
Do you remember the first time? Why Britpop nostalgia just won’t go away
31 Agosto 2025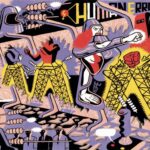
“Il mio nome è Hof soltanto Hof”
31 Agosto 2025Lo scrittore francese continua la saga cominciata con «Ci rivediamo lassù». Il nuovo romanzo sconfina nella capitale cecoslovacca del 1959, in piena guerra fredda: «È un omaggio a John le Carré, gli ho preso in prestito molte cose. Avrei voluto mandargli il libro. Faccio narrativa popolare che la sinistra snobba, invece a destra mi apprezzano»
di Stefano Montefiori
Nel Sol dell’avvenire Pierre Lemaitre porta il lettore nella Francia del 1959, dove il nostro eroe Louis Pelletier — capostipite della saga con il nome di Albert Maillard in Ci rivediamo lassù — è tornato avendo venduto la redditizia fabbrica di sapone a Beirut.
Lemaitre ha vinto il Prix Goncourt nel 2013 e da allora continua a raccontare le vicende della famiglia Pelletier scrivendo eccellenti «romanzi popolari», come la critica li chiama con ammirazione e un po’ di sussiego. Attraverso il giornalismo misto a spionaggio di François nella Praga della guerra fredda, o le piccole grandi crudeltà di Geneviève, spaventosa madre di Colette, Lemaitre dipinge con maestria il periodo delle Trente Glorieuses, l’espressione che indica i trent’anni di boom economico del Dopoguerra. Il s ol dell’avvenire (Mondadori) è il terzo romanzo della serie, e da questa ambiziosa struttura narrativa comincia la conversazione de «la Lettura» con il settantaquattrenne autore francese.
Una delle ragioni del successo dei suoi libri è l’ampio respiro, l’opera concepita come l’affresco di un secolo. Quando ha avuto l’idea?
«Dopo avere vinto il Goncourt con Ci rivediamo lassù (grande bestseller internazionale adattato anche al cinema, ndr) ho avuto voglia di continuare con i miei personaggi, ma non ho confessato l’ambizione di creare una saga neanche a me stesso. Uno scrittore mio caro amico mi disse: “Guarda, non funziona mai, sogniamo tutti di realizzare delle cose così, gigantesche, ma poi si lascia sempre perdere”. Allora mi sono limitato a scrivere il secondo romanzo, poi il terzo… E non mi sono fermato. Adesso da voi in Italia esce il sesto (Il sol dell’avvenire, appunto, ndr), tra qualche mese in Francia siamo già al settimo».
Si considera soddisfatto del lavoro compiuto?
«Non oso dire di esserne orgoglioso, ma contento sì. Di solito i lettori si stancano dei seguiti, ma a me sembra che l’interesse per i Pelletier sia intatto. E nutro il sogno che in futuro qualcuno capiti su Ci rivediamo lassù, e scopra poi che i personaggi vivono ancora in altri libri, con lo stesso entusiasmo con il quale io ho scoperto che esistevano altre avventure dopo I tre moschettieri».
Lei è un autore molto prolifico, come fa a mantenere il ritmo?
«In realtà i veri autori prolifici sono altri, quelli che pubblicano un romanzo all’anno. Io invece mi limito a uno ogni 18 mesi. La mia fortuna è che detesto la prima stesura, quindi lavoro moltissimo per riscrivere e riscrivere il testo finché il risultato mi sembra accettabile. Così finisco per riagguantare i colleghi, ma a prezzo di enorme fatica».
Qual è il ruolo di «Ci rivediamo lassù» nella sua vita di scrittore?
«Il successo di quel primo romanzo della saga è stato allo stesso tempo un aiuto e un handicap. Un aiuto, perché è una specie di modello narrativo per me, dentro ci sono lo humour, la tragedia, il dramma, il melodramma, l’amore, la vendetta. Ho l’impressione di avere messo il piede nel punto giusto, come si dice di un atleta che fa il salto il lungo. L’handicap è che spesso mi sono detto: “Non riuscirò mai a ripetermi a quel livello”. Però poi ho scritto Il gran mondo, il quarto libro della serie, che mi è sembrato il migliore di tutti. Ho visto che era possibile migliorare, che avevo ancora dei margini di progresso nella scrittura».
Quale posto occupa, nell’opera, «Il sol dell’avvenire» che esce in questi giorni in Italia?
«È il terzo della tetralogia sulle Trente Glorieuses (dopo la trilogia sulle due guerre, ndr). È un romanzo cerniera perché ha per tema di fondo la guerra fredda e preannuncia la fine di un’epoca, quella dello scontro Est-Ovest. Dal punto di vista dei personaggi, si sente che siamo alla fine della seconda generazione, quella dei figli di Ci rivediamo lassù. Presto lasceranno il posto ai discendenti. Chiusa la tetralogia sulle Trente Glorieuses, comincerò la terza serie, dai Settanta ai Novanta».
Questo romanzo, ambientato nel 1959, è il primo nel quale lei parla di un’epoca che ha conosciuto…
«Sì, ed è stata un’enorme difficoltà. Mi sono accorto che i miei ricordi erano sbagliati, che la memoria ha mescolato tutto. Pensavo di potermi affidare ai ricordi d’infanzia, invece il lavoro di verifica è raddoppiato».
I suoi romanzi non sono autobiografici, ma qual è comunque il rapporto tra i grandi eventi storici e il suo vissuto personale?
«Credo molto al lato inconscio del testo. Scrivo storie che non hanno niente a che fare con gli episodi della mia vita, ma non posso non vedere che ci sono temi ricorrenti: per esempio l’infanzia tradita o donne forti che sopravvivono alle avversità. Alla fine penso che un buon romanziere sia colui che scrive sempre lo stesso libro».
Il tradizionale rimprovero mosso a Modiano.
«Sì, ma è una critica pigra, perché il grande Patrick Modiano ora è arrivato all’apice della sua arte, e credo che cominci solo adesso a scrivere come sognava di fare a vent’anni. Anche Mario Vargas Llosa, per esempio, sul quale ho peraltro molte riserve, alla fine, libro dopo libro, è riuscito a dire quel che covava dentro. Un buon romanziere è qualcuno che ha tre o quattro cose da dire, e che alla fine riesce a scriverle come si deve. Per tornare alla domanda: non scrivo romanzi autobiografici, ma inevitabilmente, tra le righe, è quel che ho un po’ fatto».
Per esempio quanto alla politica. Nei suoi romanzi non ci sono mai manifesti, ma la sua sensibilità di sinistra è evidente.
«Sì, direi la visione del mondo, senz’altro, ma non faccio mai proclami. Ho due principi. Il primo, è avanzare a volto scoperto: chi legge i miei libri capisce ben presto che cosa penso del capitalismo, della religione, del neoliberismo, e così via. Il secondo principio è non fare proclami. Cerco di non assestare delle verità sul volto del lettore, che può essere in disaccordo con me, o con le scelte dei miei personaggi».
Anche per questo lei è comunque apprezzato a destra.
«Sì, per due motivi: uno buono e uno cattivo. Il primo è che appunto mi pare che i miei libri siano abbastanza aperti e non settari per poter essere amati da tutti, di destra o sinistra. Il secondo è che la destra è meno snob della sinistra. Per la critica di sinistra che io pubblichi molti romanzi è visto con grande sospetto. E che si vendono, per di più! Scrivo libri che la gente compra, che legge sui treni o in autobus, è insopportabile. La sinistra adora gli autori popolari, ma solo quando sono morti. Credo che alla fine avrò delle bellissime recensioni su “Libération” o “Les Inrockuptibles” ma bisognerà aspettare almeno una decina d’anni, e sarà mia moglie rimasta vedova a leggerle. Comunque, a parte gli scherzi, non mi lamento, la critica globalmente mi tratta bene».
Che cosa pensa del fatto che gli anni delle Trente Glorieuses siano diventati, soprattutto a destra, una sorta di Eden perduto, evocato con rimpianto?
«Non condivido questo sguardo. È stato un periodo pieno di ottimismo e di energia, certo, ma nel quale abbiamo inventato il diesel e la plastica e, in fondo, il riscaldamento climatico. Oggi comincia a farsi largo la consapevolezza che molti dei nostri problemi attuali derivano da quell’epoca, che non è poi stata così magica».
Per esempio, è allora che comincia e radicarsi la paura della bomba atomica e di una Terza guerra combattuta con le armi nucleari.
«Dopo una pausa di una trentina d’anni, durante i quali le armi atomiche sembravano obsolete e il rischio ormai superato, ora purtroppo si torna a parlarne, con le minacce di Vladimir Putin. In effetti il mio libro ha una certa risonanza con l’epoca attuale».
Nei suoi romanzi storici ci sono sempre legami con il presente.
«Sì, ma non mi monto la testa. A posteriori, si trovano sempre collegamenti. Ci sarebbero anche se scrivessi un romanzo su Nefertiti o Giulio Cesare, credo».
La parte su Praga è un omaggio a John le Carré?
«Sì, gli ho preso in prestito molte cose e lo dico nei ringraziamenti. Mi è molto dispiaciuto che Il sol dell’avvenire sia apparso appena dopo la sua morte. Avrei voluto mandargli il libro con la dedica: “Ecco, caro John, ho voluto renderle omaggio, spero che questo la divertirà”. Amo molto i romanzi di le Carré anche se, e questo non glielo avrei detto se lo avessi incontrato, certe volte sono dannatamente complicati e mi è capitato di non capirci più niente. Ma in fondo l’intreccio talvolta non è l’aspetto più importante. Io, comunque, mi sono sforzato di rendergli omaggio ma semplificando un po’ le cose».
È andato a Praga a fare ricerche per il libro, lei che detesta viaggiare?
«Sì, ho fatto uno sforzo perché non mi fido della mia memoria, come dicevo prima, e poi volevo scrivere su una città reale e non su quella che avevo visitato come turista vent’anni fa. In ogni caso la Praga degli anni Cinquanta-Sessanta non esiste più. Ma ho fatto bene ad andare perché ho incontrato alcuni intellettuali dell’epoca, oggi ottantenni, che si sono raccomandati: attenzione, Praga non era Mosca, Praga era una città allegra nonostante il comunismo, nei caffè ballavamo sulle canzoni di Paul Anka. Una città simile al temperamento dei suoi abitanti, divertente, autoironico e, insieme, tragico».
Un altro tema classico dei suoi romanzi è la famiglia, la base della saga.
«La famiglia Pelletier che è piena di problemi, certo. Una volta ho letto una critica, credo sulla stampa anglosassone, che la definiva una famiglia disfunzionale. Ho avuto voglia di telefonare al giornalista per chiedergli se la sua invece fosse una famiglia funzionale. È ovvio, tutte le famiglie sono disfunzionali. Le famiglie normali non esistono: siamo tutti nevrotici perché le famiglie sono fabbriche di nevrosi, lo sappiamo da Sigmund Freud ma in fondo anche dalle tragedie greche».
Tra i suoi personaggi, ce n’è uno che preferisce?
«Dovrei comportarmi come un buon padre di famiglia, appunto, e dire che non ho preferenze, ma non è vero. Ho un affetto particolare per Louis Pelletier, che mi ha dato tutto, e che in questo romanzo tratto, i lettori se ne accorgeranno, con una cura speciale».





