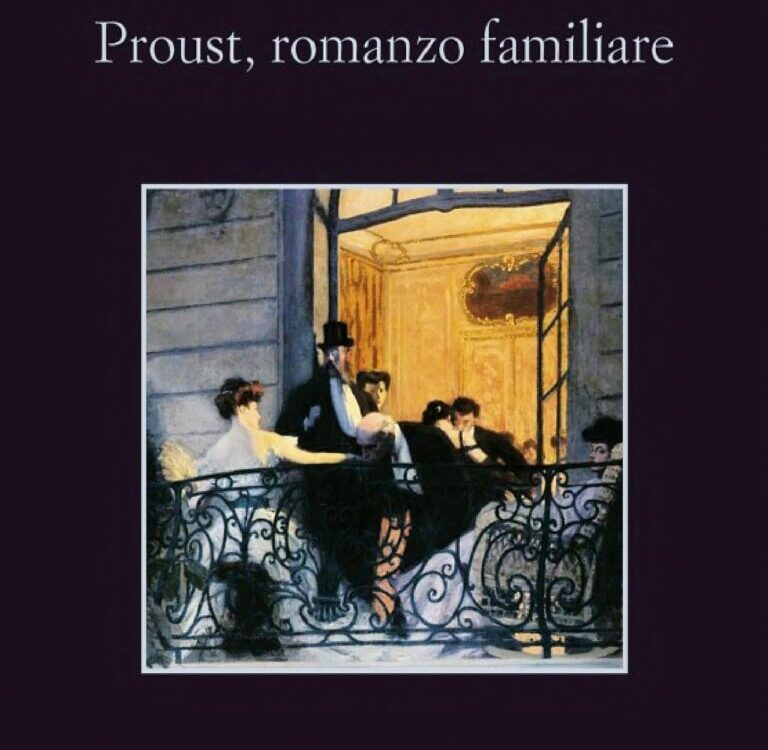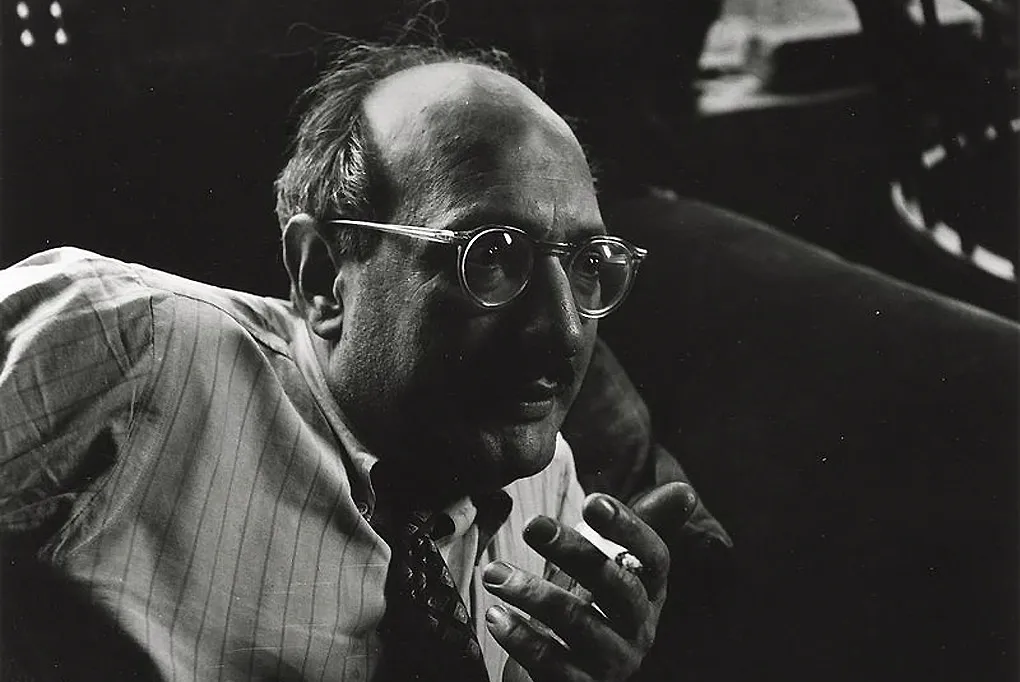
ROTHKO prima e dopo Rothko
8 Ottobre 2023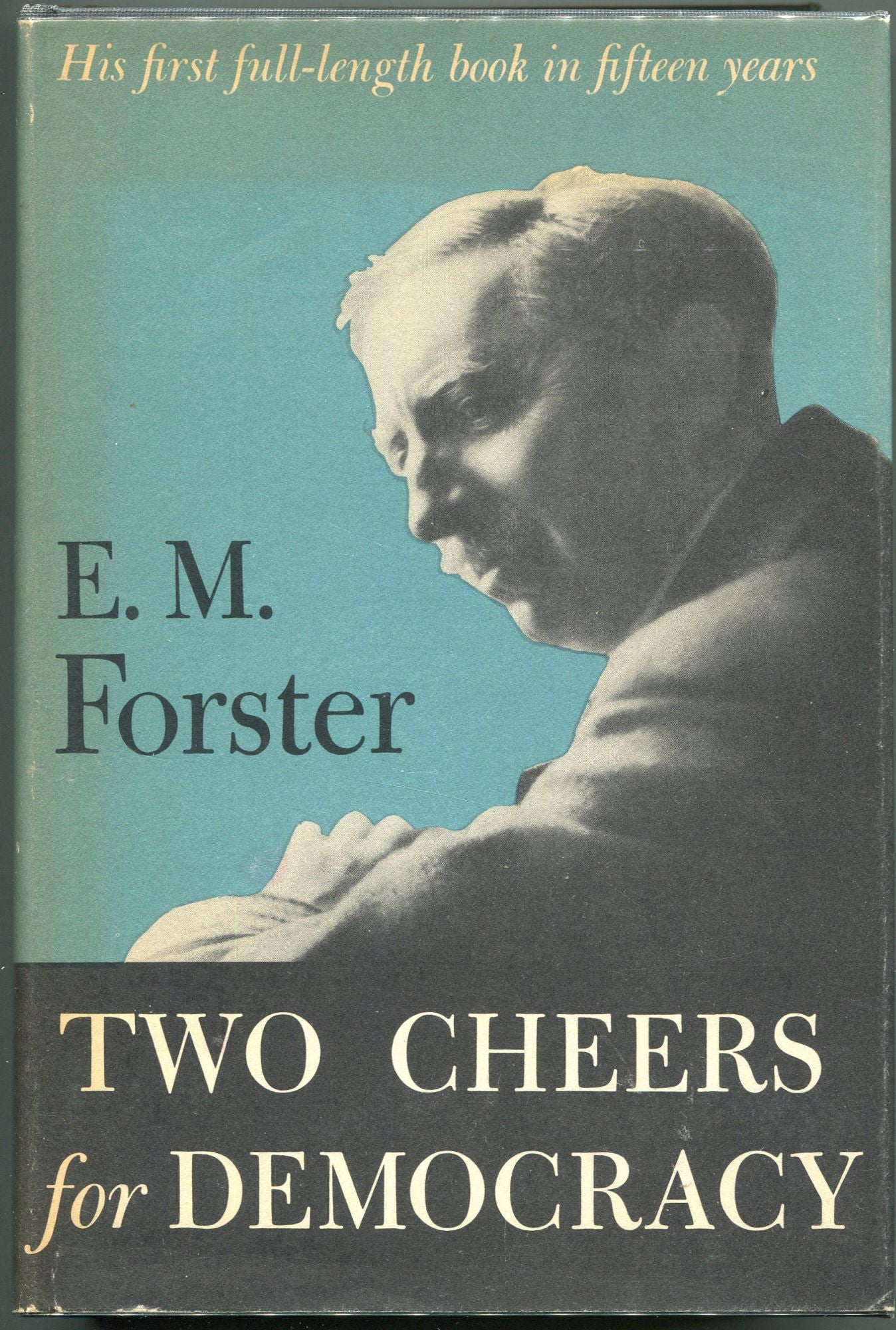
elogio della lettura (e del nuovo umanesimo)
8 Ottobre 2023Non è facile, per il lettore moderno, trovare la chiave adatta per addentrarsi nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, unica opera superstite dell’infaticabile poligrafo di età flavia di cui ricorre quest’anno il bimillenario della nascita; e non perché essa sia davvero «un insieme di aneddoti e racconti da comare», come affermava Alexandre Koyré e come talvolta ancora si ripete, quanto per l’inaudita escursione dei temi trattati in quest’enciclopedia «vasta, erudita, e non meno varia della natura stessa», secondo il giudizio di Plinio il Giovane nell’epistola a Bebio Macro (III, 5).
Se la lettura integrale della Naturalis Historia – per la quale il lettore italiano dispone di due edizioni degli anni ottanta, quella promossa dal «Comitato Pliniano» di Como e quella dei «Millenni» Einaudi coordinata da Gian Biagio Conte – non potrà che rimanere appannaggio di una minoranza persino fra i classicisti, decisamente più attraente (anche per il pubblico non specialista) è la possibilità di esplorare, attraverso incursioni di carattere monografico, questa o quella provincia del catalogo globale di Plinio.
È su questo tracciato, già percorso in Italia per i libri zoologici (VIII-XI) e per quelli sulla storia delle arti antiche (XXXIV-XXXVI), che s’inserisce la recente edizione del settimo libro della Naturalis Historia: Plinio il Vecchio, L’umano (Storia naturale, Libro VII), con testo latino accompagnato da traduzione e note di Guglielmo Monetti (Marsilio «Letteratura universale», pp. 248, € 17,00).
L’opera attinge a venticinque fonti latine, quarantanove greche, e riporta «settecentoquarantasette dati, notizie, osservazioni»: l’indice antico, che Monetti utilmente estrapola dal primo libro, è già rivelatore dell’ampiezza della trattazione pliniana de homine, e al contempo del suo sconcertante disordine tassonomico. Il libro, che intende offrire una summa della vita umana dalla culla alla tomba, permette sì di intravedere una struttura basata su ampie campiture tematiche – il catalogo delle popolazioni esotiche, il concepimento e il parto, le caratteristiche fisiche e morali dell’uomo, le malattie e la morte –, ma procede di fatto con l’accavallarsi di schede disparate, tanto da autorizzare l’ipotesi che l’affollatissima rassegna finale di inventori sia un’aggiunta seriore ed estranea al progetto originale.
La visione dell’uomo di Plinio – e il suo stesso enciclopedismo – si esprimono insomma nella pulviscolarità di un catalogo più vicino alla letteratura paradossografica che alla scienza aristotelica e teofrastea; ma più che scandalizzarsi per «la crudele mancanza di metodo» – così Jean Beaujeu – di un autore che, secondo il racconto del nipote, dettava le sue pagine durante l’ora del massaggio o i viaggi in carrozza e considerava una perdita di tempo farsi leggere due volte le stesse righe di un libro, converrà provare a riconnettere i dettagli per tracciare l’identikit dell’uomo pliniano.
Come annotava Mario Vegetti, grande evidenza ha nel nostro libro la «continuità inevitabile fra l’umano, il potere e la sua inevitabile vocazione alla tirannia e al massacro». La più fragile e superba delle creature, che può morire soffocata da un acino d’uva (così il poeta Anacreonte), nasce dunque per essere carnifex, e la storia di Roma sembra stare lì a dimostrarlo, non solo con i recenti esempi di Caligola e Nerone, ma anche con quello di Silla, unico uomo ad aver ricevuto l’epiteto di Felix «evidentemente per aver versato il sangue dei cittadini e mosso guerra alla patria». Un’antropologia del potere pessimistica, dunque, certo influenzata da topoi filosofici e storiografici, ma anche dall’esperienza amara del Plinio militare e governatore.
A colpire il filologo è poi l’attenzione pliniana per la scrittura, presentata come tratto distintivo dell’identità di specie: l’alfabeto ionico è infatti uno dei soli tre elementi di universale consenso di ogni popolo della Terra, insieme all’uso dei barberi e a quello degli orologi. Storie più o meno note di libri e biblioteche pullulano ovunque nelle pagine pliniane: così apprendiamo che Varrone era l’unico vivente ritratto nella prima biblioteca di Roma, fondata da Asinio Pollione nell’atrium Libertatis, e che esisteva una copia dell’Iliade scritta in caratteri così minuti da poter essere contenuta in un guscio di noce.
Talvolta dietro l’aneddoto curioso si scorge però il culto per la parola scritta dello stesso Plinio, il quale – ricorda ancora il nipote – era solito affermare che nessun libro è tanto cattivo da non poter essere utile in qualcosa: così, particolarmente appropriata appare la decisione di Alessandro Magno di custodire in un costoso scrigno sottratto al re Dario i poemi omerici, pretiosissimum humani animi opus.
Quella di animus, anima, animans e animal è una costellazione lessicale particolarmente rivelatrice della concezione pliniana dell’uomo, che è «pessimistica e umanitaristica (ma non umanistica)», come ben scrive Monetti. Benché un antropocentrismo vagamente stoicheggiante faccia la sua rituale comparsa all’inizio del libro, infatti, nulla se non la vanità autorizza a distinguere l’uomo dagli altri animali, e un Plinio materialista e ‘lucreziano’ liquida come invenzione ogni ipotesi di vita dopo la morte.
Nessuna tentazione essenzialistica: l’essere umano è una somma di parti e la sua vita un susseguirsi di dolori e circostanze dettate dal caso, come dimostrano infiniti esempi di mutevolezza della sorte, fra i quali spicca uno degli inserti più notevoli del libro: la sezione degli Adversa divi Augusti, vera e propria palinodia delle Res gestae.
Anche l’antropologia si risolve insomma per Plinio in un inventario dell’umano; e così ai lettori di questo libro VII resterà da godersi, smagliante Wunderkammer etnografica, tutto un brulicare di blemmi, sciapodi e pigmei che, per il tramite della letteratura parabiblica, si reincarneranno nell’Oriente fantastico della Lettera del prete Gianni – e nel Baudolino di Umberto Eco.