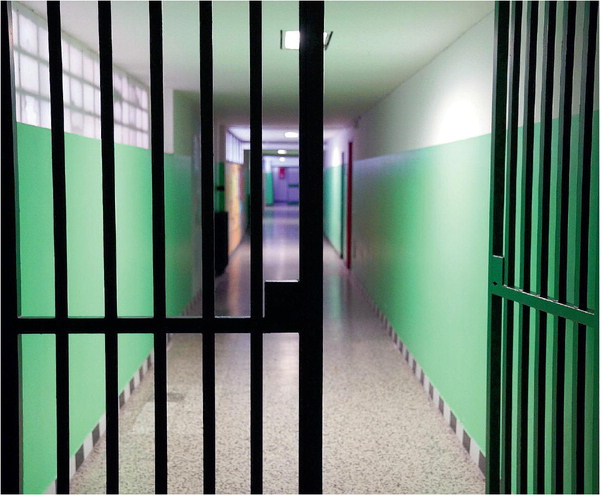L’omicidio Cecchettin e i deliri della politica. Difendere il modello occidentale è l’unico modo per non chiudere gli occhi sul dramma dei femminicidi
21 Novembre 2023
Non esistono i maschi progressisti
21 Novembre 2023Mentre aspettavamo la conferma di ciò che sapevamo già, perché lo sapevamo già, lo sappiamo tutte e lo sappiamo sempre, sono arrivate decine di racconti. Erano racconti di donne che hanno superato violenza e abusi, con aiuto o senza, donne che furono ragazze oltraggiate da fidanzati, oppure donne che sono state madri picchiate davanti ai figli, oppure studentesse apostrofate, annichilite da compagni e professori. E ogni storia era così composta e nitida nel suo emergere in tutto il suo orrore, nella paura del momento, nell’epifania del tornare a vivere dopo averla superata, che erano perfino belle tutte quelle voci che costruivano una storia intera, tanto intera e così completa, così trasversale per le latitudini e le età, così riconoscibile che a portarla in un libro e leggerla in una classe di ragazzini si farebbe una grande cosa.
Perché poi l’educazione sentimentale che a gran voce chiediamo tutti e di cui il governo se ne frega (ma non per dimenticanza, per precisa scelta di inibizione: perché poi a parlare d’amore ci finisce dentro l’amore e il genere scompare e questo governo teme grandemente la scomparsa dei limiti e l’emergere della parità. Con la parità non ci fai le gerarchie, con le gerarchie ci comandi) è facile, è come la storia: dici sai sono successe queste cose, ma non a una donna sotto un regime, no, proprio alla tua vicina di casa.
I ragazzini imparano presto: siamo noi che abbiamo bisogno di tempo per imparare. Per esempio abbiamo bisogno di molti twitt e qualche articolo di giornale per imparare che non basta più scrivere (e leggere) su twitter e sui giornali (nemmeno questo) per prendere una voce forte in risposta al femminicidio di Giulia Cecchettin, ma che bisogna andare il 25 in piazza. Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, da sempre articolata da tante associazioni in varie piazze d’Italia, anche stavolta, ancora una volta, contiene tante cose, e contiene anche quella porzione di rabbia e di dolore di cui non riusciamo a liberarci, e che deve per forza diventare altro: un grido, dei passi, delle voci, mani alzate.
Non basta scrivere e leggere, bisogna andare, ci vogliono i corpi, perché è sul corpo che si abbatte la violenza. Bisogna riempire quella piazza e fare crollare il paese, davvero, perché così, dal punto in cui stiamo ora non è che si possa fare molto, bisogna buttare tutto a terra e ricostruire. Ricostruire i centri antiviolenza, rifinanziarli, darne notizia, ricostruire l’educazione nelle mura delle scuole e in quella delle case. Pareggiare i salari, abbattere le disuguaglianze tra nord e sud, incentivare il lavoro femminile, sollevare le famiglie dall’accudimento che ricade solo sulle donne.
Bisogna mettersi spalla a spalla fisicamente e camminare assieme, come quelle donne islandesi che a noi paiono un miraggio e ci fanno pure un poco invidia.
Mi chiedevano: servirà? Sì. Serve per due motivi. Uno ce lo spiegano gli attivisti ogni volta che si espongono con i loro corpi per sostenere le battaglie, gli studenti, i ragazzi di Ultima Generazione: i corpi danno fastidio, ci vogliono altrove, divise, sole, per controllarci meglio.
E poi serve perché serve tornare a parlare quel linguaggio comune che è maturato in quei racconti, e che ci rende sorelle, quel linguaggio che ciascuna di noi conosce, e che va passato come testimone alle bambine: «Stringiti alla comunità delle donne» mi disse una volta a Milano Luisa Muraro, «perché quando sarai vecchia saranno loro che ti salveranno, non gli uomini». Me lo disse perché mi vide ingenua, perché tante cose non le sapevo: io stavo imparando.
Alcune di noi sanno perché hanno subito e visto, e se non hanno capito razionalmente in quel momento, però hanno avuto paura e quella paura era già un sapere. Ma altre lo hanno imparato tardi, alcune hanno avuto ambienti casalinghi in cui c’era parità e rispetto, e lo hanno scoperto piano che invece fuori il mondo era così, all’università, sul lavoro. E allora hanno dovuto imparare.
Si può ancora imparare. Gli uomini possono imparare. Lo dobbiamo a Elena Cecchettin che ce lo ha insegnato in questi giorni e ce lo continua a insegnare. Ma per farlo serve la comunità, e la comunità si fa in piazza: il 25 a Roma e a Messina. La comunità si fa così: che poiché non tutte potranno venire, perché qualcuna lavorerà, e qualcuna sarà incastrata in quello stesso meccanismo per cui dovrebbe venire, e qualcun’altra non avrà i soldi per arrivare e Roma e a Messina (anche se ci sono gli autobus gratis una giornata fuori costa, se parti da un paesino lontano ti costa) chi ci può andare, ci va anche per le altre. Anche per questo chi può, deve – ma non è un «deve» categorico, esterno: è più come quando dalla tragedia fiorisce un senso di speranza.