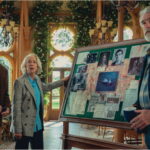Ranuccio Bianchi Bandinelli Paparoni, 1900-1975, nobil casata senese, è onorato con molti serti di alloro: biografie e film, mostre, celebrazioni e convegni, associazioni eponime. La sua vita è in due atti con intermezzo. Nel primo tempo c’è un giovin signore di provincia appassionato agli Etruschi, incerto tra la sorte del possidente o il mestiere di archeologo, che poi riuscì a fare come professore peregrino tra Cagliari, Pisa, Firenze, Roma e in Olanda, al posto di Doro Levi, eterno rivale, «razza strana, sebbene non nemica». Nel 1935 fonda «La Critica d’Arte» per innovare la disciplina nel crocianesimo imperante, con il patrocinio dei Gentile padre e figlio. La prima serie dura solo un lustro per le turbolenze di triumviri direttori: lui con Carlo Ludovico Ragghianti e Roberto Longhi. Bianchi Bandinelli si dichiarerà a posteriori «antifascista generico», un dissenso con la sordina: giura fedeltà e serve come cicerone prezzolato per Hitler e Mussolini, in un famigerato giro turistico del 1938. Era di gentile aspetto, provvisto dei blasoni, un soggetto affidabile per il Regime. Tanto è vero che Giuseppe Bottai e Galeazzo Ciano, ministri dell’Educazione e degli Esteri, pensano di affidargli la Scuola Archeologica di Atene, un ruolo rilevante per camerati esemplari come Carlo Anti, «archeologo di fama, fascista tutto di un pezzo», e Guido Libertini, obbediente al Duce dalla prim’ora.
Gli anni della guerra, «nel mezzo del cammin», sono un intervallo con metamorfosi. Il tempo andato è consegnato alle memorie intitolate Dal diario di un “borghese”, pagine di vita scritta, che servono anche a raffigurarsi per la posterità (il “borghese” del titolo è una singolare figura retorica, essendo lui di aristocratico lignaggio e paladino del proletariato per elezione).
La palinodia inizia con la cancellazione dalle accademie contro le leggi raziali e le dimissioni dall’Ateneo fiorentino per opposizione alla Repubblica di Salò, nasconde i fuggitivi nella villa chiantigiana, è preso in ostaggio dopo l’assassinio di Giovanni Gentile, si iscrive al Pci e inizia il secondo atto: il “Conte Rosso”. Ha solidi e durevoli convincimenti: «Il mio passaggio al comunismo fu un moto di rigetto verso un sistema borghese che si rivelava inumano… il comunismo non può essere soltanto una teoria economica; deve essere una nuova morale, un’etica collettiva in cui l’individuo trova il suo compimento nel bene comune». È in relazione con il gotha cosmopolita dell’intellighenzia, Thomas Mann trova «eccitante e divertente» il contrasto tra la sua aria aristocratica e le convinzioni professate: «tanto di cappello al comunismo…», gli scrive per celia.
Diventa un intellettuale organico e autorevole con pensieri, parole e opere: la Piazza Rossa di Mosca gli fa venire in mente l’Atene di Pericle, scrive di politica e cultura nei giornali di Partito e presiede l’Istituto Gramsci, organizza imprese di divulgazione: «educare il popolo significa offrire a ciascuno gli strumenti per interpretare il mondo e diventare protagonista del proprio destino». Ogni tanto fa parte dell’establishment della Repubblica ma si dimette per dissensi e sprezzatura: Direttore delle Antichità e Belle Arti per la ricostruzione post-bellica e le restituzioni; presidente dell’Icom; accademico dei Lincei e delle Scienze sovietiche; nel 1964 abbandona l’Università dieci anni prima della scadenza; fonda riviste-manifesto animate dal marxismo, dalla polemica e dalla dialettica, che come tutte le riviste-manifesto hanno vita breve: «Società» (con Cesare Luporini) e «Dialoghi di archeologia». Si impegna in pubblicazioni sulle civiltà antiche: enciclopedie stampate a tempi record, libri e collane, traduzioni di saggi dall’Oltrecortina. È in prima linea per il patrimonio italiano, come per Firenze bombardata, questionando con Bernard Berenson se rifare tutto come era e dove era, o gli orti dentro le mura di Siena scampati al cemento grazie a lui.
Per alcuni studenti appare come una folgore dell’intelletto nelle aule cineree della Sapienza di Roma. Per loro è pontefice massimo e poi venerabile Lare, insieme fanno la rivoluzione copernicana dell’archeologia italiana, ribaltando sistemi concettuali fino ad allora universalmente accettati con nuove parole chiave: contesto, storia e società comprese le classi subalterne, originalità dell’arte romana, integrazione con la storia dell’arte, immagini come mezzo di comunicazione.
Nuovi allori saranno aggiunti quest’anno, mezzo secolo dopo la sua ultima data fatale.