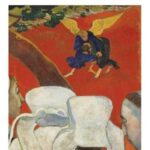
Giacobbe lotta con l’Avversario e alla fine conosce se stesso
2 Giugno 2024
ARTE e fascismo, il mart esplora il binomio
2 Giugno 2024Non ricordo se nel libro dedicato da Michel Pastoureau ai vari significati che il colore nero ha assunto nella storia della civiltà umana vi fosse qualcosa di simile all’idea espressa in più di un’occasione da Franco Maria Ricci – il geniale editore e grafico al quale Genova dedica fino al 30 di giugno una fascinosa mostra, Franco Maria Ricci. L’Opera al nero – ovvero che il nero sia il colore dei colori, quello che tutti li contiene e perciò anche il più adatto a esaltarli nelle immagini che vi vengono impresse sopra, un po’ come le figure rosse dei vasi antichi ricevono molta della loro saliente eleganza proprio dall’ingobbio scuro sui cui sono dipinte. Una stessa maniera d’esaltare e impreziosire gli oggetti ha ispirato anche il curatore della mostra, Pietro Mercogliano, nel modellare, insieme a Maddalena Casalis, quasi fossero di docile cera, gli spazi della Loggia degli Abati del Palazzo Ducale, fino a ottenere che sul morbido velluto delle luci, sulla raffinatezza dei toni delle pareti l’opera editoriale di Ricci si stagliasse con quella nitida presenza che l’ha da sempre contraddistinta.
Dicevamo che una simile interpretazione del nero non ebbe precedenti; ma ci si dovrebbe forse ricredere, ricordando, come fa il curatore, la nigredo alchemica, oppure ancora la mélas cholé, l’atrabile da cui per Aristotele il genio traeva i suoi pensieri più lucenti. E, dal momento che si parla di un editore, non si può dimenticare come anche quella dell’inchiostro sia una nerezza feconda e come il carattere tipografico sulla pagina bianca, sciolto da ogni nesso, possa farsi puro segno e ispirare perfino ghiribizzi stravaganti del genere di quelli inventati da Antonio Basoli nel suo Alfabeto pittorico. A Ricci per scoprire le possibilità immaginifiche dalla semplice impressione di un alfabeto su carta fu sufficiente un testo assai meno eccentrico di quello del Basoli: il Manuale tipografico di Giambattista Bodoni, la cui ristampa uscì nel 1965 accompagnato da questa nota, che il catalogo (con contributi di Laura Casalis, P. Mercogliano e F. M. Ricci, pp. 88, € 28,00) riporta: «Credo che Bodoni vada riscoperto con l’occhio di oggi, reso attento e smaliziato dalle più recenti esperienze visuali. Anche la Pop Art ha in comune con il neoclassico Bodoni un’idea, il desiderio del segno di superare la sua funzione originaria, di liberarsi dal normale contesto per vivere in una dimensione autonoma e fantastica che solo la cultura rende possibile».
Nell’antico troviamo il moderno a volte anche il futuro, è sufficiente ruotarlo, come un prisma, cambiarne l’angolazione. Ce lo mostrano alcuni incantevoli disegni di cucine: oggetti di confort borghese, realizzati da Ricci ispirandosi ora all’art nouveau di Majorelle, ora al neogotico di Strawberry Hill, ora al gusto Luigi XV, sempre con la libertà d’un capriccio settecentesco. Al contrario di quanto professarono i romantici, e più tardi, i surrealisti, loro indisciplinati discepoli, la fantasia non era per lui dérèglement de tous les sens, ma «sintesi di sensibilità e cultura». Non uno dei lavori che ammiriamo lungo le sale smentisce tale equilibrio di misura e libertà, ancor più evidente nella stanza in cui alle tavole dell’Encyclopédie (anche questa, come il manuale di Bodoni, ripubblicata dell’editore in quasi anastatica) sono accostate quelle del Codex Seraphinianus, l’Enciclopedia dell’impossibile di Serafini: l’una che tende l’assurdo verso la razionalità, l’altra che porterebbe all’assurdo, se appena volessimo staccare e ingrandire un dettaglio o abolire una didascalia. Così anche gli oggetti d’arte, fotografati nei particolari e osservati dalle angolazioni eccentriche d’un Savinio, d’un Manganelli o d’un Arbasino, assumevano negli articoli di «FMR», la rivista cui è dedicato l’ultimo degli ambienti, una risonanza insolita e nuova, «something of rich and strange» come suonavano i versi di Shakespeare che avrebbero potuto costituirne l’esergo.
Il pannello iniziale – dove come negli altri la storia di Ricci è narrata attraverso le sue parole – ci svela quale parte avesse avuto nella sua visione lo stupore: «L’Ottocento dei nonni mi affascinava poco, e con la fantasia seguivo i Ricci più antichi, quelli che si aggiravano per i mari di Levante, ambasciatori a Tiro e a Cipro. Da bambino sognavo la Cina quando mi raccontavano di un antenato, Padre Matteo Ricci, che nel Seicento la visitò, amò, e scrisse». «I Segni dell’uomo», la «Biblioteca di Babele», collana diretta da Borges, «FMR», le collezioni d’arte e lo stesso labirinto della Masone parlano tutti di questa curiosità insaziabile e tortuosa, la stessa di Sinbad per il gran mare incognito o dei cavalieri erranti nei deserti, che, come diceva Borges, sono i più grandi fra i labirinti. Gli ambienti del Palazzo Ducale si sono aperti alla grazia molteplice di questi racconti, geometrici e ondulati come le tracce del vento sulle dune di sabbia. Ma dietro l’impeccabile editore, che dette stabile e concreta forma ai suoi sogni, un po’ sempre rimase qualcosa della freschezza del fanciullo meravigliato.





