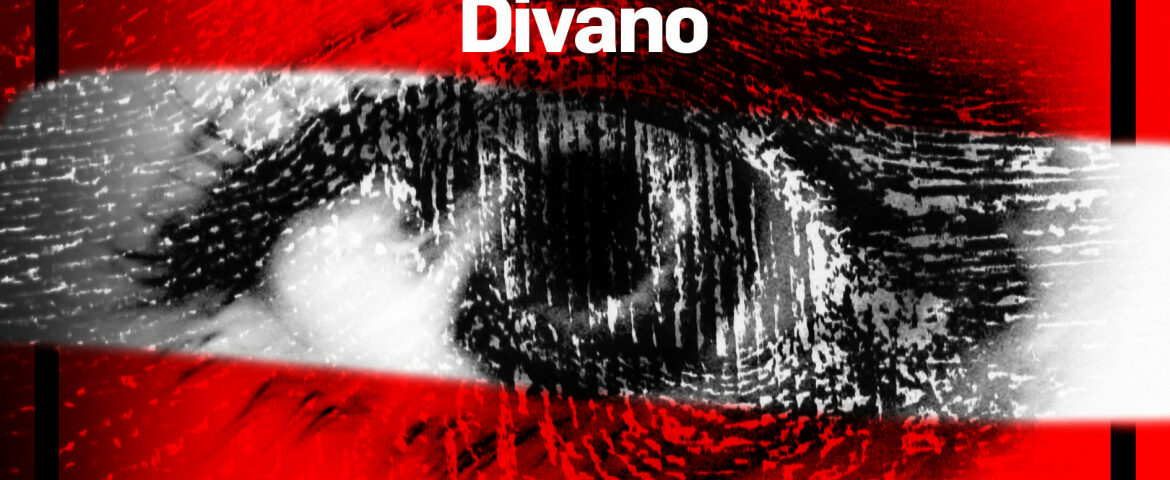Il malessere dei giovani, guaio globale La prima causa: carenza di relazioni
16 Maggio 2025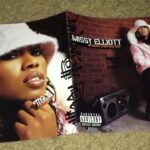
Missy Elliott – Work It
16 Maggio 2025Il ripudio della guerra «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» dovrebbe costituire un convincimento radicato nei cittadini italiani, un presupposto che dovrebbe essere condiviso dalle generazioni (ben cinque?) educate dalla scuola e dalle istituzioni della Repubblica quale risultato d’una crescita civile maturata nel corso degli ultimi ottanta anni. Gli italiani dovrebbero sentire il ripudio della guerra come un moto spontaneo della loro civica identità: non solo rifiutare ogni guerra in ogni caso, ma agire attivamente di conseguenza, darsi governi che fattivamente contrastino le soluzioni armate ovunque vengano perseguite.
Viviamo da anni in un diffondersi, dal Baltico al Mar Rosso, di guerre che massacrano gli inermi e radono al suolo città, ma i cittadini italiani non denunciano in nome dell’undicesimo dei «principi fondamentali» della Costituzione il loro governo, impegnato a inviare armi, dunque a prender parte attiva nell’alimentare gli eccidi. Un governo che quelle guerre sostiene, approvandole quali mezzi adeguati alla «risoluzione delle controversie internazionali» in atto.
Pure, nel 1948, le parole della Carta contro la guerra furono dettate nella loro sobria nettezza per affermare un impegno inderogabile, dopo cent’anni di guerre sofferte dagli italiani, da una generazione all’altra, milioni di morti, dal Risorgimento al secondo conflitto mondiale siglato nel 1945 dall’arma atomica.
La redazione consiglia:
È doveroso constatare che negli anni della Repubblica, il ricorso alle testimonianze, le documentazioni tratte dagli archivi, le opere letterarie e di poesia, le figure di quanti quel susseguirsi di guerre del Regno d’Italia, in Africa e in Europa, contrastarono e nelle quali troppi persero la vita, letterati ed analfabeti e, insomma, le ricerche storiche (non senza obiezioni) hanno della guerra mostrato gli orrori e denunciato le retoriche che li nascondono.
Dicevo che viviamo giorni, settimane, e mesi e anni di guerre ormai, ma poche e quasi relegate dai grandi circuiti della stampa e della comunicazione, in un ‘a parte’, come si dice a teatro, sono le voci dei cittadini italiani che si levano nel nome dell’articolo 11. È necessario constatare che, nella loro stragrande maggioranza, gli italiani non ritengono di dover far sentire chiara e forte la loro «repulsa della guerra».
Nemmeno gli appelli dell’autorità cattolica romana paiono animarli ad una protesta. Nemmeno il timore indotto dalla stretta contiguità, geografica e strategica, delle devastanti operazioni belliche, così vicine ai confini del nostro paese. Nemmeno il fatto che il nostro territorio nazionale ospita una rete di basi militari che costituiscono un inevitabile bersaglio da colpire a seconda di come volgano i casi delle ostilità e il loro intensificarsi.
Mi chiedo se a curare (non oso dire a guarire) tanta irresponsabile indifferenza dei governanti e dei governati italiani non gioverebbe la lettura di quelle testimonianze letterarie e storiche che qui sopra richiamavo. Una poco nota e perfetta è giunta in libreria in questi giorni. Si tratta di pagine pubblicate nel 1922 negli Stati Uniti dall’editore Macmillan con il titolo The Unbidden Guest (L’ospite non invitato) dovute a Silvio Villa (1882-1934), ingegnere torinese trasferitosi a New York, che nel 1916, entrata l’Italia in guerra, torna in patria per partire volontario verso il fronte. Avvalendosi della meticolosa e impeccabile cura di Franco Corleone (e dei contributi di Manuele Gianfrancesco, Andrea Zannini e Guido Crainz) le Edizioni Menabò di Ortona, con il titolo Sulla linea del fronte. Episodi della Grande Guerra, pubblicano cinque brevi scritti di Villa di straordinaria energia evocativa e di altissima tempra morale.
Il primo, Claudio Graziani. Un episodio di guerra, si imprime come un apologo che, avvinto il lettore, lo costringe a meditare sulla sconvolgente disumanità che la guerra, in ogni suo atto, senza remissione perpetra. Un racconto esemplare d’un episodio del 1918, della ‘grande guerra’, che induce a convenire, ci dice Crainz con le parole di Sigmund Freud, come «mai un evento storico abbia distrutto in tale misura il così prezioso patrimonio dell’umanità».