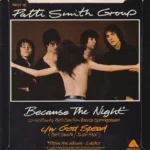Il nome è così antico da perdersi nel mito.Il significato così mutevole da renderne impossibile una definizione univoca. Stiamo parlando del “museo”, di cui lo stesso organo di riferimento, l’Icom (International Council of Museums) ha dovuto più volte aggiornare lo statuto, estendendo il dominio sino all’immateriale e all’intangibile e allargardone i compiti dalla mera conservazione alla comunicazione e addirittura al “diletto” e al “piacere”.
«Accessibile, inclusivo e sostenibile», si legge infatti nell’ultima dichiarazione del 2022, il museo «opera e comunica eticamente e professionalmente con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze».
Anche se a molti ancora appaiono ancora solo come depositi di un passato da ammirare e preservare in un’aura di esclusiva intangibilità, i musei in realtà non sono mai state entità statiche. Per chi ne percorra la storia, risulta anzi evidente come essi siano andati incontro a una serie di mutazioni che hanno riguardato sia la loro funzione che il loro assetto fisico. Per più un secolo l’ Altes Museum di Berlino ha fissato la tipologia del museo illuminista, replicandosi in infinite versioni, dall’Europa all’America, in tutto il mondo occidentale. In forma di tempio, dotato di corte e di un’ampia scalinata d’accesso, sintetizzava il canone dell’identità nazionale, prezioso scrigno dei tesori del popolo. Fu solo nel 1970 che il Centre Pompidou ne mandò in frantumi l’icona. Nel plateau Beaubourg a Parigi l’esplosione fu così forte da suscitare l’immediato rigetto: ci si accorse solo dopo che, dietro il sacrilegio di quella “macchina” aliena , si affollavano le più profonde pulsioni di avanguardie culturali che predicavano l’avvento di una società aperta, dal “museo senza muri” di Malraux al Fun Palace di Cedric Price, lucida profezia del passaggio dalla società industriale a quella post-industriale: una sorta di centro sociale anarchico e libertario dove la cultura e l’arte si facevano, non si esponevano.
Rispetto a tale radicalità , persino il “cigno” di titanio di Frank Gehry a Bilbao sembrò piuttosto una regressione commerciale che non un avanzamento: il trionfo di quello che, all’alba del nuovo millennio, segnò la stagione dell’ “ipermuseo”, architetture roboanti che andavano incontro alle esigenze di un pubblico ormai globale, tanto smaliziato di non accontentarsi più del solo passato, ma anche tanto ammaliato dall’esasperata ricerca del nuovo da alimentare la corsa di quelle che allora amavano definirsi “archi-star”. Il Guggenheim di Bilbao, il Louvre di Abu Dhabi , il Museo ebraico di Berlino, il Maxxi di Roma, la Fondation Vuitton a Parigi sono oggi l’evidenza fisica dei tanti “musei possibili” di cui si occupa questo libro che raccoglie le ricerche dei dieci autori (architetti, storici, critici, curatori) che hanno condiviso esperienze e riflessioni su questo potente indicatore dei cambiamenti della società globale.
Prima di tutti il fenomeno del museo in franchising, che legittimò l’equiparazione dei grandi brand museali a quelli della moda e del consumo: la casa-madre che apre filiali negli hot spot del nuovo turismo, dopo il Guggenheim, ha interessato il Louvre che ad Abu Dhabi ha fatto da apripista alla replica mediorientale dell’Isola dei Musei di Berlino.
I cambiamenti non riguardano però solo i contenitori, ma anche i contenuti e i format d’esposizione: la “democrazia culturale” impone il punto di vista dell’arte globale, di cui il nostro passato è solo una piccola parte. La Convenzione di Faro del 2011 indica come compito principale del museo di costruire le nuove identità delle comunità, che sono a loro volta chiamate a svolgere un ruolo attivo di negoziazione e di creazione di significati più ampi e rispondenti alle ambizioni e ai bisogni delle popolazioni. I curatori e i direttori perdono lo scettro del comando, sono costretti a ripensare il museo, ad organizzarlo e ridisegnarlo sotto i nuovi input. Al Met di New York la presentazione dell’arte classica si deve accompagnare a quella che prima veniva definita “arte primitiva”, allargando la trama della storia in senso geopolitico: accanto a una statua greca, una scultura africana, ad esempio, o un totem indiano. La Tate Modern di Londra ha più volte rifatto l’allestimento delle collezioni, invertendo la proporzione tra opere di artisti ed artiste e aprendosi alle tematiche del gender che costringono a rifare il catalogo della storia dell’arte. Black Lives Matter, Fridays for Future, metoo, il fluid gender, le rivendicazioni del pensiero postcoloniale, sono entrati a piede teso nel recinto del museo, dopo averlo espugnato a colpi di manifestazioni, proteste, micidiali elaborazioni critiche. Hanno preteso di entrare nella logica di gestione e in quella dei finanziamenti da parte delle multinazionali più discusse. Hanno preteso la cancellazione di opere e donazioni nella logica woke e dei canoni della cancel culture, scuotendo l’equilibrio nervoso dei direttori, quotidianamente esposti alle pretese di gruppi che chiedono di ridefinire gli spazi, di elaborare più adeguati linguaggi, di adottare politiche di assoluta trasparenza. Le scalinate neoclassiche che sancivano la sacralità del museo – come al British di Londra– sono occupate dai manifestanti contro la British Petroleum; l’atrio del parigino Musée de l’Immigration (ma anche quelli dell’americano Whitney Museum) sono frequenti palcoscenici per flashmob e pop-up in forma di performance. Il trauma storico del colonialismo, dello schiavismo, del razzismo, della prevaricazione occidentale scuote il silenzio tradizionale dei musei del costume, reclama esemplari riparazioni, solleva il tema delle restituzioni. Se ne sono accorti a Berlino con l’inaugurazione del colossale Humboldt Forum che vanta una sterminata collezione di manufatti di tutto il mondo, spesso frutto di predazioni coloniali.
Come se non bastasse, l’avvento del digitale ha messo in discussione persino la dimensione materiale dei manufatti: creando musei effimeri (le cosiddette experiences) che in realtà sono ambienti immersivi di proiezioni in continuo movimento, o insidiando da vicino la storica fattualità dei masterpieces. Nel Rijksmuseum di Amsterdam, la celebre Ronda di Notte di Rembrandt è affiancata da una lavagna touch screen che sostituisce la tradizionale didascalia, offrendo le potenzialità di un ipertesto descrittivo.
Ce n’è da far storcere il naso a ogni cultore del dialogo silenzioso con l’arte, ma naturalmente il risvolto della medaglia è l’allargamento della sua comprensione a un pubblico sempre più vasto e impreparato che va conquistato ad ogni costo.
Il dibattito è incandescente, la realtà ribollente. Certamente si può dire, come con le stagioni, che non esistono più i musei di una volta.
Fulvio Irace (a cura di)
Musei possibili. Storia, sfide, sperimentazioni
Carocci, pagg. 230, € 24