
/ Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander /
1 Settembre 2022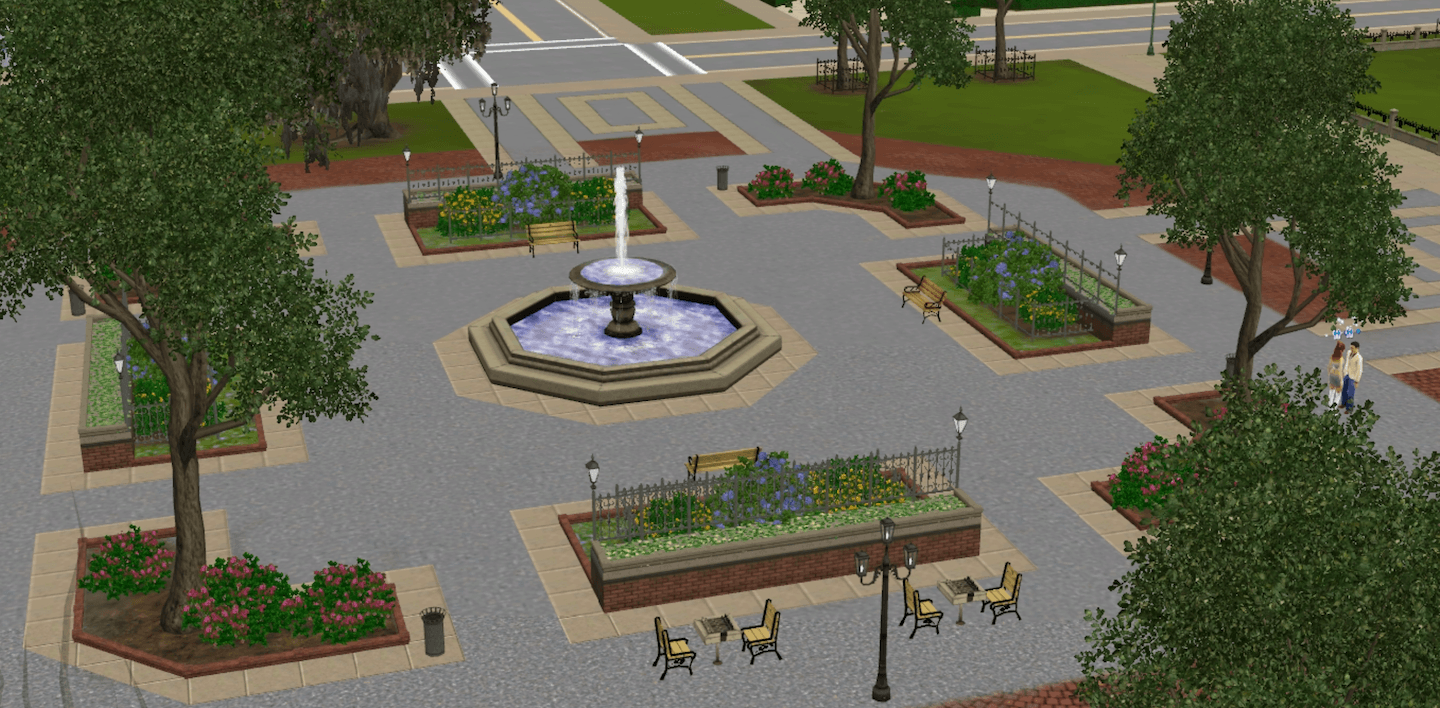
La piazza virtuale
1 Settembre 2022C’è in qualcosa nel nuovo film di Noah Baumbach che risuona del precedente (e magnifico) Marriage Story di cui ritrova anche il protagonista, Adam Driver; quel sentimento impalpabile di una fragilità del nostro essere nell’amore, nella vita, nello status professionale, nelle relazioni famigliari o amicali o con se stessi, e la sorpresa di potersi affidare a legami che scoprono sempre una nuova e diversa complicità. White Noise, che ha aperto ieri la Mostra del cinema numero 79 con un «tappeto rosso» affollatissimo – il festival è anche vetrina elettorale – e il Lido sold out da giorni in cui è difficile trovare anche un divano, nella vicenda della coppia protagonista riflette però molto altro: un paesaggio americano che ha origine dal romanzo di DeLillo, Rumore bianco, e dal suo «american dream» attraversato da una paranoia diffusa e costante che distorce il senso del mondo.
Noah Baumbach
Ho letto il libro di DeLillo all’inizio della pandemia e non potevo credere a quanto fosse pertinente rispetto al momento storico e alle nostre vite
DeLillo definiva quel suo racconto la ricerca di «uno squarcio di luce nel quotidiano» tra le paure che lo abitano, a cominciare da quella più grande di tutte, la morte. È questo anche l’incubo di Jack Gladney (Adam Driver), professore di successo in una ricca università americana del Midwest dove ha scalato la fama affermandosi come lo specialista assoluto di studi su Adolf Hitler – pure se non sa una parola di tedesco e cerca di impararlo in segreto senza grandi risultati. Le sue lezioni sono capolavori di One man show (una performance che ricorda un po’ quella in Annette di Carax): dietro agli occhiali, nel crescendo di drammaticità e di enfasi incanta e seduce gli studenti, gli altri docenti lo ammirano e lo considerano una «benedizione» per l’istituto, poco importa se in fondo è anche un po’ cialtrone: il suo iconico Hitler (quasi un Elvis della Storia) è ciò che serve nella rappresentazione di sé. E come i brillantissimi colleghi, esperti anche loro settoriali di ogni cosa, la sua abilità teorica è scollata dall’esperienza del quotidiano la quale quando arriva è irruenta, sfuggente, devastante, lo coglie impreparato, persino ignoto a sé stesso.
JACK è sposato con Babette (Greta Gerwig), insegnante di ginnastica posturale, hanno un piccolo figlio e altri adolescenti da precedenti matrimoni; Babette è dolce e solare, pure lei ha paura della morte, la notte quando parlano si confidano la paura reciproca di andarsene l’uno prima dell’altra, e si abbracciano forte. La mattina di una nuova giornata però il rumore è quello rassicurante dei lessici famigliari che si intrecciano: eppure ci sono segreti – ma non è questo che accade in ogni famiglia? Cosa inghiotte Babette di nascosto? Che sono quelle pillole? La figlia di lei (Raffey Cassidy) la osserva con sospetto, la spia, prova a capire ma la sostanza è ignota ai ricercatori più brillanti. Intanto Babette dimentica le cose sempre più spesso. E dove va quando dice di insegnare la sera tardi?
NELLE CONVERSAZIONI echeggiano leggende metropolitane, complotti, notizie della onnipresente televisione – «la famiglia è il luogo della disinformazione» ripete spesso Jack a fronte di quelle certezze improvvise con la fascinazione speciale per i disastri, quel senso della catastrofe incombente che è proprio dell’immaginario americano – come spiega uno dei colleghi di Jack (Don Cheadle) agli allievi prendendo a esempio gli incidenti di macchina nei film hollywoodiani che sono tragici ma soprattutto liberatori perciò unici rispetto a ogni altro cinema nel mondo – è la sequenza iniziale, quasi una dichiarazione di intenti.
Quando però la catastrofe diviene «reale» nelle loro vite con una nube nera tossica provocata da un incidente, la coppia (e la famiglia) esplodono: crisi profonda o un passaggio liberatorio? Marito e moglie devono affrontare i segreti che ruotano intorno a quell’ossessione della morte che li devasteranno, portandoli dopo passaggi complessi (forse) a una nuova complicità e consapevolezza. DeLillo ha scritto il romanzo negli anni Ottanta reaganiani, Baumbach li mantiene nel decor «vintage» lasciandovi scorrere il contemporaneo: in quella paranoia diffusa tra ufo, predicatori e invenzioni mediatiche si affermano l’esperienza (e le reazioni) degli anni pandemici con le ossessioni complottistiche della rete (al posto della tv) e la «specificità» del sentimento americano (e del Midwest) che ha i toni e i colori di una Campbell’s Soup warholiana della postmodernità. Più che come segno di un’epoca, il flusso di parole (e di silenzi) dei personaggi raggiungono però la loro compiutezza quando si fanno narrazione di uno stato d’animo, di un sentimento, di una ricerca emozionale al di là delle convenzioni sociali, delle loro dinamiche, di una loro «lettura». È in quello spazio che la scrittura (anche cinematografica) di Baumbach funziona e trova consapevolezza di un’emozione, di un cortocircuito eccentrico (formalmente) capace di cogliere la realtà nel suo spaesamento.




