
TYPOLOGIEN PHOTOGRAPHY IN 20TH-CENTURY GERMANY
13 Aprile 2025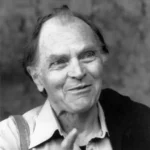
Feyerabend, diario anarchico di un metodico della irregolarità
13 Aprile 2025Dionigi Albera sull’isola di frontiera ora approdo di chi cerca una nuova vita
di Alessandro Vanoli
Guardatela dall’alto innanzi tutto. Dalla distanza che offrono le mappe. Persa nel blu intenso del Canale di Sicilia. Vedrete allora che quel minuscolo scoglio, prima di essere un’isola è già di per sé un confine. Estrema punta meridionale dello Stato italiano e dell’Europa, geologicamente è in realtà l’ultima propaggine del continente africano.
Forse si deve cominciare proprio da questo piccolo paradosso per parlare di Lampedusa. Luogo di passaggio e luogo di confine, piccolo spazio troppo lontano per essere considerato davvero rilevante, ma pur sempre centrale tra le rotte secolari che connettono Africa ed Europa. L’antropologo Dionigi Albera è partito proprio da simili contraddizioni per raccontare in modo affascinante la storia secolare di quest’isola (in Lampedusa. Una storia mediterranea, Carocci), accettando inevitabilmente che passato e presente potessero confondersi e che le storie di antiche battaglie e di incontri tra culture, finissero per specchiarsi nei problemi di un faticoso presente in bilico tra turisti e migranti.
Così ecco la Lampedusa più antica. Ed è strano scoprire che per secoli la storia dell’isola è di fatto la storia di uno spazio disabitato. O quasi. La prima notizia ci giunge infatti dalla Vita di San Luigi, famosa opera medievale che parla, tra le altre cose, delle avventure di crociata compiute dal re di Francia, Luigi IX. Ed egli nel 1254 si trovò per l’appunto a sbarcare a Lampedusa, trovandola deserta, se non per un eremo disperso tra viti, fichi e ulivi, all’interno del quale rinvenne due cadaveri. Non sappiamo molto altro, ma questa entrata dell’isola nella storia, oltre a segnare a suo modo un destino tragico e misterioso, ha già di suo il passo del romanzo (e non è un caso forse che nei secoli successivi, la maggior fortuna di quell’isola sarà nell’essere evocata tra i versi di Ludovico Ariosto, come luogo centrale tra le vicende dell’Orlando furioso).
Da quel momento in poi accadono tante cose, ma forse la più importante è che Lampedusa si fa progressivamente sempre più reale, soprattutto come spazio di confine. Ed è proprio quel suo eremo a mostrarne il senso più profondo. Dalla metà del XVI secolo appaiono infatti le prime testimonianze chiare dell’esistenza nell’isola di una grotta-santuario che ospita uno spazio di culto della Vergine, condiviso tanto dai cristiani quanto dai musulmani. Lo notano con stupore e interesse molti eruditi e viaggiatori del tempo: a sinistra, dicono, si trova una cappella cristiana, a destra un santuario musulmano; e tutti i credenti vi lasciano offerte, a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, a prescindere dalla religione. Tutto questo continuerà per secoli: una piccola isola; solitaria in alto mare, facile da conquistare ma difficile, se non impossibile, da tenere; così difficile da rimanere alla fine deserta, in equilibrio tra cristiani e musulmani. Almeno fino a quando tutto cambia di segno: è il 1849 quando Lampedusa passa ai Borboni e l’antico culto viene abolito. La Madonna da quel momento perde il suo antico volto di mediazione. E da questo momento, non a caso, si trasforma nella Madonna di Porto Salvo, protettrice dell’isola, celebrata ancora oggi. Ci vorrà poco perché tutto questo passi all’Italia appena nata.
Il resto è storia ormai contemporanea, che tra piccole e grandi trasformazioni, porta Lampedusa a ricoprire nuovamente il ruolo faticoso di frontiera tra mondi differenti. Ma questa volta in modo tragico, in quanto parte della nuova geografia delle migrazioni. Il fenomeno è cominciato negli anni Novanta con l’arrivo ogni anno di qualche centinaio di persone, soprattutto dalla Tunisia. Sbarchi sporadici e quasi inosservati inizialmente. Poi, un decennio dopo, le cose hanno cominciato a cambiare e le persone ad aumentare sempre di più. Lampedusa ha cominciato a diventare la meta dei flussi migratori trascinati attraverso il Sahara, sino alla Libia: migliaia di arrivi ogni anno, addirittura 30 mila nel 2008. Così quell’antico scoglio si è trasformato in una base operativa per azioni di controllo e di salvataggio e in un temporaneo centro di accoglienza o detenzione.
Un’isola frontiera, insomma, come in passato ancora oggi; senza che l’equilibrio tra i sacrosanti diritti degli isolani e le necessità dei migranti abbiano trovato una vera definitiva soluzione. In un’emergenza mai finita che è metafora triste dei recenti cambiamenti del Mediterraneo. Per i quali viene da pensare che sarebbe meglio ritrovare quella via che secoli prima l’isola stessa ci aveva già indicato: affidando il suo confine alla generosità di qualsiasi marinaio, indipendentemente dalla religione, piuttosto che al cinismo di chi sfrutta la guerra, la disperazione e la miseria.
https://www.corriere.it/la-lettura/





