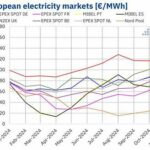Non è la fine della guerra. Certo non quella sperata da Netanyahu. Per lui tutto si doveva concludere con la distruzione di Hamas. Ora è costretto a firmare un accordo con i capi del movimento che voleva annientare. L’intesa fra Israele e Hamas sullo scambio di 20 ostaggi israeliani vivi e 28 morti contro 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui 250 ergastolani pluriomicidi, non è un evento storico. È un momento di rara umanità nell’inferno scatenato il 7 ottobre dai massacratori di Hamas, cui Gerusalemme ha risposto con un tentativo ormai avanzato di genocidio ai danni degli “animali” gaziani. Ma la partita per la pacificazione della Striscia e dell’intero Medio Oriente, rivendicata dal presidente degli Stati Uniti con toni millenaristici, resta tutta da giocare.
Nella migliore ipotesi, l’accordo è il primo passo destinato ad avviare aspri negoziati sulla seconda fase del piano Trump. Nella peggiore, una pausa speriamo non breve in un conflitto fuori controllo. Poche ore dopo l’annuncio di Trump, gli opposti estremisti di Hamas e degli ultrà teocratici del governo israeliano già lavorano alacremente a svuotare di senso l’intesa per la stabilità in Medio Oriente su cui il tycoon ha imperniato la sua autocandidatura al Nobel per la pace.
Alcuni dati appaiono comunque evidenti e premonitori. Primo. Ci si accorge, dopo aver fatto finta di non vederlo, che a Hamas saranno restituiti circa duemila combattenti, tra cui vari ergastolani avvelenati dalla lunga detenzione. Potenziali Yahya Sinwar. Una quota di scarcerati tornerà forse a Gaza, diversi in Turchia, Qatar o altrove.
Secondo. Non c’è né ci potrà essere accordo sul disarmo, ovvero sul suicidio di Hamas. Senza contare che ormai la causa palestinese si identifica con la resistenza islamista. Ciò che peraltro non dispiace alla gran parte degli israeliani che esclude per principio qualsiasi Stato palestinese, figuriamoci se retto dagli organizzatori del 7 ottobre.
Ieri Trump ha chiamato Netanyahu e gli ha detto: “Bibi, Israele non può battersi contro il mondo”. E Bibi: “Lo capisco bene”. In questo scambio di battute sta il senso dell’ambiguo rapporto fra due sedicenti grandi amici. L’errore strategico di Bibi e degli apparati che lo hanno inizialmente seguito è stato di credere che la guerra contro Hamas potesse produrre la vittoria decisiva. Sono anni che nelle Forze armate e nell’intelligence si discute attorno a questo concetto, che stravolge la postura dello Stato ebraico. Dalla guerra di indipendenza del 1948 in avanti Israele ha sempre ricompreso le sue campagne militari contro nemici arabi e/o terroristi palestinesi sotto lo slogan “mietiamo le erbacce”.
Ottant’anni di mietiture mai definitive sono sembrati abbastanza a diversi esponenti degli apparati di sicurezza. La “villa nella giungla” decisa a sbarazzarsi delle “bestie feroci” e a estendere i propri confini sta importando la giungla nella villa. La vittoria decisiva si sarebbe dovuta raggiungere attraverso campagne militari per sbaragliare i clienti dell’Iran, a cominciare da Hezbollah in Libano e Hamas oggi a Gaza domani in Cisgiordania. Per inaugurare il Grande Israele. Potenza nucleare insediata fra mare e fiume — Mediterraneo e Giordano — allargata a Giudea e Samaria (Cisgiordania), Libano meridionale fino al fiume Litani, pezzi di Siria oltre il Golan fino alle soglie di Damasco. Quanto all’Iran, infragilito e impedito a sviluppare l’atomica, si sarebbe sbarazzato del regime dei pasdaran, magari reinsediando la monarchia di casa Pahlavi. Da Ciro il Grande al Ciro minimo, pallido rampollo dell’ultimo scià, il “nobile popolo persiano” avrebbe riscoperto la sua natura filosemita. Vastissimo programma.
Per questo era necessario interpretare il massacro del 7 ottobre come minaccia strategica. Combattere Hamas quasi fosse lotta per l’esistenza. Come se Sinwar potesse innalzare il suo vessillo a Gerusalemme. Il problema è che Israele non può cogliere una vittoria decisiva. Per mille ragioni, ma soprattutto per l’esigua demografia che non gli permette di serbare il carattere ebraico in un mare di arabi. A meno di non ammazzarli e/o cacciarli tutti. Così mettendosi, direbbe (non solo) Trump, contro il mondo.