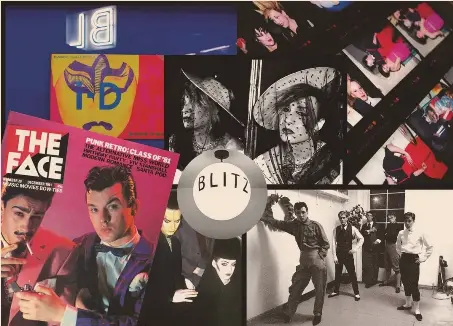Responsabilità e parole: la differenza tra governare e commentare
2 Novembre 2025
Corriere della Sera, intervista di Aldo Cazzullo a Massimo D’Alema, 3 novembre 2025
3 Novembre 2025
di Pierluigi Piccini
A Siena la “competenza” supplisce alla politica, ma senza una visione condivisa il governo del territorio rischia di smarrire la propria direzione.
L’Università di Siena è oggi una delle poche istituzioni capaci di esprimere progettualità e attrarre risorse. È un fatto positivo: la città ha sempre vissuto grazie alla forza delle proprie istituzioni culturali. Ma proprio per questo occorre chiarire i confini. In ogni sistema complesso la collaborazione tra enti funziona solo se ciascuno mantiene identità e responsabilità proprie.
Quando la politica abdica
Negli ultimi anni l’Ateneo ha esteso il proprio raggio d’azione: innovazione, sostenibilità, agroalimentare, comunicazione, sanità. È una crescita naturale, favorita dai fondi europei e dall’indebolimento di altri soggetti pubblici. Il rischio, però, è che la competenza si trasformi in supplenza politica. Quando la politica abdica al proprio ruolo di indirizzo, la “competenza” tende a riempire il vuoto e a ridefinire, di fatto, gli equilibri di governo della città.
Non è una questione di buona o cattiva fede, ma di governance: chi decide gli obiettivi, chi valuta i risultati, chi assume la responsabilità pubblica delle scelte?
Il limite della rappresentanza
Il Comune nomina un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Università: dovrebbe essere il luogo del dialogo strategico. Ma la realtà mostra che non basta. Nella fase di elaborazione dei progetti Pnrr, ad esempio, non c’è stata una reale condivisione con l’amministrazione comunale sulle priorità del territorio. In altre città — Bologna in primis — università e Comuni hanno costruito progetti integrati fin dall’inizio. A Siena no, e le conseguenze si sono viste anche nella precarietà dei ricercatori reclutati e poi rimandati a casa: non un semplice problema gestionale, ma un sintomo dell’assenza di visione comune.
Il rischio di sovrapposizioni si ripresenta in molti ambiti. Basti pensare alla duplicazione di funzioni tra l’Enoteca Italiana, con la sua missione di promozione del vino, e il Santa Chiara Lab, che sviluppa progetti nel settore agroalimentare. Senza un coordinamento esplicito si disperdono risorse e si alimenta concorrenza invece di complementarità.
Autonomia e coordinamento
L’Università ha legittimazione scientifica, non democratica. Il Rettore non è eletto dai cittadini; il Senato Accademico non risponde al corpo elettorale. La sua autonomia è un valore da difendere, ma non può prescindere da un coordinamento con la politica locale quando le scelte incidono sulla vita pubblica: mobilità, sanità, sviluppo territoriale. Autonomia non significa isolamento, né sostituzione della funzione di governo.
Il caso della sanità
Il tema emerge con particolare forza nella sanità. L’Università di Siena, con le sue competenze mediche, è una risorsa straordinaria. Ma le decisioni sulla programmazione sanitaria — investimenti, organizzazione dei servizi, allocazione delle risorse — devono restare in capo alla politica e alla struttura amministrativa pubblica. La collaborazione è necessaria, ma non deve diventare sovrapposizione: la ricerca produce conoscenza, la politica definisce le priorità, la sanità pubblica garantisce equità e accesso. Quando questi piani si confondono, il sistema perde trasparenza e direzione, e i cittadini la possibilità di sapere chi risponde di cosa.
La Fondazione Mps
Un discorso simile riguarda la Fondazione Monte dei Paschi, che ogni anno investe risorse importanti sul territorio, ad esempio Siena Food Lab. Le sue erogazioni hanno valore, ma appaiono spesso frammentate e prive di un disegno strategico complessivo. Anche qui serve chiarezza: quali obiettivi guidano le scelte? E come si integrano con le politiche pubbliche e con le iniziative dell’Università? Senza un coordinamento, il rischio è di sommare buoni progetti che non costruiscono sviluppo.
Una regia condivisa
Siena ha bisogno di una cornice di cooperazione esplicita tra istituzioni: un protocollo pubblico tra Comune, Università, Fondazione e Azienda sanitaria, con ruoli e responsabilità definite; un tavolo permanente di coordinamento strategico che operi già nella fase di progettazione; una relazione annuale al Consiglio comunale sugli esiti e sulle risorse impiegate. Non burocrazia, ma chiarezza democratica.
Conclusione
Collaborare non vuol dire confondersi. Il futuro della città dipenderà non solo dalle risorse, ma dalla capacità di distinguere competenza e potere, autorevolezza e mandato, consulenza e responsabilità.
Siena non deve ridurre il ruolo dell’Università, ma ricostruire una politica capace di dialogare con essa da pari a pari. Solo così la conoscenza può tornare a essere governo, non sostituto del governo.
Nota sulle fonti
Le informazioni e i riferimenti contenuti nel testo derivano da documenti pubblici, atti istituzionali e notizie di dominio pubblico riguardanti l’Università di Siena, il Comune di Siena e gli enti citati. L’articolo esprime esclusivamente un’analisi di carattere politico e istituzionale, senza intento diffamatorio o riferimento a persone fisiche.
Clausola di tutela legale
Il presente articolo esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di carattere politico, istituzionale e culturale, formulate in buona fede su fatti e informazioni di pubblico dominio. Ogni riferimento a enti, soggetti o progetti ha finalità di analisi e interesse generale. Non vi è alcuna intenzione diffamatoria né attribuzione di responsabilità personali. L’autore declina ogni uso improprio o decontestualizzato del testo da parte di terzi.