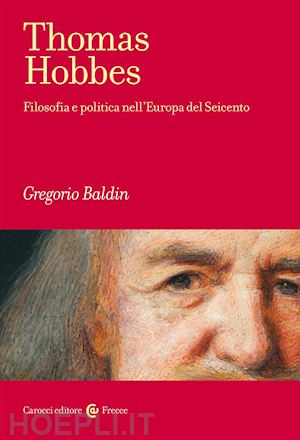L’elemento chiave per comprendere il pensiero di Thomas Hobbes (1588-1630), filosofo inglese di grandissimo spessore, è la paura. Un sentimento che si era sopito negli ultimi decenni di storia europea – di fatto un periodo tra i più sicuri mai vissuti nonostante la diversa percezione popolare – che è tornato prepotentemente ad angosciare gli spiriti, prima con l’epidemia di Covid, ora con la guerra ad portas. E proprio dalla paura parte il saggio, accurato, ben documentato, piacevolmente esposto nonché dotato di un serio apparato di note, di Gregorio Baldin, docente di Storia della filosofia nell’Università del Piemonte Orientale. Il sentimento della paura accompagnò Hobbes a partire dalla nascita. La madre gravida infatti, terrorizzata dalla possibile invasione delle coste britanniche da parte della Invencible Armada di Filippo II, diede alla luce prematuramente due «gemelli»: lui e la paura. L’invasione non avvenne ma la paura rimase, e fece sentire costantemente il suo peso nell’opera politica del nostro.
Grandissimo conoscitore dei classici greci e latini e padrone delle loro lingue, ateo e materialista convinto, monarchico assolutista e insieme però propugnatore, con il suo contrattualismo, di una sovranità che viene dal basso, Hobbes fu un pensatore sistematico che affrontò tutti i generi della filosofia del suo tempo, compendiandoli in tre grandi sezioni: la filosofia naturale o fisica dedicata al corpo, l’antropologia, dedicata specificamente all’uomo, e la filosofia politica incentrata sul cittadino. Ne derivarono non soltanto il De cive (1642), il De corpore (1655) e il De homine (1658), ma anche molte altre opere tra le quali il celebre Leviatano (1651), ove si dichiara che lo stato esiste per tutelare la vita e la sicurezza dei cittadini che ad esso si rivolgono per trovare la protezione che li liberi dalla paura. E infatti nella famosa immagine del frontespizio dell’opera il gigante rappresentante lo stato è formato da una moltitudine di omini (e anche di donnine) che sono accorsi verso di lui per trovare riparo, talché li si vede di schiena, con i loro cappelli e le loro cuffie.
Baldin non si limita a esporre e interpretare i contenuti del pensiero hobbesiano; compie invece un lavoro acribico di collocamento dello stesso nel contesto storico, sociale e culturale della sua epoca. Ma non lo fa meccanicamente, come in quei tabulati che mettono in una colonna le fasi della vita e del pensiero di un autore e poi accostano in un’altra la cronologia dei principali eventi contemporanei, no. Nel saggio di Baldin, che non ha concorrenti di tal genere nemmeno nella produzione di lingua inglese, la filosofia di Hobbes è integrata – come dire – organicamente all’interno della storia degli eventi politici, sociali, militari etc., in maniera tale che le due si compenetrano in un pensiero «embedded» nella complessa, ricca quanto tormentata età all’interno della quale al filosofo toccò trascorrere la sua lunga esistenza.
Thomas Hobbes viaggiò a lungo in Europa, compiendo anche lunghi soggiorni fuori dall’Inghilterra, e conobbe di persona grandissimi pensatori tra i quali il padre Mersenne, nel cui salotto parigino convergevano le più grandi menti dell’epoca. Forse incontrò di persona anche Galileo Galilei; di sicuro lo apprezzò e lo elogiò fino a definirlo «il più grande filosofo non solo di questo secolo ma di tutti i secoli», avendo intuito la portata rivoluzionaria dell’opera galileiana. Di notevole importanza il decennio francese di Hobbes, l’incontro-scontro con Descartes, l’elaborazione di un rigido materialismo coinvolgente anche l’anima, Dio, lo stesso cogito e le sensazioni, alla ricerca di una certezza «geometrica» per le azioni umane.
Il suo ritorno in Inghilterra, a Londra, avviene poco dopo il processo e la decapitazione di Carlo I con l’accusa di tradimento. Lo accompagna la fama come pure lo scandalo per il suo capolavoro, il Leviatano, e per le sue dure parole contro il potere ecclesiastico. Baldin sottolinea ampiamente l’estensione della parte di produzione di Hobbes consacrata a contestare le pretese della chiesa, sempre intenta a usurpare i diritti di sovranità appannaggio del potere civile. La religione, afferma Hobbes sulla scorta di Stazio e soprattutto di Lucrezio è stata creata dalla paura umana (primus in orbe deos fecit timor) e da subito ci fu chi se ne servì con finalità politiche (tantum religio potuit suadere malorum). E continuò a farlo.
Hobbes scrisse fino ad età avanzata: rimase sempre infatti una persona vivace, un po’ collerica (di temperamento «sanguigno»), studiosa, moderata nella dieta, fisicamente attiva, anche se negli ultimi decenni di vita fu costretto da un tremore alle mani (forse un Parkinson) a dettare i suoi pensieri a un amanuense. Ancora religione e chiesa saranno gli ultimi interessi, uno dei quali è l’eresia, il principio per il quale una dottrina giudicata eretica si oppone a una dottrina rivelata come vera. Ma tutto ciò soltanto dopo la appropriazione del termine e del concetto da parte della chiesa. Eresia infatti – in greco ??????? , derivato dal verbo ????? , scegliere – significava originariamente «scelta, elezione, inclinazione, proposta». Indicava una presa di posizione in termini filosofici o politico-religiosi, senza sentore di riprovazione. Questa si impone invece subito nel nuovo assetto religioso cristiano, dove le viene associato sempre di più il significato di deviazione, eterodossia, errore. Insomma l’obiettivo polemico di Hobbes si focalizzò sempre di più sulla religione e le sue pretese, anche se di fatto egli fu un pensatore eclettico di ampio respiro che ancora oggi interloquisce con noi dopo essersi confrontato nei secoli con svariati autori. Morì, dissero alcuni, da saggio stoico; da pio cristiano pentito, dissero malignamente altri. Scrive Baldin e mi piace riprendere la frase, com’era sempre vissuto: da filosofo.
Gregorio Baldin
Thomas Hobbes.
Filosofia e politica
nell’Europa del Seicento
Carocci, pagg. 346, € 35