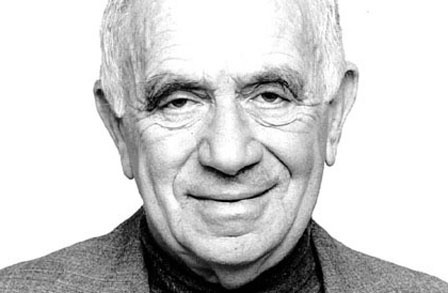C’è anche Siena?
4 Aprile 2024
Premierato, così l’Italia copia Israele: eppure lì fu un fallimento
4 Aprile 2024Editoriale
SAMARITANI COLLETTIVI
«Dal luogo in cui abbiamo ragione, i fiori non spunteranno mai in primavera». A 24 anni dalla sua morte, i versi di Yehuda Amichai, uno dei padri della poesia israeliana, continuano a smascherare la falsa ragionevolezza della guerra. Di quella che ancora una volta dilania il Medio Oriente e delle altre 184 guerre in corso nel pianeta. Non a caso sono nati in Terra Santa, che della logica illogicità dello scontro a oltranza è emblema e profezia. L’ampia fascia di altipiani desertici e colline verdeggianti tra il Giordano e il mare è un concentrato di buone ragioni per far girare all’infinito la macchina del conflitto. Ciascuno, essere umano, comunità o popolo, ha una sfilza di torti, abusi, vittime da rinfacciare all’altro.
Ciascuno ha una motivazione valida per nutrire paura e sfiducia nei confronti del vicino. Ciascuno ha “parole buone” – esistenza, ritorno, resistenza, sicurezza, perfino fede – con cui giustificare la “necessità” di combatterlo. Peggio, di eliminarlo. Parole che governi e nazionali e internazionali, rilanciano, ammantandole di un’aura di ineluttabilità e sano realismo.
Ne stiamo sentendo tante in questo tempo di normalizzazione della violenza bellica. La guerra come destino inevitabile, non come somma e conseguenza di deliberate scelte politiche, economiche e sociali. L’opzione unica che occulta la non volontà di costruirne altre. In un luogo simile – affollato di buone ragioni – non c’è posto per la vita, neanche quella di un fiore, scrive il poeta Amichai. La vita richiede spazio. Spazio in cui si insinui la storia dell’altro. In cui le sue altrettanto granitiche motivazioni aprano crepe nelle proprie.
La pace allora comincia da una “fessura”. Uno spiraglio da cui far entrare un filo di luce nel buio del “conflitto ragionevole”. Chi e in che modo può aprirla? Le istituzioni internazionali, ingessate da meccanismi ormai obsoleti, sembrano non riuscire, quando anche – e non sempre – lo vogliono. Alla loro inerzia fa da contraltare l’attivismo di gruppi, movimenti, associazioni, Ong della società civile. Nei teatri bellici più cruenti, troviamo là questi “samaritani collettivi”, per parafrasare papa Francesco. Con-sapevoli di non poter risolvere il conflitto, ma determinati ad aprire una fessura. Come? Confutando, con i propri gesti, la logica della guerra. Quella dei civili e delle loro vite
trasformati in danni collaterali più o meno accettabili in base alla posta in gioco. Quella della linea netta tra i propri e gli altri, i buoni e i cattivi, il bene e il male. Quella dei diritti umani a geografia variabile e dei dittatori finanziati con denaro pubblico dei contribuenti, quando fanno comodo. Gli operatori umanitari non lo fanno con i discorsi dotti. Portano i propri corpi dentro le lacerazioni dei conflitti – i tanti sotto gli occhi di tutti e i molti di più invisibili – per curare, sfamare, dissetare, salvare dall’annegamento, educare. Ovunque ci sia necessità: da Haiti all’Ucraina, dal Messico al Myanmar al Sudan. Indistintamente. L’esempio di World central kitchen è eloquente. All’indomani del 7 ottobre, nel caos generale, le sue cucine di emergenza hanno dato da mangiare agli israeliani sfollati dai kibbutz del sud e del nord. Con lo stesso spirito hanno donato 43 milioni di pasti ai palestinesi di Gaza. Sette di loro sono stati uccisi mentre lo facevano. È inaccettabile. Tanto più che sono morti per la fame, non propria bensì per saziare quella altrui. Eppure, accade spesso. Solo nel corso del 2023, in base alle stime di Humanitarian outcomes, che ha realizzato un’apposita banca dati, 116 operatori umanitari sono stati uccisi in servizio. Ogni volta purché siano cittadini del Nord del mondo e non locali – il mondo si indigna, almeno a parole. Eppure, fino a un minuto prima, quegli stessi uomini e donne erano stati accusati di connivenza, interesse personale, nel migliore dei casi, ingenuità. No, non sono ingenui. Di nuovo la Terra Santa lo dimostra, a chi ha il coraggio di guardare oltre l’ideologia del “conflitto inevitabile”. I costruttori di pace – e ce ne sono tanti in Israele come in Palestina, una pluralità di gruppi e reti troppo poco ascoltati – hanno impresse sulla propria carne le ferite di 75 anni di guerra nonché lo stigma del “tradimento” di fronte al clan di appartenenza. Le hanno, però, trasformate in fessure da cui far entrare un barlume di luce. La società civile sta facendo la sua parte. La comunità internazionale, almeno, non la lasci sola.