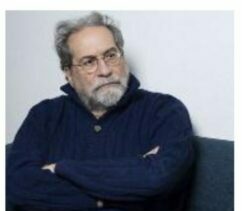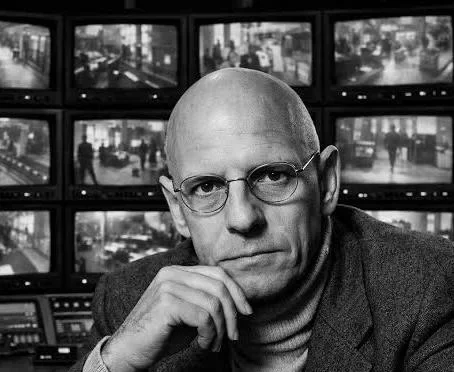Il Santa Maria e la sua ombra. Quando l’arte diventa decorazione dell’identità
14 Novembre 2025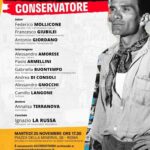
Pasolini non si lascia addomesticare
14 Novembre 2025
Politica dei luoghi, comunità e futuro nell’Amiata del 2025
Quando parliamo di “tornare”, non parliamo di nostalgia. Non parliamo del sogno di un passato idealizzato. Parliamo di un compito che riguarda noi — qui, oggi, nell’Amiata — in un’Italia che ha perso i suoi centri di equilibrio e deve ricostruirli dal basso.
La storia di Barzellotti che torna a Piancastagnaio non è una parabola morale. È un promemoria politico: si può passare una vita intera a salire e accorgersi, troppo tardi, che la direzione era sbagliata.
Per questo oggi dobbiamo ragionare seriamente — come amministratori, come cittadini, come comunità — su cosa significhi tornare. E soprattutto: tornare dove.
L’Amiata non è periferia. Non è margine. Non è un luogo da cui scappare per “realizzarsi” altrove. È un laboratorio concreto, dove qualità delle relazioni, energia rinnovabile, cultura diffusa, storia mineraria, montagna, borghi e competenze possono produrre un modello diverso da quello che ha consumato le città e desertificato i territori.
Tornare significa riconoscere il valore di ciò che esiste già: la forza delle comunità che resistono allo spopolamento, un’eredità culturale che non è folclore ma identità attiva, una geotermia che se governata bene diventa leva di sviluppo e non solo concessione, un tessuto produttivo che sta cambiando pelle tra pelletteria, innovazione, restauro ed energie, una dimensione umana dei rapporti che altrove è impossibile. Non è un ritorno sentimentale: è capire che qui ci sono le condizioni per un futuro più giusto, più sobrio, più governabile.
Da anni denunciamo la fragilità del modello italiano: individualismo, precarietà, servizi che arretrano, giovani che emigrano. I territori interni pagano il prezzo più alto, ma sono anche gli unici a poter costruire risposte reali. Tornare oggi significa riattivare le relazioni, farne il cuore della politica. Significa costruire cooperative di comunità, gestire in modo condiviso i beni comuni, tessere reti intercomunali che siano alleanze reali e non solo burocrazia, far vivere il mutualismo locale, sostenere le filiere corte, creare un welfare di prossimità per chi è fragile.
La solitudine è la nuova povertà. La comunità è il nuovo welfare. L’Amiata, per storia e carattere, sa ancora cooperare. Non dobbiamo importare modelli: dobbiamo far emergere ciò che sappiamo già fare.
Qui il limite non è teoria: è scritto nel bosco, nelle faggete, nei castagni, nei calanchi, nei versanti franosi. È scritto nell’acqua, nella neve, nell’escursione termica. È scritto nel fatto che ogni risorsa è preziosa e non rinnovabile all’infinito. Tornare alla terra significa costruire un’economia rigenerativa, riportare la produzione energetica dentro un patto con i territori, rendere sostenibile mobilità e accessi, valorizzare il paesaggio come bene collettivo, governare l’interazione fra natura, turismo, cultura e innovazione.
Non è ambientalismo astratto: qui è pianificazione quotidiana. La montagna non mente: ti dice cosa puoi fare e cosa non devi fare. Ascoltarla è politica.
Per anni la politica nazionale ha ignorato i territori come il nostro, trattandoli come costi invece che risorse. Noi dobbiamo ribaltare questa logica. Tornare significa costruire patti tra Comuni, imprese e cittadini che rendano possibile il ritorno nei centri storici, investire nei servizi essenziali — trasporti, salute, scuola — come condizione per la vita e non come spesa, considerare cultura e innovazione come leve economiche e non accessori, governare la transizione energetica con strumenti locali invece di subirla come imposizione, fare di Piancastagnaio e dell’Amiata poli di formazione, produzione e ricerca. Non è utopia: è la condizione per restare vivi.
Il nostro tornare non è chiusura identitaria. Non è autocelebrazione paesana. Non è difesa isterica della “tradizione”. Tornare è un modo diverso di aprirsi: all’innovazione che rispetta il territorio, alle imprese che accettano le regole del luogo, ai giovani con opportunità non precarie, alla cultura contemporanea come chiave di lettura del presente, all’Europa con progetti veri e non slogan. Il ritorno non è ritiro: è rilancio.
Il gesto di Barzellotti — tornare a Piancastagnaio per morire — è anche un ammonimento. Ci ricorda che si può capire la verità dei luoghi, ma fuori tempo massimo. Noi non possiamo permetterci questo lusso. I territori interni non possono aspettare. La crisi climatica non aspetta. Lo spopolamento non aspetta. La desertificazione dei servizi non aspetta. Il ritorno deve avvenire adesso: come scelta politica, come visione di governo, come progetto condiviso.
Per noi, qui, nel 2025, tornare significa questo: tornare a Piancastagnaio come centro e non come margine, tornare a una politica che non ha paura della complessità, tornare alla montagna come maestra e non come vincolo, tornare alla bellezza come risorsa economica e non come retorica, tornare alla comunità come forza e non come ricordo, tornare a un’economia che non consuma la terra ma la rigenera, tornare a un’amministrazione che ascolta prima di decidere, tornare a un modello di sviluppo che tenga insieme lavoro, cultura e ambiente.
Tornare, insomma, significa prendere in mano ciò che abbiamo ereditato e portarlo in avanti — senza svenderlo, senza consumarlo, senza tradirlo. Significa fare dell’Amiata non un luogo che sopravvive, ma un luogo che guida.
Barzellotti tornò quando non poteva più parlare. Noi possiamo tornare mentre abbiamo ancora parole, idee, strumenti. Il nostro tornare non è gesto privato: è progetto pubblico, collettivo, politico. È decidere che la scorza della modernità non basta più. Che serve aprirsi. Che serve cadere a terra, come un riccio maturo, per far germinare finalmente un futuro nuovo.
Qui. Adesso. In Amiata.
(fine)