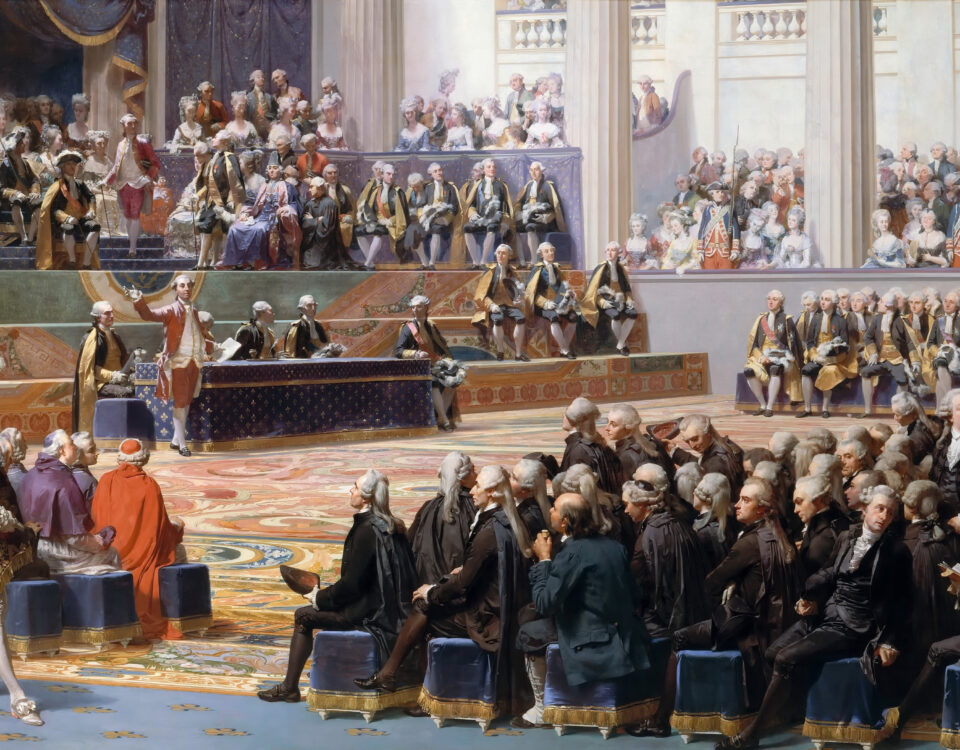Master of Puppets
2 Gennaio 2026
Biotecnopolo: tra atto amministrativo e progetto reale
2 Gennaio 2026Bocciarelli al posto di Calvino: la leggerezza come spettacolo
di Pierluigi Piccini
Il richiamo alla “leggerezza” può apparire come un gesto conciliatore, ma poggia su un equivoco profondo. Nel discorso della Fabio, responsabilità e leggerezza vengono presentate come poli distinti da tenere in equilibrio: da un lato il peso dell’impegno, dall’altro una leggerezza chiamata ad attenuarlo. In questo modo, però, la leggerezza viene privata del suo significato più rigoroso e ridotta a un semplice registro emotivo.
In realtà, la leggerezza non attenua la responsabilità né le si aggiunge dall’esterno: ne è parte costitutiva. È una postura critica, una forma di precisione dello sguardo che consente di esercitare il pensiero senza esserne schiacciati, mantenendo distanza, lucidità e capacità di giudizio. Separarla dall’impegno significa trasformarla in stile, in tono, in atmosfera. Ed è precisamente ciò che accade quando viene intesa come intrattenimento, come linguaggio pop, come qualità rassicurante e immediatamente condivisibile — fino a essere esemplificata, senza esitazioni, da figure come Irama.
Qui lo scarto non è solo culturale, ma politico. Questa idea di leggerezza non interroga il potere, non ne mette in crisi i linguaggi, non produce attrito. Al contrario, funziona come dispositivo di pacificazione simbolica, come forma di consenso morbido. Se ci fosse una reale consapevolezza della tradizione da cui il concetto proviene — quella che passa, evidentemente, da Calvino — non sarebbe necessario separare responsabilità e leggerezza: le due dimensioni starebbero insieme, in una tensione costitutiva e produttiva.
Arte contemporanea e dispositivo di rassicurazione
È dentro questo slittamento che va collocata anche la questione dell’arte contemporanea. L’arte, quando è davvero tale, non serve a “completare” un’offerta culturale né a rendere più gradevole un racconto istituzionale: serve a incrinare, a produrre scarti, a introdurre conflitto simbolico. Quando invece viene ridotta a contenuto espositivo, a evento che deve funzionare, piacere e circolare, perde la sua capacità di incidere e diventa parte dello stesso dispositivo di rassicurazione.
In fondo qualcosa accomuna Bocciarelli e Leone, pur nella distanza evidente dei linguaggi e delle ambizioni. Entrambi concepiscono la cultura come esposizione, come costruzione di un racconto che deve funzionare, essere riconoscibile, circolare. Nel caso di Bocciarelli ciò assume forme apertamente spettacolari e semplificate; in quello di Leone prende una forma più selettiva, colta, talvolta disposta al rischio e persino alla possibilità di non piacere. La differenza è reale e va riconosciuta.
Questa impostazione ha in parte tentato anche il direttore della Pinacoteca. Ma lì il materiale stesso — la natura della collezione, la sua densità storica e simbolica — ha funzionato da argine. Il patrimonio ha imposto dei limiti, impedendo una trasformazione pienamente orientata alla comunicabilità e al racconto, e conservando una resistenza interna alla spettacolarizzazione.
Il territorio come interlocutore assente
Ciò che continua a mancare, anche nelle versioni più esigenti di questo modello, è un rapporto strutturale con il territorio inteso non come sfondo, ma come soggetto. L’arte contemporanea non viene chiamata a misurarsi davvero con la città, con le sue contraddizioni, le sue stratificazioni sociali e simboliche. Non diventa un luogo di produzione di senso radicato, ma un dispositivo che arriva, si espone e riparte. Il rischio, la selettività, persino l’impopolarità restano qualità interne al progetto curatoriale, non leve di un processo capace di produrre trasformazione culturale reale.
È qui che si misura la distanza più profonda. Una politica culturale che sappia distinguere non si limita a produrre buone mostre o contenuti ben confezionati, ma assume il territorio come interlocutore critico, come campo di sperimentazione, come soggetto capace di reagire e trasformarsi. Senza questo passaggio, anche l’arte contemporanea più raffinata rischia di restare autoreferenziale, e la selettività di ridursi a stile più che a progetto.
Da interrogazione a messa in scena
Non è una questione di persone, ma di paradigma. Di un passaggio silenzioso ma decisivo: da una cultura che interroga, seleziona e mette in tensione il reale, a una cultura che organizza, mette in scena e rende visibile ciò che deve funzionare. In questo slittamento si misura la distanza tra un’idea della cultura come esercizio critico e una cultura intesa come dispositivo di comunicazione. Ed è precisamente qui — nello scarto tra interrogazione e messa in forma, tra conflitto e gestione — che il cerchio si chiude.