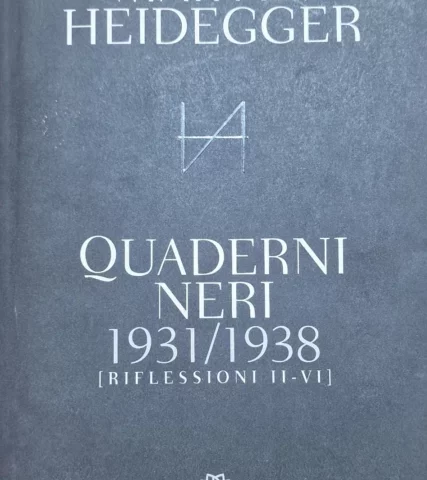LA MATERIA IMMORTALE
11 Gennaio 2026
Yasmin Levy – Una Noche Mas
11 Gennaio 2026Pierluigi Piccini
Una domenica pomeriggio d’inverno, in silenzio, sfogliavo alcune pagine dei Quaderni neri. Non cercavo rivelazioni né scandali tardivi. Cercavo una misura. Volevo capire, senza difese e senza indulgenze, la distanza che si era creata tra quei testi e il punto a cui ero arrivato. Non una distanza polemica, né un ripensamento improvviso, ma qualcosa di più lento e profondo: la distanza che separa una formazione da una trasformazione. Ho sentito il bisogno di scrivere questo testo in quel momento preciso, perché solo la scrittura mi consentiva di dare forma a ciò che ormai era chiaro ma non ancora detto: non stavo più pensando nello stesso modo, e non potevo più agire come prima.
Per anni ho pensato l’essere come una promessa di stabilità. Non nel senso ingenuo di un rifugio, di un “posto sicuro” in cui ripararsi, ma come il tentativo severo, quasi ascetico, di sottrarre qualcosa alla dissipazione. Diffidavo delle consolazioni, ma cercavo una tenuta: un principio che non fosse travolto dal consumo del tempo, un punto in cui il reale non si risolvesse in flusso e perdita. Se devo dirlo senza retorica, era un modo di avvicinarmi all’immortalità senza nominarla: non l’immortalità dell’anima, non l’aldilà, ma un’idea più dura e più filosofica, l’immortalità come permanenza dell’essere, come ciò che resta mentre tutto muta.
È qui che Martin Heidegger è stato per me decisivo. Il suo pensiero mi ha formato non perché offrisse certezze, ma perché mi ha insegnato a prendere sul serio l’apertura: l’esposizione al tempo, la fragilità del senso, l’evento che precede la volontà. Ho imparato che il pensiero autentico non mette al riparo, ma espone; non fonda sistemi, ma resta sulla soglia. Eppure, proprio mentre mi educava alla finitezza, quel pensiero lasciava intravedere un’altra aspirazione: l’essere come invio, come storia profonda, come ciò che attraversa le epoche e non muore. La morte dell’individuo non diventava l’ultima parola, perché restava un’idea di permanenza più originaria: il reale come destino che tiene insieme, come trama che, in qualche modo, salva dalla pura dispersione.
A un certo punto ho capito che questa ricerca di stabilità aveva un prezzo. Non un prezzo morale, ma ontologico e politico. Quando la stabilità diventa criterio, il pensiero tende a trasformare ciò che accade in ciò che deve accadere. Il tempo, invece di aprire possibilità, si irrigidisce in una traiettoria. La storia si fa narrazione necessaria. L’evento perde la sua imprevedibilità e si trasforma in figura del destino. È una torsione sottile ma decisiva: il pensiero nasce per liberare e finisce per fondare; nasce per aprire e rischia di chiudere.
Questo passaggio è stato per me una soglia. Non ho rinnegato ciò che mi ha formato; l’ho attraversato. Ma attraversarlo ha significato riconoscere qualcosa di più radicale: che l’ossessione occidentale per il fine ultimo – il telos – non è solo una struttura teorica, ma una macchina che organizza la vita. È il modo in cui abbiamo imparato a giustificare il presente come semplice mezzo: la materia vale se “serve”, il tempo vale se “porta” da qualche parte, le cose valgono se si lasciano tradurre in uno scopo. Quando lo scopo è compiuto, ciò che resta diventa residuo, scarto, problema da eliminare. È una metafisica travestita da buon senso, tanto più potente quanto più invisibile.
Da qui nasce la nuova tappa del mio ragionamento: demolire il primato dello scopo senza cadere nel nichilismo. Non dire “non c’è scopo, dunque nulla ha senso”, ma dire l’opposto: è proprio l’assenza di uno scopo ultimo a liberare la produttività del reale. Ho chiamato questa postura scoposizione: non l’afinalismo stanco di chi si arrende, ma la deposizione attiva della tirannia del fine. Un gesto che non svuota il mondo, ma lo riapre.
In questa nuova luce, anche il tema dell’immortalità si è trasformato. Prima lo cercavo come stabilità: l’essere come ciò che permane, come garanzia contro la fine. Oggi lo vedo in modo più duro e, paradossalmente, più fertile: l’immortalità non è la persistenza dell’identico, ma la metamorfosi senza compimento. La materia non “muore” come immaginiamo che muoia un io. La materia differisce la fine, la rinvia, la redistribuisce. Ciò che chiamiamo “fine” è spesso un confine imposto da noi, dall’ansia di chiudere i processi in categorie nette. Ma nel reale non c’è un punto in cui qualcosa smette di accadere: cambia forma, cambia connessione, cambia funzione. La materia non ha tempo morto.
Questo spostamento mi ha portato naturalmente a Jean-Luc Marion, non come fuga da Heidegger, ma come conseguenza interna del mio cammino. Marion mi ha dato parole per pensare un evento che non fonda e non si lascia fondare. Il dono eccede, non stabilizza. Non istituisce una storia necessaria, non assegna missioni, non produce identità forti. Accade e, proprio perché accade senza garanzia, disarma la volontà di trattenere. In questo passaggio ho riconosciuto una disciplina del pensiero: una vigilanza costante contro la tentazione di trasformare l’apertura in destino.
La mia laurea su Marion ha preso forma dentro questa tensione, ma non è nata solo tra libri. È maturata anche in un’esperienza concreta: la mostra Il Dono al Palazzo delle Papesse. Lì ho visto con chiarezza che non era solo intellettuale che il dono non è un concetto consolatorio. È una ferita nel nostro modo di possedere. È la prova che qualcosa può darsi senza ridursi a scopo, senza essere catturato come funzione, senza diventare risorsa. L’arte, quando è vera, non illustra idee: produce un’esperienza di eccedenza. Mi ha costretto a riconoscere che il pensiero non deve per forza chiudere in una sintesi; può restare all’altezza dell’evento, senza addomesticarlo.
Da quel momento, la domanda è diventata inevitabile: se il reale è trasformazione continua, se la materia non “finisce” ma muta, se il futuro non è un traguardo ma un campo aperto, allora come cambia il mio modo di pensare e di agire?
Qui entra un nodo pienamente contemporaneo: la colonizzazione del futuro attraverso i sistemi di calcolo. La tecnologia non si limita a organizzare il presente; lo traduce in proiezioni, in scenari, in ottimizzazioni. Produce futuri “razionali” e li rende prescrittivi. Il rischio non è la previsione in sé, ma l’autorità invisibile della previsione: ciò che è calcolabile tende a diventare ciò che è reale, e ciò che non entra nel calcolo viene degradato a rumore. È una nuova forma di platonismo, questa volta computazionale: il mondo vero è quello che sta nei modelli, e la materia, con le sue ambiguità, diventa un fastidio da ridurre.
La scoposizione è anche una resistenza a questa teleologia automatica. Non una protesta romantica contro la tecnica, ma un criterio per non esserne governati. Se il sistema dice “il futuro ottimale è questo”, la scoposizione risponde: il futuro non deve arrivare in quella forma. Il futuro vero è ciò che non è afferrato. Non per celebrarne l’oscurità, ma per custodirne l’apertura. È una responsabilità più difficile: non garantire risultati, ma proteggere possibilità.
Qui la filosofia diventa prassi.
Pensare e agire in modo scoposto significa rinunciare all’ossessione dell’“uso migliore” e lavorare sugli “usi possibili”. Progettare non come chiusura, ma come esplorazione. Non impostare processi per estrarre un unico valore, ma creare condizioni perché più trasformazioni possano coesistere, anche quando non sono tutte economicamente massimizzabili. La realtà non è una scala unica di valore: è una pluralità di valori non convertibili in un solo metro.
Significa anche reintrodurre spazi di non-utilizzo. Non tutto deve entrare nel ciclo economico umano. Non per moralismo, ma perché la saturazione di ogni possibilità in una sola direzione è la forma più raffinata di violenza. Lasciare che una parte del reale resti fuori dall’ottimizzazione non è spreco: è cura dell’aperto.
Significa cambiare rapporto con il tempo. Il tempo del calcolo è discreto, scandito, impaziente: produce report, chiude cicli, misura scarti. Il tempo della trasformazione è durata, maturazione, kairos: richiede attenzione, presenza, sapere pratico. In questa nuova tappa, mi interessa una politica e un’economia capaci di riconoscere tempi diversi, non un solo tempo dominante.
Significa documentare senza totalizzare. Sì, tracciare, misurare, conoscere. Ma senza trasformare la rappresentazione in giudizio ontologico. Senza credere che ciò che non è nel database non esista. Ci sarà sempre un resto non computabile, un’eccedenza che sfugge: non è un difetto, è la garanzia che il reale non è completamente colonizzato.
Infine, significa ripensare la responsabilità. Non più come realizzazione di uno scopo finale, ma come custodia della possibilità di trasformazione. Essere responsabili non è portare il mondo a un traguardo; è evitare di chiudere il futuro prima ancora che bussi. È scegliere senza assolutizzare la scelta, decidere senza mitizzare la decisione, agire senza trasformare l’azione in destino.
Questa è, oggi, la mia nuova tappa. Non la ricerca di una stabilità che assomiglia a un’immortalità mascherata, ma la fedeltà a un’immortalità più reale e più inquietante: quella della materia che non smette di trasformarsi e dell’evento che non si lascia possedere. Un pensiero senza traguardo non è un pensiero senza direzione morale; è un pensiero che rifiuta di giustificare il presente come sacrificio in nome di un futuro già scritto. È un pensiero che restituisce valore al presente come campo di trasformazioni, e al futuro come sorpresa.
Qui ritorna, con una forza che oggi sento necessaria, l’utopia del non-ancora di Ernst Bloch, scoperto tanti anni fa grazie a don Flori e mai davvero abbandonato. Il Principio Speranza non promette salvezze garantite né approdi certi: apre. Custodisce ciò che nel reale non è ancora dato, ciò che insiste senza essere visibile, ciò che non può essere dedotto dal presente. È una speranza senza calendario e senza programma, ma proprio per questo radicale. Non consola, ma orienta. Non chiude il tempo, lo tiene aperto.
In un’epoca che ha smesso di credere nel futuro perché lo ha trasformato in previsione, in calcolo, in ottimizzazione, questa speranza è di nuovo indispensabile. Non come fuga, ma come resistenza. Non come ideologia, ma come esigenza antropologica e politica. Senza il non-ancora, il presente si irrigidisce, diventa gestione dell’esistente, amministrazione della fine. Con il non-ancora, invece, il presente torna a essere spazio di possibilità reali, di trasformazioni non ancora pensate, di scarti che non sono residui ma aperture.
Non ho chiuso un ciclo. Ho deposto l’idea che il ciclo debba chiudersi. E in questa deposizione — scoposizione — ritrovo, oggi, la forma più concreta della speranza: non l’attesa di ciò che verrà certamente, ma la cura di ciò che potrebbe accadere. È poco, forse. Ma è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in un tempo che ha smesso di aprirsi al futuro.