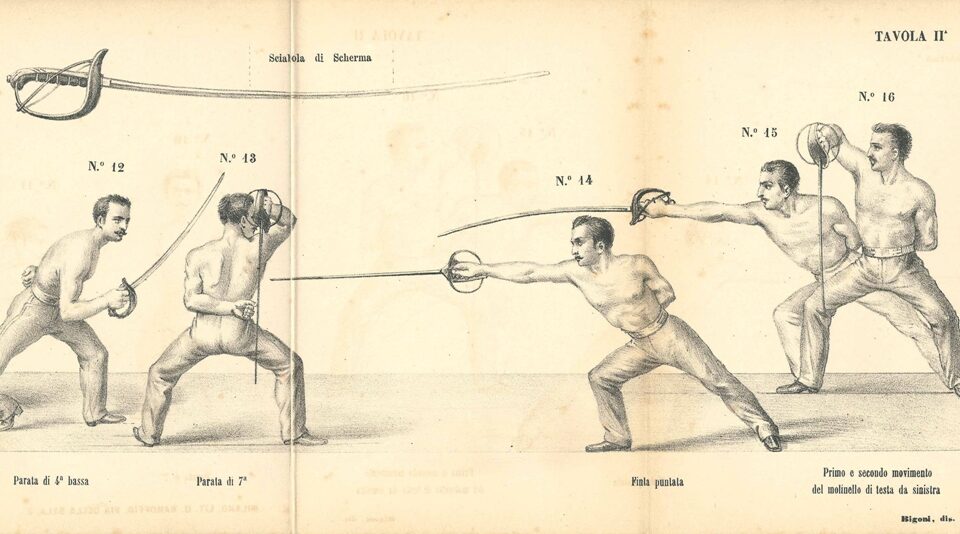La democrazia dopo la democrazia
23 Gennaio 2026
MILLE NOTTI A TEHERAN
24 Gennaio 2026
C’è una linea sottile che attraversa alcune delle esperienze culturali più interessanti di questi giorni: non l’idea di un progetto, di una forma compiuta o di un messaggio da trasmettere, ma piuttosto la disponibilità a lasciar accadere il reale, a sostare nell’indeterminato, a non forzare il senso. È una postura esistenziale prima ancora che estetica, che riguarda le vite, le immagini e persino il vivente nel suo insieme.
La incarna in modo radicale Claude Loir, protagonista del documentario Un jeune homme de bonne famille di Sébastien Lifshitz. La sua è una vita che non si è mai lasciata organizzare in un destino: un’infanzia segnata dall’assenza, l’esperienza militare, l’approdo alla libertà sessuale in un tempo di clandestinità e di rischio, il passaggio disinvolto tra teatro, fotografia, cinema pornografico, senza mai trasformare nulla in identità definitiva. Loir racconta tutto con una calma disarmante, come se l’esistenza fosse stata per lui una corrente da seguire più che una strada da costruire. La libertà, nel suo racconto, non è un’idea astratta ma una pratica minima: accettare ciò che arriva, cogliere l’occasione, non irrigidirsi. Attorno a questa voce, il film ricompone pazientemente frammenti dispersi, immagini dimenticate, tracce destinate a scomparire, restituendo visibilità a quelle vite che la storia ufficiale considera marginali, quando non indegne di memoria.
La stessa diffidenza verso la forma chiusa e il significato imposto attraversa l’opera di Gerhard Richter, protagonista di una grande retrospettiva alla Fondation Louis Vuitton. Richter ha sempre dichiarato di amare ciò che non ha stile, perché lo stile, quando diventa affermazione, è una forma di violenza. Le sue immagini sfocate, i dipinti tratti da fotografie, i paesaggi indistinti non cercano di dire qualcosa sul mondo, ma di mostrare come il mondo ci appare prima di ogni intenzione. È una pittura che pratica la sottrazione, una sorta di “de-pittura” che rinuncia al controllo dell’artista per lasciare spazio all’opacità del reale. Guardare questi lavori significa accettare di non vedere tutto, di non comprendere fino in fondo, di restare in quella zona intermedia in cui il senso non è ancora stabilizzato.
Questo stesso movimento di apertura si ritrova, su scala più ampia, nell’esperienza immersiva Quelques secondes d’éternité, che trasforma il Musée d’Orsay in una vera e propria architettura vivente. Qui non è più solo la biografia o l’immagine a sottrarsi alla fissazione, ma la vita stessa, raccontata come una serie di metamorfosi della materia. Proiezioni, musica, voce e ricerca scientifica si intrecciano per mostrare la plasticità del vivente, il suo continuo divenire, senza gerarchie tra arte e scienza. Lo spazio museale smette di essere contenitore e diventa ambiente, organismo, esperienza condivisa, invitando lo spettatore a percepirsi come parte di un sistema più vasto, fragile e in trasformazione.
In filigrana, queste esperienze sembrano dire la stessa cosa: che forse non si tratta di affermare, spiegare o dominare, ma di imparare a stare. Stare nelle vite che non fanno storia, nelle immagini che sfuggono alla messa a fuoco, nei processi vitali che non si lasciano ridurre a schema. Lasciarsi accadere, senza paura di vivere e senza paura di perdere.