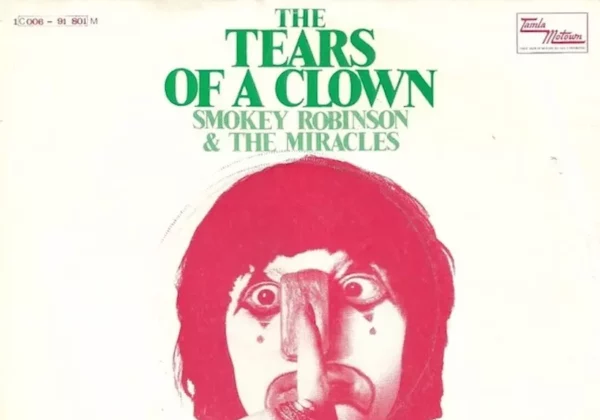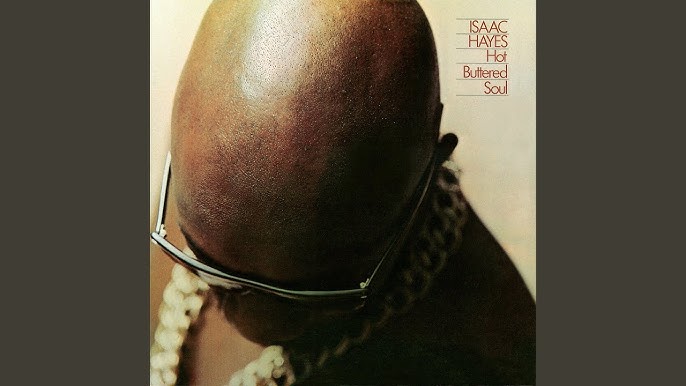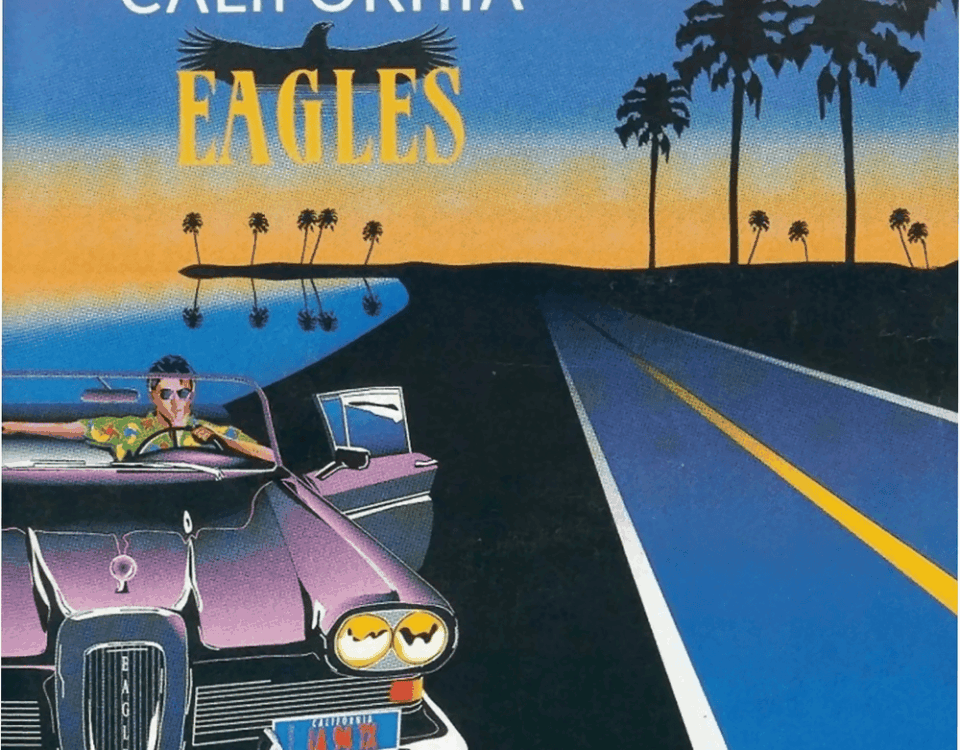An ‘AI afterlife’ is now a real option – but what becomes of your legal status?
15 Febbraio 2026
Mio “nipote” Umberto
15 Febbraio 2026György Kurtág
di helmut failoni
Tra pochi giorni, giovedì 19 febbraio, il compositore ungherese György Kurtág, uno fra i più grandi e originali del secondo Novecento, compirà cent’anni. Sì, un secolo. Un’età in cui è ancora con l’orecchio, non solo metaforicamente, proteso sulla partitura: il 20 febbraio a Budapest andrà in scena in prima mondiale la nuova opera Die Stechhardin (2023-2025), ma l’ultimissima delle sue creazioni, una breve composizione pianistica dedicata al figlio e alla nuora, è datata 24 dicembre 2025. Kurtág, rispetto al mondo della musica contemporanea, è stato creativamente schivo e solitario. Non ha mai seguito le strade maestre, nemmeno quelle dei suoi contemporanei. Agli esordi, insieme all’amico di una vita, il compositore György Ligeti (1923-2006), fu seguace di Béla Bartók (1881-1945) e successivamente, sull’onda lunga di Anton Webern (1883-1945), è diventato, anche se esteticamente distante, maestro dell’aforisma in musica: il minimo delle note per il massimo dell’espressione. Játékok («Giochi»), per esempio, è una raccolta di brevi pezzi pianistici iniziata nel 1973, suddivisa in oltre dieci volumi, che Kurtág ha anche inciso per l’etichetta Ecm — in duo con l’amatissima moglie Márta — come diversi altri suoi capolavori, quali i Kafka-Fragmente, Hommage à R. Sch. op. 15d e Jelek, játékok és üzenetek (Signs, Games and Messages), questi ultimi con la viola di Kim Kashkashian. La quale a «la Lettura» dice: «Come un angelo senza genere venuto a dare notizie severe con il più profondo amore, Kurtág accende in noi il bisogno di puntare alla massima chiarezza e potenza. La sua musica si avvicina il più possibile alla creazione di un riflesso dell’universo: architettura ed equilibrio, in cui tutto è permeato da una compassione profondamente umana». E aggiunge: «Non lo si può paragonare a nessuno. Le sue radici? Più occidentali che orientali: viene direttamente da Beethoven». Nel 2026 sotto il nome di Kurtág 100, festival in tutt’Europa lo celebreranno. «La Lettura» lo ha intervistato.
Le capita di sognare la musica?
«Sì, ma spesso la dimentico».
Che cosa le rimane al risveglio?
«Una sensazione di benessere e la fiducia che riuscirò a comporre… forse. Con il passare del tempo sogno meno. Ma quando accade, può essere importante».
Si ricorda un suo sogno?
«Dopo la morte di Annie Fischer (pianista ungherese, 1914-1995, ndr) sognai molto chiaramente un brano musicale. Alcune note di quel sogno trovarono poi posto nel mio brano Virág. In quel periodo, nello stato di veglia non riuscivo davvero a lavorare. Nel sogno, invece, scrivevo musica con grande chiarezza. Esistono anche opere che non sono nate propriamente da un sogno, ma che funzionano come un sogno. Colinda, per esempio, si muove e agisce come se fosse un sogno».
Come compone? Segue regole fisse?
«No. Quando so già come fare una cosa, quando la forma è chiara in anticipo, mi fermo, non continuo a scrivere quel brano. Il desiderio scompare. Il mio cervello, da solo, non mi porta molto lontano. Per me, gli impulsi inconsci e istintivi sono decisivi: nulla conta di più. Scrivo prima, solo poi capisco ciò che ho fatto».
Lo comprende sempre comunque?
«Spesso non capisco. Se un’idea diventa troppo chiara subito, perdo l’interesse».
La funzione della musica, per lei ?
«La musica non è qualcosa che si merita automaticamente. Ci sono momenti in cui non si è nello stato giusto per ascoltare Beethoven o Béla Bartók, né tantomeno per percepire davvero il primo canto del merlo in primavera. Forse lo si potrà meritare l’anno successivo. Meritare, in questo senso, significa trovarsi in uno stato di concentrazione e di totale disponibilità. Se qualcosa arriva gratuitamente, se non costa nulla, allora non è vero. Per me la musica ha a che fare con questa soglia: una soglia tra presenza e assenza, tra la vita e una specie di morte apparente».
Da giovane ha studiato a Parigi con Olivier Messiaen e Darius Milhaud. In quel periodo attraversò una crisi creativa. La aiutò una psicologa, Marianne Stein, alla quale dedicò il suo primo Quartetto per archi del 1959.
«L’incontro con Marianne, che all’epoca era una figura di riferimento nella psicologia dell’arte, è stato decisivo per me. Mi ha liberato da dubbi profondi, da un’ansia che mi paralizzava, da una vera immobilità creativa».
Come la aiutò concretamente?
«Mi ha fatto capire che dovevo comporre come pensavo io, non come pensavano gli altri, e che dovevo cercare la verità. L’ho raccontato altre volte: mi parlò degli Einzeltöne, delle singole note, e mi disse di concentrarmi su di esse. Disse di avvicinare due note, metterle in relazione, immaginando un’unità melodica. Io però capii qualcosa di diverso, ma da quell’equivoco nacque per entrambi un nuovo modo di pensare il processo creativo».
Nel suo catalogo i pezzi brevi sono superiori a quelli più lunghi. Perché predilige questa forma?
«Come Webern, mi sono progressivamente orientato verso forme piccole, molto piccole. In quel periodo, oltre alla terapia, costruivo forme semplici con fiammiferi e bastoncini; disegnavo in modo spontaneo i miei impulsi nervosi su fogli di carta, con la penna stretta nel pugno. Lasciavo dei segni. Fu anche allora che decisi di tornare in Ungheria: avevo compreso, grazie al lavoro con Stein, che il luogo geografico in cui si vive conta in realtà molto poco. Come compositore ho sempre cercato la massima concentrazione possibile. Ho affrontato le questioni fondamentali della vita, fisica e spirituale, con un’introspezione il più possibile onesta, talvolta persino crudele. Mi sentivo diverso da molti miei contemporanei perché per me la comprensione passava sempre attraverso le emozioni».
Tutto ciò la poneva controcorrente.
«In contrasto con le tendenze dominanti, nazionali e internazionali. Dove l’essenziale erano struttura e musica dodecafonica; tutti cercavano il radicalmente nuovo, rompendo con il postmodernismo. Sapevo bene dove andavano i miei contemporanei: il mio amico György Ligeti mi mandava partiture e dischi. Anche se tutto ciò aveva un effetto su di me, non ho mai voluto allontanarmi dal mio cammino. Un cammino che, in fondo, non si sapeva nemmeno dove conducesse».
Prendiamo due fra i suoi lavori più noti, i «Kafka-Fragmente» e «Fin de partie», ispirato a Samuel Beckett. Nei due scrittori cosa l’ha affascinata? Il loro linguaggio concentrato, conciso, essenziale, che dice tutto in poche parole? Pensiamo anche ai suoi omaggi ad Anna Achmatova e Friedrich Hölderlin.
«La letteratura, per me, non è un’illustrazione ma una presenza. Kafka, Beckett, Hölderlin, Achmatova: non li considero come materiali da “mettere in musica”, ma come voci che agiscono dall’interno. Esistono opere che non sono nemmeno concepite per essere eseguite, ma per essere lette. A volte ho la sensazione che un testo funzioni come un messaggio, più che come un oggetto musicale».
Ha atteso anni prima di comporre «Fin de partie», che ha portato in prima assoluta al Teatro alla Scala nel 2018.
«Ricordo che la prima volta che vidi Beckett ero a Parigi e assistetti a Fin de partie. Capii pochissime cose, ma poi comprai il libro, e Ligeti mi telefonò per dirmi di andare a vedere Aspettando Godot. Da quel momento Beckett divenne la cosa più importante in assoluto per me. Amavo la brevità delle sue frasi e la loro assoluta precisione di formulazione».
La musica ha bisogno di maturare a lungo prima di venire alla luce?
«Ci sono opere che richiedono molti anni e altre no. Nel mio lavoro torno più volte sugli stessi pezzi, anche su opere molto brevi. Talvolta sono pienamente convinto che un’opera sia buona, e solo più tardi mi accorgo che non lo è. Altre volte accade il contrario. Il tempo non garantisce nulla, ma senza il tempo certe cose non possono accadere. Spesso comprendo davvero un’opera solo quando viene eseguita, o quando la riprendo dopo anni. Succede anche che, tornando su un pezzo, abbia l’impressione di non capire più ciò che avevo in mente all’epoca».
Torna in mente una frase di Arvo Pärt: «A volte bisogna aspettare a lungo prima che la musica arrivi». Lei cerca la musica o «attende» il suo arrivo?
«Non la cerco in modo attivo. La ascolto di continuo e ciò che resta in me può tornare anche dopo molti anni. Anche ciò che credo di aver completamente dimenticato, può riemergere. Quando ascolto, non mi colloco dietro il compositore per analizzarlo: sento la musica sotto la pelle. Se qualcosa deve tornare, tornerà».
Nei suoi brani ci sono momenti in cui tutto sembra scorrere in una direzione, ma poi, a un certo punto, emergono situazioni inattese. Che spezzano. Eppure alla fine tutto sembra funzionare in modo naturale. Istinto e regole insieme?
«All’inizio c’è sempre qualcosa che vuole nascere. Il mio ruolo è non ostacolarlo. Il lavoro cosciente viene dopo. Mia moglie Márta svolgeva un ruolo fondamentale in questo processo: aveva un senso molto acuto delle proporzioni e della direzione. Sapeva dire quando qualcosa era eccessivo, quando diventava prolisso, quando deviava e perdeva freschezza. Talvolta il caso interviene in modo decisivo. Ma può farlo solo se si è pronti ad accoglierlo».
Quando la sua musica contiene dei testi, questi ne influenzano la struttura?
«Sì, ma non in modo lineare. Talvolta ometto dei versi, talvolta li ripeto, talvolta li reintroduco persino quando l’opera sarebbe più equilibrata senza di essi. Non seguo regole fisse. Il testo non determina la struttura dall’esterno. Entra nel processo compositivo e lo modifica dall’interno. Anche quando una scelta mi appare cosciente, so che potrebbe essere sbagliata. Ma è comunque quella che l’opera richiede in quel preciso momento».
Ha insegnato musica da camera, pianoforte, ma mai composizione. Una volta ha detto che avrebbe voluto insegnare lo scetticismo. Che cosa intendeva?
«Insegnare mi obbliga a pensare. Se ho tempo, non penso: studio, lavoro, faccio. Quando insegno, si mette in moto un meccanismo che mi costringe a interrogarmi. È allora che imparo qualcosa sui miei stessi pensieri. Lo scetticismo, per me, non è diffidenza, ma resistenza alle soluzioni facili. Se qualcosa funziona troppo facilmente, probabilmente non è giusto. Bisogna meritare ogni cosa».
Che ruolo ha avuto sua moglie?
«Márta era il mio Super-io. Possedeva, come ho detto prima, un senso naturale delle proporzioni e della direzione. Il nostro lavoro comune non riguardava solo l’esecuzione o l’insegnamento: era un modo condiviso di abitare la musica, fino in fondo. Se vi si resta intorno, non funziona. Nella musica bisogna esserci sia fisicamente che interiormente».
Ci parli del suo amico György Ligeti. Vi siete conosciuti nel 1945 all’esame di ammissione al Conservatorio?
«Sì, a Budapest. Lui mi ha guidato per tutta la vita. No, devo correggermi subito: sono io che l’ho seguito, talvolta immediatamente, talvolta con qualche anno di ritardo, persino decenni. Ma — la chiamo la sindrome dell’imitatioChristi — i primi anni della nostra amicizia non furono influenzati solo dalla sua guida spirituale. Senza esserne influenzato immediatamente, ho orientato i miei gusti, e persino i passi che ho compiuto nella mia vita privata, secondo il suo esempio. A partire dal 1946-1947, mia moglie ed io avevamo problemi di passaporto e ci trasferimmo per 5 anni a casa di una zia, in una stanza di servizio, quattro metri per due. Per un periodo veniva anche Ligeti».
Un ricordo insieme?
«Ogni domenica sera facevamo musica a casa. Cantavamo opere di Mozart: Márta cantava tutti i ruoli femminili, Ligeti faceva il tenore e talvolta anche il baritono. Il nostro amico e compositore Ferenc Sulyok — eravamo insieme in classe di composizione — faceva il basso. Io suonavo al pianoforte le parti d’orchestra».
Ha avuto un bel rapporto con l’Italia.
«L’Italia è stata importante per me. In particolare Assisi e Firenze. Ricordo un sogno in cui cercavo disperatamente il centro di Firenze, ma a un certo punto capivo che non ha un centro vero e proprio».
E Assisi invece?
«Ad Assisi sono rimasto profondamente colpito dal San Francesco di Cimabue. È un’immagine che per me non è mai stata solo pittura, ma una presenza: qualcosa che resta e lavora in silenzio, come accade spesso anche nella musica. A Firenze, invece, ricordo l’ascesa al campanile di Giotto. Salire quei 414 gradini all’età di ottant’anni non è stato un gesto simbolico, ma un’esperienza fisica molto concreta: fatica, respiro, concentrazione. Sono cose che conosco bene anche nel lavoro musicale».
Ha insegnato alla Scuola di musica di Fiesole. Come fu quell’esperienza?
«Un luogo per me fondamentale è stato anche Fiesole, grazie a Piero Farulli e alla Scuola di Musica che aveva fondato. Sono stato invitato più volte a insegnare musica da camera. Farulli aveva un’idea dell’insegnamento come pratica viva, rigorosa e condivisa: qualcosa che si trasmette facendo, non spiegando».
C’è stata anche Milano poi…
«Un ruolo decisivo lo ha avuto Milano Musica, in particolare Luciana Pestalozza (1929-2012; sorella di Claudio Abbado, ndr), un’amica importante. La sua intelligenza musicale e la sua attenzione reale nei confronti degli artisti hanno avuto un significato molto profondo per me».
Ci dice dell’amicizia con Luigi Nono?
«Un’altra amicizia fondamentale è stata quella con Luigi. Mi ha aiutato molto. Ci incontrammo a Budapest, brevemente, ma nacque un’amicizia che si è poi materializzata nel mio Omaggio a Luigi Nono op. 16 e nel suo Omaggio a György Kurtág. Anche se i nostri percorsi erano diversi e indipendenti sotto molti aspetti, ci siamo riconosciuti in una stessa attenzione per la scrittura frammentaria. Per me il frammento è un elemento autonomo, autosufficiente; per Nono era un modo per spezzare il corso lineare degli eventi. In entrambi i casi, si trattava di resistere al discorso continuo, alla totalità chiusa».
Quando vi siete visti l’ultima volta?
«A San Pietroburgo, dopo la caduta del Muro di Berlino. Ricordo che parlò del dovere dei giovani di continuare la lotta. Non uno slogan, ma responsabilità etica».
Che cosa vi ha legato profondamente?
«Tra le figure che ci hanno accompagnato, cito Achmatova, Rimma Dalos, Hölderlin, Kafka. E Tarkovskij: penso spesso alla scena della candela in Nostalghia, un’immagine che per me dice molto dell’esistenza artistica, del rischio, della concentrazione necessaria. E poi Nono mi presentò Claudio Abbado: negli anni 1993–94, a Berlino, ho lavorato con lui per il mio Stele (e per il bellissimo Grabstein für Stephan, Op. 15c, ndr). Fu un’esperienza intensissima».
Altri compositori italiani?
«Salvatore Sciarrino e Franco Donatoni. In modi diversi, hanno rappresentato per me una forma di rigore e di libertà».