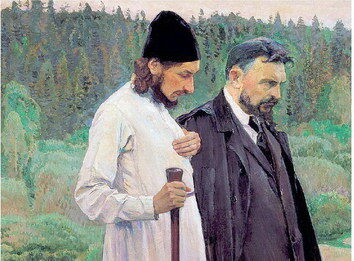La filosofia della natura nel giardino dell’arciduca Massimiliano
8 Gennaio 2023
« Terminus Malaussène » : Daniel Pennac libère son bouc émissaire
8 Gennaio 2023«Una collezione è una raccolta di storie», scrive Sam Stourdzé nel catalogo della mostra, aperta fino al 26 febbraio, Collection: 150 photographies de la collection Bachelot à la Villa Médicis, da lui curata all’Accademia di Francia a Roma, dove si è insediato come direttore da ormai circa due anni. E le storie di certo non mancano di palesarsi agli occhi del visitatore, a cominciare dalla storia della collezione stessa, raccolta messa insieme dai coniugi Florence e Damien Bachelot – fondatore, quest’ultimo, della società finanziaria Aforge Finance – cominciando quasi per caso da un’asta di stampe fotografiche organizzata da Hachette Filipacchi Médias nel novembre 2004. Da allora, complice la discreta curatela di Stourdzé, indagatore del mondo delle immagini conosciuto proprio in quell’occasione, la collezione si è ampliata seguendo la passione e l’istinto dei Bachelot, liberamente, ma conservando una forte coerenza di fondo derivata dalla preferenza per la fotografia humaniste francese, e per le sue mutazioni oltreoceano, senza trascurare alcuni episodi presi dal panorama europeo.
E chiaramente le storie diventano qui quelle catturate dai tanti autori rappresentati che si calarono nel flusso della realtà per intrappolare in una buona composizione umani còlti nelle più disparate attività, complice, talvolta, il caso. Sulla scia di quel ritorno a una autenticità della relazione della fotografia con il soggetto umano, descritto da Walter Benjamin nella sua Piccola storia della fotografia del 1931, è altresì inevitabile che emerga da queste storie anche un interesse sociale, oltre che formale e antropologico, testimoniando il trasformarsi del mondo dal dopoguerra alle ultime emergenze umane (vedi ad esempio la parte finale della mostra dedicata a Laura Henno e al suo lavoro sulle migrazioni clandestine).
Se i fotografi umanisti francesi – e la sezione photographie humaniste è retta da nomi d’eccezione, tra cui quelli di Brassaï, Cartier-Bresson, Doisneau, Sabine Weiss risuonano quasi mitici – riportavano brani di umanità di una Francia faticosamente sopravvissuta dal buco nero della seconda guerra mondiale, più o meno contemporaneamente i colleghi americani della Photo League non solo dimostravano che la nazione degli immigrati, gli Stati Uniti, era diventata a pieno titolo una nazione di fotografi, ma fornivano indizi su quelle criticità sociali che, già elefanti nel salotto statunitense, sarebbero cresciute proporzionalmente alla forza con cui si cercava di ignorarle o di nasconderle. Non a caso la Photo League venne accusata di essere una organizzazione comunista e anti-americana, e fatta chiudere nel 1951, ma senza riuscire a fermare questa ondata di fotografia umanista all’americana, e basta soffermarsi sull’accusato di Dorothea Lange, o sui manifestanti alle marce da Selma a Montgomery di Mike Smith, o sul ragazzo afroamericano con la pistola di Helen Levitt, per avvertirne la tesa preoccupazione sociale.
Altre storie americane verranno poi narrate dai fotografi della controcultura, che tra anni sessanta e settanta scrutarono acutamente nelle ombre di un’America profonda, pulsante e a volte non del tutto decifrabile: si va dallo scatto con la famiglia afroamericana a Harlem, ritratta da Bruce Davidson a ridosso del Civil Rights Act, ai cittadini omaggianti il treno funebre di Robert F. Kennedy nel 1968, ripresi dal treno stesso da Paul Fusco, fino al giovane sostenitore della guerra in Vietnam con tanto di paglietta e spilletta «Bomb Hanoi», colto da Diane Arbus nel 1970 in tutta la sua glaciale convinzione.
Ma c’è un’altra storia molto forte dietro a questa collezione, e a questa mostra, e non riguarda uomini ma più strettamente il medium fotografico nella sua essenza, ed è la storia di un ritorno alla materialità della fotografia che ci appare oggi sensazionale. Di fatti il mirino collezionistico dei Bachelot, e di Stourdzé, ha cercato tenacemente la qualità e la storicità delle stampe fotografiche. Del resto la collezione è nata proprio da aste di stampe fotografiche, dismesse nell’era della corsa alla digitalizzazione delle immagini dei primi anni duemila. Proprio oggi che della fotografia, già priva dell’aura benjaminiana, è stata compromessa la credibilità stessa, il suo valore di prova del visto, la presenza di una stampa cartacea riaccorcia quella distanza tra immagine e verità che è diventata così liquida e inafferrabile nell’era delle manipolazioni digitali. Inoltre, le stampe stesse hanno una loro storia come oggetti, e come tali sembrano quasi recuperare una sorta di aura: Lella (1948), di Édouard Boubat, potrebbe essere una delle tante stampe vintage in circolazione, eppure è l’esemplare che il fotografo stesso tenne con sé tutta la vita, e per questo viene considerata nelle stesse parole dei Bachelot come «la più vicina all’opera originale dell’artista, la sua rappresentazione storica e artistica più autentica».
Una storia similare riguarda le cromaticamente suntuose stampe Cibachrome del pittore e fotografo di moda Saul Leiter – realizzate per sé e tenute private, e riscoperte solo negli anni novanta dal gallerista Howard Greenberg – in cui l’occhio del fotografo inquadra stralci di un mondo che sembra già inconsciamente incorniciare se stesso, nascondendosi o svelandosi dietro una finestra, attraverso una tenda o incorniciato da un pertugio inatteso. È questo episodio forse l’unica deroga all’altrimenti coerentissimo filo conduttore della collezione, apparendo gli uomini e le donne nelle foto di Leiter non come soggetti sociali, individui con cui empatizzare umanamente, ma quasi come semplici contributi alla dimensione estetica e pittorica delle composizioni.
Partiti dall’interesse primario verso la Francia, i Bachelot hanno avvicinato la fotografia americana, stimolati dai propri viaggi e spostamenti, ma non manca una sezione europea dove si possono trovare lavori di fotografi inglesi, belgi, italiani, cechi, nei cui lavori l’umanismo prende la forma ora delle stranianti composizioni documentaristiche di Chris Killip, ora delle introspezioni sussurrate e dimesse dei nostri Ghirri e Giacomelli, ora dei subitanei e ficcanti sguardi reportagisti di Gilles Caron. Proprio attraverso l’occhio di quest’ultimo si svela uno sguardo in cui la responsabilità di testimoniare i mutamenti sociali e politici diventa una questione urgente, improrogabile, che lo spingerà a essere presente negli ultimi anni sessanta sui più caldi scenari mondiali – Irlanda del Nord, Guerra dei sei giorni in Israele, Vietnam, Biafra, Parigi, e la Città del Messico dei moti studenteschi, la Cecoslovacchia nell’anniversario della Primavera di Praga – fino a scomparire, appena trentenne, sulla strada che univa il Vietnam e la Cambogia di Pol Pot e degli Khmer rossi. E siamo nel reame del fotogiornalismo, dove il fotografo, dopo essere stato flâneur, street photographer, osservatore sociale, s’interroga sulla correttezza morale del rimanere un semplice sguardo senza intervenire (e un ricordo va al tragico episodio del suicidio del reporter Kevin Carter, non presente in mostra).
È una terra di confine la fotografia della Collezione Bachelot, in cui le storie possono venire cercate o si può essere sorpresi da quelle, spesso in bilico tra ricerca formale, intervento del caso e significato sociale dei soggetti, fino al raggiungimento di quel punto in cui, rubando le parole a Susan Sontag, per i fotografi non c’è differenza tra lo sforzo di abbellire il mondo e quello di strappargli la maschera.