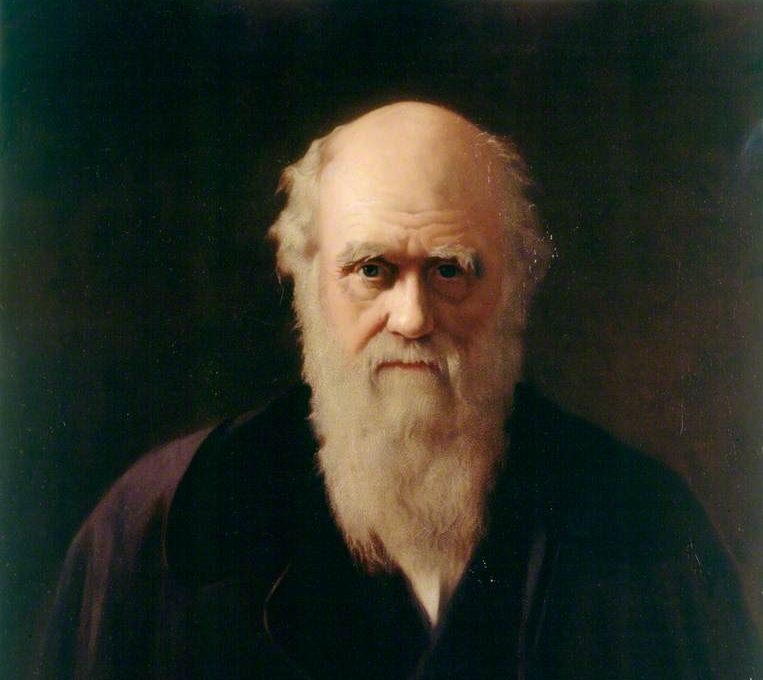«I ragazzi vogliono mettersi in gioco, ma servono politiche nuove»
2 Dicembre 2023
Paco de Lucia – Entre dos aguas
2 Dicembre 2023Di nome la conoscono pressapoco tutti. Un sondaggio tra l’empirico e il casereccio condotto anni fa tra gli iscritti al Dams di Roma Tre e i loro familiari conseguì un ri-sultato sorprendente: nessuno ignorava chi fosse e quale mestiere avesse esercitato Maria Callas.
Se poi dal generale passiamo al particolare e ci volgiamo ai consumatori d’opera lirica – per passione, predominante o una delle tante, o per più modeste ragioni di convenienza sociale –, è probabile che sulla Callas cantante costoro nutrano una quantità di convinzioni e certezze. La maggior parte delle quali prive di fondamento.
Scopo del presente articolo è smontarne alcune, di quelle macroscopiche.
Cominciamo dalla più inveterata: la carriera breve. Se all’attività internazionale continuativa (1947-60), condotta per qualche tempo a ritmi vertiginosi, sommiamo l’intenso periodo ellenico (1942-45), il risultato sono sedici anni di esibizioni pubbliche, seguìti da altri quattro-cinque disseminati di concerti e rare rappresentazioni teatrali. Molte celebrità canore dell’Otto e Novecento non hanno calcato le scene più a lungo, alcune anche meno, si pensi – tanto per dire – alla Colbran, a Nourrit, alla Falcon, alla Strepponi, alla Lind, alla Ponselle, alla Dessay e, soprattutto, a Giuditta Pasta, il paragone con la quale (in uno con Maria Malibran) è divenuto un passaggio obbligatorio della pubblicistica callasiana sin dai tempi di Eugenio Gara, primo e forse massimo turiferario della nostra centenaria. E, a dirla tutta, gli anni buoni nelle parabole dell’illustre rivale Renata Tebaldi o di colleghi odiosamati quali Fedora Barbieri, Di Stefano, Del Monaco superarono forse di molto la diecina? (qui non si fa questione di gusto o di stile, ma solo di salute vocale).
Viene poi il tema della vociaccia (copyright, pare, Tullio Serafin, principale guida professionale della Callas). Brutta voce, che vuol dire? Secondo Reynhaldo Hahn (il grande amico, e amante, di Proust era compositore, pianista, direttore d’orchestra e… tenore) «la voce è importante, ma la sua è un’importanza del tutto secondaria. Una bella voce, infatti, non è necessariamente compatibile con l’istinto del canto». Se posso essere sincero, a me i timbri benedetti dal Cielo, quando non siano corroborati da tecnica o facoltà espressive eccezionali (Di Stefano, Gianni Raimondi, Domingo, la Ricciarelli nel primo caso, la Sutherland, la Nilsson, persino la Freni tanto nomini nel secondo), uggiano. Ma si lascino da parte le predilezioni personali, per soffermarci in primo luogo sull’immediata riconoscibilità del timbro della Callas; in secondo, sulla capacità tutta sua di plasmarlo e modificarlo (al limite, di deturparlo) in rapporto al personaggio e alla situazione di volta in volta interpretati. Stando a un commentatore d’epoca, il giornalista Emilio Radius: «La voce della Callas è brutta con arte, cioè esteticamente, artisticamente giusta; e quindi bella non in sé e per sé, ma in rapporto al valore della parte».
Per chi come la Callas lavora su estensioni molto divaricate (quasi tre ottave: per l’esattezza, dal fa diesis sotto il rigo al mi sopracuto), la norma scolastica, e assai più novecentesca che ottocentesca, dell’omogeneità tra i registri rimane una chimera. Inoltre, come chiosa Eugenio Montale (il poeta laureato era anche critico musicale, invero non dei più compiacenti verso il soprano greco-statunitense): «Non è che avesse due o tre voci, come si è affermato. Ogni cantante, dopo una certa carriera, sa bene di averne avute altrettante». Montale si riferisce senza dubbio alcuno alla voce (al colore, al volume, all’estensione) che muta nel corso degli anni.
La cosa vale anche per la Callas: è sotto gli orecchi di tutti come dopo la cura dimagrante del 1953-54 il registro centrale sia smagrito del pari, e altrettanto la mole della voce. Ma, fatto assai più significativo, con la Callas le due o tre voci operano spesso in simultanea, nel corso dello stesso spartito, se non della stessa scena o pezzo chiuso. Sempre secondo Hahn, «il canto è bello se significa qualcosa»; a tal fine si deve ogni volta escogitare «non tre, quattro, cinque sonorità, ma dieci, venti, trenta; occorre poter modellare la voce all’infinito, facendola passare attraverso tutti i colori del prisma sonoro».
Non esiste, pertanto, la voce della Callas, esistono le sue voci. Le quali, a loro volta, non sono in numero illimitato, ma possono essere ordinate sulla base della tipologia dei personaggi: l’essere soprannaturale, maga strega sacerdotessa guerriera regina spietata (Abigaille, Lady Macbeth, Medea, momenti di Armida, Norma e Carmen), centrato sui suoni di petto, su vibrazioni bronzee; l’eroina tragica greco-romana in panni neo-classici (Alceste, Ifigenia, Giulia), dall’impasto brunito ma terso; la fanciulla fragile indifesa alienata (Amina, Elvira, Lucia, le scene di pazzia di Anna Bolena e Imogene), emissione alleggerita e colore incorporeo, lunare, scossi però da repentine catabasi nell’oscuro, emblemi degli sbandamenti mentali; la femmina sicura di sé, lieve ma acuminata, nelle parti comiche (Fiorilla, Rosina); la nobildonna segnata da inquietudine nervosa e angoscia al limite del delirio (le protagoniste verdiane 1850-70); la voce borghese (per le opere della Giovane scuola), che in genere compie un percorso da gradazioni lievi a sonorità rinforzate, da un’ingenuità fidente alla consapevolezza d’un ineluttabile destino di morte (nella Traviata, dalla critica del tempo e dalla stessa Callas sentita come presagio del Verismo, Violetta fa il tragitto opposto, dalla pienezza all’attenuazione più radicale). E negli anni migliori (1949-53, vertice il biennio ’51-’52), le varie voci non erano né belle né brutte; semplicemente sfioravano l’onnipotenza.
«Il suo avvento ha rinnovato il repertorio: tutto un tipo di opere fino a ieri considerate morte o ineseguibili [Rossini serio, Bellini, Donizetti, ecc.] è stato riqualificato dalla sua esperienza» (Fedele d’Amico); ella ha condotto a effetto «una rivoluzione musicologica, più ancora che vocale» (Rodolfo Celletti). Tutto vero; senza dimenticare, però, che 1. nei titoli di repertorio la Callas, sorda alle sirene della filologia musicale, accettava tagli e varianti di tradizione; 2. i lavori ignoti o rari da lei riesumati (talvolta per pochissime recite) non superano, come numero, quelli eseguiti dalla Tebaldi.
Serafin insisteva con l’allieva sulla congruenza tra canto e gesto, e la Callas acquisì una perizia scenica rara per i tempi. Ma provocò un rivolgimento anche in questo àmbito? Uno spettatore d’eccezione, Luca Ronconi, lo nega: «ha nobilitato e affinato un cliché, non ha inventato alcunché di nuovo. Viceversa, sul piano musicale era un’altra cosa, un altro mondo».
Potrei andare avanti a lungo: sulla (presunta) carenza di sensualità; sulla (presunta) estraneità al comico, e così via. Ma il mio spazio è finito. Meglio allora concludere segnalando la concezione, estetica e etica a un tempo, aristocratica, sacrale anzi, che la Callas aveva della propria arte. Cantante vetero-moderna, interessata solo alle opere del passato (non interpretò mai lavori a lei contemporanei, tranne che negli anni greci) ma smaniosa di renderle attuali vive urgenti (oltre che di pervenire alle misure di una diva new fashion come Audrey Hepburn), non era cólta, tanto meno simpatica. Borghese spilorcia e reazionaria, sempre pronta a prendere dagli altri nella vita di ogni giorno, nella vita vera, quella dei «pazzi teatri», ha dato tutto quello che aveva e poteva.
Era così tanto che i suoi effetti benefici e nutrienti durano tuttora. Integri.