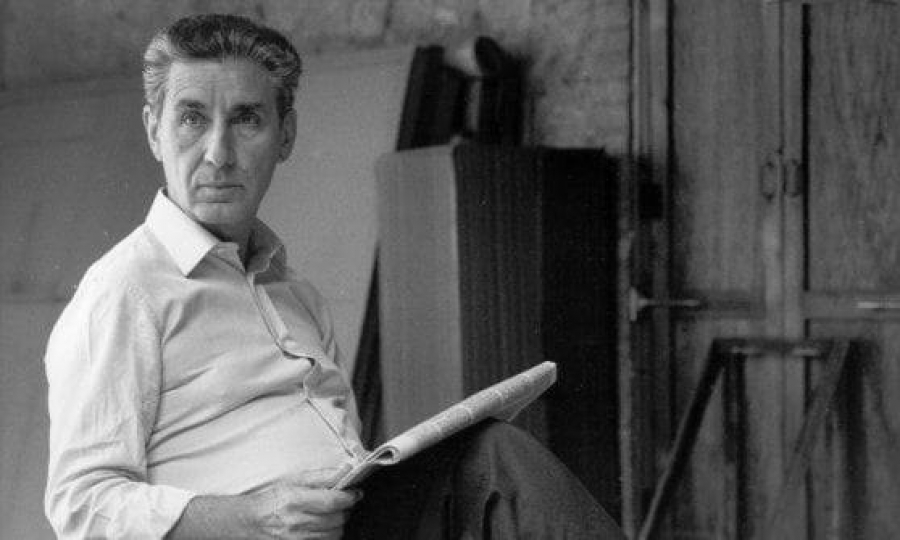
Quantità e qualità
24 Ottobre 2022
Sandbag sculpture: how Kyiv is shielding statues from Russian bombs
24 Ottobre 2022Ci vorrebbe il Cyrano di Guccini per infilare oggi la penna ben dentro l’orgoglio dei protagonisti del defunto campo progressista. Quelli che, col loro sguardo corto, narcisismi vari e piccoli cabotaggi di carriera, già a luglio hanno accettato che Giorgia Meloni diventasse premier. E ora si sbranano per le briciole di potere rimaste, un vicepresidente, un questore, un posto al Copasir.
Li osserviamo in questi giorni commentare i nuovi presidenti delle Camere, i ministri, l’informata di reduci dell’Msi, di bigotti, e le Santanché che arrivano al potere. E alzare il sopracciglio un poco disgustati. E usare il solito linguaggio incomprensibile, «deriva polacca», o ungherese, o deficit di atlantismo, o di presentabilità. Ma la colpa è loro, dovrebbero non dormirci la notte, invece di scalpitare per fare le smorfie nei talk show, una gara tra le opposizioni più «intransigenti» e «dure» o qualche altro aggettivo a perdere.
Perché tutto questo si poteva evitare. A luglio, quando Draghi ha colto la palla al balzo per lasciare una postazione dove non voleva più stare. Ha sbagliato Conte, per primo, perché non ha capito che nessuno (meno che mai una destra già vincente nei sondaggi) gli avrebbe concesso di starsene sei mesi all’opposizione per rigenerarsi. Ma ha sbagliato soprattutto il Pd, e non solo Enrico Letta, vaneggiando di agenda Draghi, e rinunciando all’unico alleato che avrebbe potuto servire a fermare la destra nei collegi, almeno da Roma in giù.
Letta ha sbagliato di più, ma anche tutti gli altri che hanno balbettato e poi hanno votato all’unanimità il suicidio politico. Anche quelli che ora riparlano di alleanza, domani, o forse il giorno dopo, magari tra 5 anni, chissà. Erano divisi su Draghi e sulle armi all’Ucraina. E allora? Meloni si porta al governo l’amico del «dolcissimo» Putin e l’ex padano che portava il leader russo sulle magliette. E gli americani, molto più pragmatici dei loro fans italiani, se ne sono già fatti una ragione e annunciano collaborazione.
Da noi no, dem e contiani continuano a beccarsi come i capponi di Renzo, a sognare di fregarsi due punti percentuali nel prossimo sondaggio virtuale. E intanto Meloni arriva a palazzo Chigi col suo contorno di gente che il potere l’ha sognato per una vita, o l’aveva perduto lustri fa e ora per miracolo lo ritrova.
E i capponi? Litigano, vaneggiano di «congresso costituente», probabilmente inconsapevoli della rabbia che monta contro di loro. Perché gli italiani di centrosinistra lo sanno benissimo chi sono i responsabili, sanno che Meloni ha preso solo il 26% e la coalizione di destra gli stessi voti di 4 anni fa. Nessuno sfondamento, solo un uso intelligente della legge elettorale. Ma i sedicenti progressisti non si scusano nemmeno, tirano dritto, danno le pagelle, pronti (i dem) per un nuovo giro di giostra in un congresso che non cambierà nulla.
Nessuno di loro, tranne qualche cane sciolto, può dire di aver provato a fermare il treno che andava verso il burrone. Tutti zitti e buoni, in attesa che il leader scegliesse quelli da mettere in lista. Convinti di prendere voti al Nord sull’eredità di Draghi e candidando Cottarelli.
Conte invece non si era fatto nessuna illusione, tranne quella di avere un risultato che gli consentisse di sopravvivere. E ora lancia la sua opa sulle macerie del Pd, che la traversata duri due anni o cinque a lui non importa. Come pare non importare a nessuno quello che questa destra farà alla carne viva del Paese dal ministero delle «imprese», da cui scompare il concetto stesso di «lavoratori». O da quello della «natalità» che darà botte ai diritti delle donne. O da quello del «merito» pensato per sfregiare la scuola pubblica. Troppo facile accomodarsi adesso nei salotti a dire «che orrore». Si spera almeno che domani, quando Draghi passerà la campanella a Meloni, il caffè vada di traverso a tutti loro.





