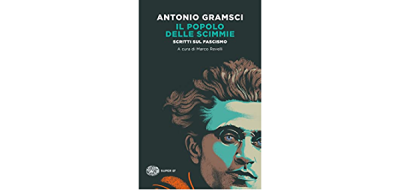Edouard Louis: “Io, Ken Loach e la classe operaia”
7 Giugno 2022
Chiedimi se sono felice – Samuele Bersani
7 Giugno 2022È nota la rilevanza dell’interpretazione dei fascismi di Gramsci. Fascismi al plurale, non solo perché sono stati molti e diversi, ma anche perché lo stesso fascismo italiano ha attraversato fasi distinte, che il pensatore sardo si è sforzato di cogliere nei loro tratti peculiari. Quella gramsciana è dapprima un’interpretazione in presa diretta del movimento fascista al suo sorgere, per concentrarsi poi sulle diverse trasformazioni che subisce per arrivare al potere e quindi per «farsi Stato». Fu Enzo Santarelli il primo, a inizio anni ’70, a offrire una selezione gramsciana in grado di mostrare tale percorso, anche interpretativo, dalla Grande guerra ai Quaderni. A distanza di molti anni, Marco Revelli ripropone ora buona parte di quelle riflessioni, precedute da una sua impegnata Introduzione, nel volume: Antonio Gramsci, Il popolo delle scimmie. Scritti sul fascismo, a cura di Marco Revelli (Einaudi, pp. 213, euro 13).
ARTICOLI E BRANI scelti da Revelli sono particolarmente numerosi per gli anni 1920-1921 e 1924, ma giungono fino alle Tesi di Lione, alle Discussioni nel carcere di Turi e agli stessi Quaderni, anche se la scelta da questi ultimi è necessariamente limitata rispetto alla mole delle note interessanti sull’argomento.
Cosa è Il popolo delle scimmie di cui parla Gramsci nei primi anni ’20? La destra del Novecento si distingue dai movimenti reazionari del secolo precedente perché deve ripensarsi all’altezza della società di massa, deve cioè cercare di organizzare le masse e ottenerne in parte l’appoggio. Come è noto, l’analisi di Gramsci è in un primo tempo centrata sulle masse piccolo-borghesi, messe in crisi dalla guerra e dal dopoguerra, che forniscono al movimento di Mussolini la prima leva per combattere il movimento socialista e mutare i rapporti di forza.
Il comunista sardo riflette su questi elementi, con osservazioni acute relative al ruolo giocato dalla «cattiva» unità nazionale alle spalle, dalla Prima guerra mondiale e appunto dalla piccola borghesia alla riscossa, paragonata a quelle scimmie che nella novella di Kipling erano pericolose quanto ridicole e in fondo stupide. Su questi aspetti certo non secondari si concentra soprattutto Luca Cangemi, curatore di un’altra raccolta sullo stesso tema, destinata a un pubblico giovanile (Antonio Gramsci, Contro il fascismo nascente, Lunaria, pp. 143, euro 13). E in parte Christian Raimo, che però allargava lo sguardo – nell’antologia in e-book curata un paio di anni fa (Il metodo della libertà. Scritti sulla democrazia, il fascismo, la rivoluzione, Euridice, euro 4,99) – anche su aspetti diversi della riflessione gramsciana degli anni ’20.
Tuttavia va detto che Gramsci capì presto come il fascismo fosse cosa più seria del «popolo delle scimmie». Se ancora al tempo della Marcia su Roma (si veda il breve articolo scritto a Mosca per la Pravda del 7 novembre 1922, da poco ritrovato e pubblicato dalla rivista Critica Marxista lo scorso anno) egli riteneva che il movimento mussoliniano fosse dominato da agrari e piccolo-borghesi, pian piano gli fu chiaro il tentativo del fascismo di unificare per la prima volta tutta la borghesia italiana, dandole rappresentanza politica unitaria – come afferma il Togliatti delle Lezioni sul fascismo, opportunamente ricordato da Revelli –, per costruire a muovere da ciò un nuovo tipo di Stato e di società.
NON SONO DUNQUE da trascurare gli altri momenti della analisi gramsciana, riguardanti il tentativo mussoliniano di ripensare – con l’ausilio di importanti intellettuali – l’impalcatura istituzionale e sociale dello Stato. Non è un caso che una ricognizione in questa direzione ci sia offerta da un attento studioso dei Quaderni come Fabio Frosini con il recente La costruzione dello Stato nuovo. Scritti e discorsi di Benito Mussolini 1921-1932 (su cui ha scritto Claudio Vercelli su queste pagine lo scorso 7 maggio).
Dopo avere infatti puntato inizialmente l’attenzione sul tema della violenza e sul ruolo della piccola borghesia, e poi sulle contraddizioni interne ai «due fascismi», cittadino e agrario, già prima dell’arresto ma soprattutto in seguito, nel chiuso di un carcere fascista, Gramsci coglie gli aspetti innovativi e meno folclorici, più incisivi, del fenomeno: una particolare accezione di «cesarismo» (su cui Revelli si sofferma), la «questione sindacale», il corporativismo, una ipotesi di rivoluzione passiva come risposta alla rivoluzione bolscevica. Nel primo dodicennio del regime fascista, in altre parole, viene progettata una nuova architettura istituzionale, rinnegando tra l’altro l’originario credo liberista professato da Mussolini (che aveva indicato in Pareto uno dei suoi maestri), in favore di uno Stato interventista, «che prevede e provvede». A partire dal 1933, però, lo Stato mussoliniano prenderà un’altra via, rotolando verso la rovina, sua e del Paese.
IL TENTATIVO AVANZATO in precedenza, e per qualche aspetto proseguito anche in seguito (si pensi alla costituzione dell’IRI), era per molti versi innovativo, cercando di adeguarsi a una società caratterizzata ormai dall’attiva presenza delle masse, che si voleva organizzare per meglio averne il controllo: «o voi immettete il popolo nella cittadella dello Stato – afferma Mussolini nel 1927 –, ed egli la difenderà; o sarà al di fuori, ed egli l’assalterà». Del resto politica, economia e società trovano nella prima metà del secolo scorso forme nuove di rapporto in tutti i tipi di governo o regime che reagiscono alla crisi dello Stato liberale: dal bolscevismo ai fascismi, dalle socialdemocrazie al new deal. In Italia, nota Revelli, la novità assume il peculiare tratto determinato dall’impatto dei processi di razionalizzazione su una persistente «arcaicità sociale»: una chiave di lettura da non trascurare.
Gramsci fu tra i primi, soprattutto in campo marxista, a cogliere l’insieme di questi processi di nuovo rapporto tra politica e società che avrebbero profondamente segnato il secolo scorso, ma che poté vedere solo in parte.