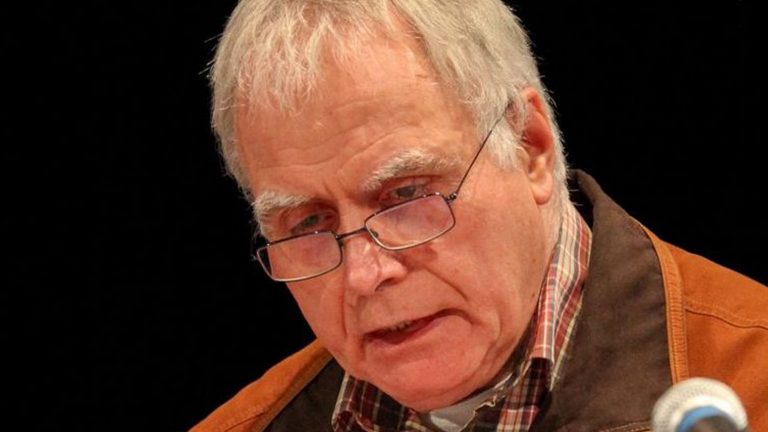È dannoso fomentare nelle piazze europee faziose tifoserie: abbiamo il compito di scongiurare il disastro
Fantasma contro fantasma, incubo contro incubo si aggirano per le terre martoriate del Medioriente. Alla guerra sul terreno si sovrappone, nell’immaginario collettivo, quella del fantasma di un confronto che può condurre a un incendio più generale. Hamas non poteva sperare un risultato migliore per demolire, con un colpo solo, l’idea stessa di due stati che convivono in pace sullo stesso territorio sovrapponendovi quella jihadista della guerra santa e dell’antisemitismo. Nei primi giorni del suo attacco criminale si è creduto che quel massacro avesse, come unico obiettivo quello di fare saltare il ventilato accordo tra Israele e l’Arabia Saudita , con il timore che si trattasse di una pace separata che escludeva i palestinesi. Ma la natura stessa degli immondi massacri compiuti da Hamas ci dice che c’era anche qualcos’altro. Che non riguardava il semplice ragionamento geo-politico. L’obiettivo di fondo era quello di rendere impossibile ogni soluzione di pace, di provocare quel rigurgito di risentimento e di vendetta che cova da più di un secolo in quella regione martoriata. Lo stesso bersaglio prescelto lo dimostra. Colpire, uccidere, sgozzare, rapire uomini, donne, bambini e neonati, in gran parte pacifisti e aperti al dialogo con i palestinesi, voleva dire in modo macabro: «Non ci sono tra di voi buoni e cattivi. Noi vogliamo la morte di tutti gli ebrei». Benyamin Netanyahu ha risposto con l’obiettivo, di per se plausibile e legittimo, di liberare l’area dal dominio di Hamas. Che però, per ora, si è risolto nella distruzione di città, villaggi e nella catastrofe di migliaia di vittime che muoiono sotto le bombe e che languiscono, in attesa del cataclisma, subendo il taglio di elettricità, petrolio e cibo. Inoltre l’ordine di Israele di evacuare la popolazione di Gaza verso il sud del Paese ha rievocato antiche paure. Molti osservatori, commentando le immagini di centinaia di migliaia di palestinesi in fila sulle strade, piegati sotto il peso di materassi, utensili, valigie e seguiti da figli terrorizzati, hanno risvegliato lo spettro della grande espulsione del 1948, che i palestinesi chiamano la Nakba. Nell’immaginario e nel Dna collettivo dei due popoli riemergono due incubi contrapposti: la Nakba dei palestinesi e la Diaspora degli israeliani.
Si è venuto così a formare in molte coscienze un nodo di equivoci, una sovrapposizione di piani che diventa sempre più difficile sciogliere. Non resta altra via che tagliarlo con la lama della ragione e della proposta. Sul piano storico, e anche al fine di trovare una via d’uscita, è del tutto doveroso ricordare, come ha fatto il Segretario generale dell’Onu, il contesto delle responsabilità che hanno alimentato la tragedia in corso. Purché si riaffermi sempre con chiarezza che la responsabilità immediata è di Hamas e non va, per nessuna ragione, giustificata. Sul terreno della passione e del cordoglio ci si può immedesimare nell’odio e nelle paure di tutti e due i popoli. Ciascun atto nefasto può essere vissuto, da ciascuno di noi, con la “compassione” che è dovuta a tutte le vittime, senza distinzioni. Quello che è dannoso fare è fomentare, nelle piazze europee, lo scontro tra diverse “martirologie”. Se vogliamo aiutare tutti e due i popoli a ritrovare la strada della reciproca comprensione spetta a noi, che non abbiamo subito le loro sofferenze, mantenere i nervi a posto, coltivare la lucidità di giudizio, non alimentare faziose tifoserie, mossi dall’unica vitale preoccupazione di trovare una via d’uscita. Sto parlando del destino dei popoli e non dei loro dirigenti. Questo è il vero aiuto che noi europei possiamo e dovremmo dare: quello di avere il privilegio di potere ragionare al di sopra dei reciproci odi al fine di scongiurare una generale “eclissi della ragione” che potrebbe diventare incontrollabile.
Va bene, va benissimo chiedere la cessazione del fuoco o le tregue umanitarie. A patto però che tali richieste non nascondano la tendenza a prendersi una pausa nelle faticosa ricerca di una soluzione. Va bene invocare una pace giusta e durevole a patto che ci si muova con decisione per imporre, senza compromessi commerciali, ai paesi arabi la rinuncia alla distruzione dell’“entità sionista” e agli israeliani quella dell’occupazione senza fine. Il nodo fondamentale da spezzare è il reciproco sostegno tra due fondamentalismi religiosi, quello che ispira l’ultra destra israeliana e quello dello jihadismo arabo, immortalato nella fotografia della “triplice alleanza del terrore” incarnata dai capi di Hamas, della Jihad islamica e degli Hezbollah. Lo ripeto, è del tutto evidente che i due popoli non potranno mai convivere sullo stesso territorio se saranno diretti da due opposti fondamentalismi che si fondano sulla reciproca distruzione.
Quello che si stenta ancora a focalizzare con la dovuta attenzione è che c’è stata una cesura drammatica nella “questione palestinese”. Unraccapricciante slittamento dal terreno di un laicismo di natura nazionale a quello di un progressivo fondamentalismo religioso che rischia di diventare maggioritario nella stessa Cisgiordania. La comunità internazionale, con la sua inettitudine, è essa stessa responsabile di questo slittamento. Si è perso un patrimonio umano e politico estremamente prezioso. Ho avuto modo di conoscere sul campo Simon Peres e Yasser Arafat, nel corso del mio primo viaggio in Medio Oriente da segretario del Pci. Non posso dimenticare la straordinaria apertura mentale di Peres e le parole dette da Arafat, parole che, viste oggi, mi paiono premonitrici. Mi ha detto rivolgendosi all’Europa: «Ho fatto tutto quello che l’Occidente in questi anni mi ha chiesto. Ora sta a voi rispondere positivamente». L’ho poi rivisto pochi anni dopo nella Striscia di Gaza, che, ormai in preda al pessimismo, mi ha sibilato sotto voce: «Se l’Occidente continua a non darmi una mano nella soluzione della questione palestinese, io non riuscirò più a governare “intifada” sempre più radicali ». Peres e Arafat erano due laici, aperti alla comprensione reciproca. Riuscirà l’Europa a riallacciare le fila di una tela così tragicamente spezzata? Bisogna comprendere c he occorre lavorare per trovare nuovi interlocutori capaci di comprendersi. E non lo si può fare mantenendo distinto il momento della forza da quello che Gramsci chiamava il momento dell’egemonia intellettuale e morale. È del tutto evidente che con Hamas si deve trattare per la priorità della liberazione degli ostaggi, ma non lo si può fare su una prospettiva di pace che, rispettando le risoluzioni dell’Onu, si fondi sull’esistenza di due Stati. A questo punto del mio ragionamento mi si risponderà che nel campo palestinese non esiste un interlocutore credibile. È vero. Tuttavia in tutte le guerre si è sempre pensato anche a dar vita a interlocutori credibili. Per questo Israele accanto alla forza dovrebbe coltivare quella egemonia intellettuale e morale che le permetterebbe di sconfiggere politicamente e non solo militarmente Hamas. E lo può fare prendendo decisamente nelle proprie mani la prospettiva dei “due Stati”. E cercando, in campo palestinese, i possibili interlocutori. Faccio un solo nome, esclusivamente a titolo di esempio. In una prigione israeliana sta da vent’anni languendo Marwan Barghouti, considerato da gran parte del suo popolo un Mandela palestinese, che nel 2002 ha dichiarato al Washington Post che «la strada sarà tracciata con chiarezza se i vicini indipendenti e uguali d’Israele e di Palestina potranno negoziare un avvenire pacifico tessendo stretti legami economici e culturali». Ricordo bene, per averne sentito parlare nelle mie visite alla striscia di Gaza, che, a suo tempo, numerosi membri del parlamento europeo tra i quali Meir Sheetrit avevano caldeggiato il rilascio di Barghouti come parte di future negoziazioni di pace, e ricordo anche che Shimon Peres si era espresso a favore del “perdono presidenziale”.
Liberarlo oggi per creare un nuovo interlocutore credibile per il popolo palestinese? È solo un esempio. Non intendo certo sovrappormi alla fervida fantasia dei “Grandi della terra” allorquando si ricordano che accanto ai muscoli convive “l’esprit de finesse” del cervello politico e diplomatico.