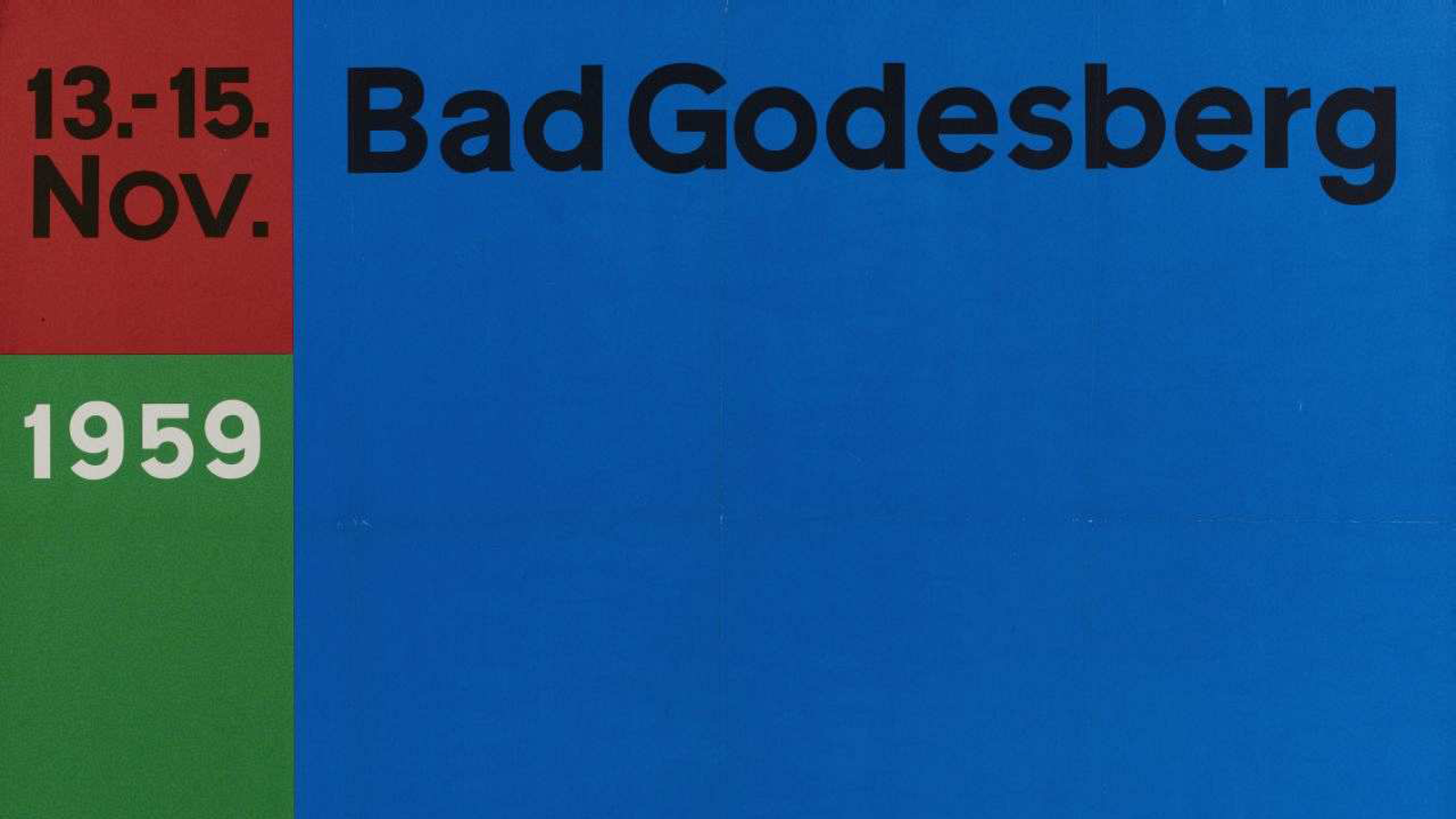Il bello delle elezioni (perse) è che dopo c’è il congresso del Pd. Ovvero regole contestate, candidature annunciate e ritirate, faccia a faccia tra i nomi in corsa (i confronti impossibili nella campagna elettorale normale, unico paese d’Europa, vero Agcom?). È sempre stato così, ma non è detto che oggi lo spettacolo sia così divertente come in passato. La partita è stata inaugurata di Enrico Letta con la lettera «agli iscritti e alle iscritte del Pd» e l’indicazione di quattro fasi (la chiamata, i nodi, il confronto, le primarie) all’insegna di «apertura, opposizione, nuova vita». Nelle intenzioni del segretario-non ricandidato dovrebbero evitare il rischio di trasformare il congresso in un «casting» e una «messa in scena staccata dalla realtà», con in azione le «maschere pirandelliane». Intanto va avanti sui giornali e sui social il rito definito analisi della sconfitta, in cui vanno segnalate, almeno, la conclusione di Gianni Cuperlo («Stiamo letteralmente sulle scatole a una parte del paese») unita a quella del suo finto doppio su Twitter Gianni Kuperlo: «Il Pd è come la vita: fa un po’ schifo a tutti, ma è tutto quello che abbiamo».
UN POPOLO INATTESO
Ottobre Democratico. Che non era rosso, non è stata una rivoluzione e la spinta propulsiva si è esaurita da tempo. Cadde in ottobre la crisi del primo governo Prodi, il remoto 1998 da cui è cominciata l’interminabile guerra civile a sinistra, la grande occasione perduta. Ma anche l’origine del Pd ruota sul mese autunnale, in tre date ormai lontane e forse dimenticate anche dai protagonisti. 16 ottobre 2005: le prime primarie nazionali della storia che consegnarono a Romano Prodi la candidatura a premier alle elezioni del 2006. 6 ottobre 2006: il convegno di Orvieto in cui furono gettate le basi del futuro partito. 14 ottobre 2007: l’atto di nascita del Pd, con l’elezione del primo segretario, Walter Veltroni, sindaco di Roma.
Sono passati quindici anni da quel momento. Di quella sera ricordo Goffredo Bettini, l’organizzatore della campagna di Veltroni. Si aggirava in camicia rossa: «Sono come un pistolero, lavoro a contratto. Il mio compito è finito».
Nella sala del teatro Adriano al centro di Roma, location perfetta per l’acustica e le belle riprese televisive, con il leader immortalato tra due colonne doriche, era già partita la colonna sonora: Mi fido di te di Jovanotti e Imagine di John Lennon.
Veltroni appena incoronato segretario, con il verde del nuovo partito acceso alle spalle, proclamò: «Da oggi deve far paura la parola conservazione. Il Pd dovrà durare decenni, non nasce da un leader e per un leader, ma dalle persone reali di questo paese». Si dimise, nella stessa sala, sedici mesi dopo, senza cravatta, quasi liberato. «Non ce l’ho fatta a fare il partito che volevo, chiedo scusa».
LE PRIMARIE DI PRODI
In mezzo c’erano state le elezioni perdute contro Berlusconi ma con una percentuale mostruosa, il 33 per cento e 12 milioni di voti e una grande manifestazione al Circo Massimo, sempre in ottobre, sabato 25.
In quelle primarie del Pd 2007 avevano votato in tre milioni e mezzo. Due anni prima erano stati un milione in più e avevano mandato la macchina dei partiti in tilt. Il 16 ottobre 2005, una domenica di sole, gli elettori del centrosinistra votarono per la prima volta per scegliere il candidato premier nelle piazze, nelle librerie, nelle palestre, nei negozi per gli animali.
I gazebo sono il simbolo delle primarie. In fila vecchi, giovani, suore, Giovanni Bazoli, Alessandro Profumo, Corrado Passera, anche i sicari dell’ndrangheta che a Locri uccisero il vicepresidente del consiglio regionale calabrese Franco Fortugno, appena uscito dal seggio dove aveva votato. Un popolo imprevisto.
Il giorno prima gli organizzatori prevedevano un milione di votanti, «se è così sarà un successo», a metà mattinata le schede erano esaurite, furono ristampate, due milioni, tre milioni in serata, all’alba quattro milioni, alla fine i votanti saranno quattro milioni e mezzo.
Romano Prodi aveva cercato la legittimazione popolare che gli era sempre stata negata e l’aveva avuta. Ma lo stratega Arturo Parisi, alle tre di notte con i piedi su una poltrona, capì subito che quel trionfo inatteso avrebbe costretto i capi dei partiti a inventare una contromossa: «Ora ci chiederanno di fare qualcosa che ha le sembianze dell’Ulivo, ma non è l’Ulivo…».
In poche ore le resistenze si sciolsero. Clemente Mastella, fino alla mattina precedente con un piede fuori dalla coalizione del centrosinistra, giurò fedeltà: «Giobbe era uno che non faceva politica, io non sono Giobbe». Il leader della Margherira Francesco Rutelli fu il più rapido di tutti. Nella notte chiese, subito, la nascita del Partito democratico, come vuole «la nostra gente». Il segretario dei Ds Piero Fassino si allineò.
Un anno dopo, il 6 e il 7 ottobre 2006, i capi del futuro partito si riunirono a convegno a Orvieto. Tre relazioni, affidate al futuro sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al politologo Salvatore Vassallo e allo storico Pietro Scoppola.
«Il Partito democratico non rappresenta la ristrutturazione, anche radicale, di un vecchio edificio, ma la costruzione di una nuova casa… nasce dall’unione di soggetti diversi, tutti dotati di pari dignità, la tradizione cattolico-democratica costituisce una componente rilevante tanto quanto quella socialdemocratica e quella liberaldemocratica», disse Gualtieri, all’epoca storico dell’Istituto Gramsci, vicino a Massimo D’Alema.
LA SPARTIZIONE
Pari dignità tra i soggetti. Una formula che da allora in poi i partiti e poi le correnti hanno interpretato al ribasso, in modo spartitorio, di zone di influenza.
Eccola qui, la fusione a freddo, cui reagirà qualche mese dopo Scoppola il 14 marzo 2007, nel suo ultimo intervento pubblico (morirà qualche giorno dopo la nascita del Pd, il 25 ottobre), non nascondendo la sua delusione per come stava avvenendo la formazione del nuovo partito: «Non credo alla formuletta dei riformismi che si incontrano, perché di riformismo in questo paese ce ne è stato poco per molti decenni: prima è stato bloccato dal conflitto ideologico con il comunismo, poi, nel centrosinistra, è stato travolto dalle logiche di partito. Il riformismo italiano più che una espressione di grandi e forti tradizioni politiche è stato un fatto di élites illuminate… Il Pd ha radici profonde nella storia del Paese o è una invenzione estemporanea e contingente senza radici e perciò senza futuro? Nella storia del Paese vi sono motivi profondi di resistenza, di incompatibilità, rispetto al progetto del Pd?». Domande di una certa attualità.
Il Pd era nato non per convinzione ma per conversione: cuius regio eius religio. In poche settimane, tutti i contrari erano diventati favorevoli: principi, alti feudatari, valvassori e valvassini. Al seguito dei signori della guerra nazionali.
Come dimostrava la strepitosa inversione di marcia di Massimo D’Alema: «Non c’è un’ora X in cui tutti si sciolgono, vanno al gazebo e nasce il Partito democratico», aveva avvertito a Orvieto nell’ottobre 2006.
«Dobbiamo eleggere una Costituente del Pd dove i cittadini vanno, votano, pagano una quota e ricevono una tesserina. Io spero che siano più di un milione», si corresse sei mesi dopo a Firenze, al congresso dei Ds.
Toccò ancora a lui salire in Campidoglio e chiedere a Veltroni di candidarsi alla segreteria del Pd. Il Caminetto dei notabili si spostò in blocco. E fu ancora lui, Massimo D’Alema, a emettere la sentenza definitiva nel 2008: «Il progetto si è appannato per ragioni più complesse del correntismo: se avessimo le correnti non sarebbe bello a vedersi, ma sarebbe un ordine. No, il problema è generale: l’amalgama è mal riuscito».
I signorini della guerra
La legge che ha guidato il centro-sinistra dal 1995 in poi: se esci dalla foto di gruppo ti combattiamo, se rientri ti facciamo eleggere. Perfino Matteo Renzi è rientrato in questo schema. E naturalmente l’ultimo segretario, Enrico Letta, nominato all’unanimità in poche ore dopo le dimissioni (mai spiegate) di Nicola Zingaretti.
Nel 2007 i candidati alla segreteria furono Veltroni, Rosy Bindi e Enrico Letta. Oggi si è fatta avanti Paola De Micheli, si dice disponibile Stefano Bonaccini, si attende l’esterna Elly Schlein (la “chiamata” di cui ha scritto Letta), vorrebbe ma non può il vice-segretario Peppe Provenzano.
I signori della guerra erano D’Alema e Franco Marini, oggi sono sostituiti dai Signorini di oggi (i ministri Franceschini, Orlando, Guerini), esperti di tattica più che di strategie, di guerriglia più che di guerra, di trappolette più che di grandi manovre. Soprattutto: nel 2018 il Pd di Renzi ha raccolto poco più di sei milioni di voti, la metà di quelli presi da Veltroni dieci anni prima.
Una settimana fa hanno votato per il Pd poco meno di cinque milioni e mezzo di elettori, ovvero soltanto un milione in più dei votanti delle primarie del 2005, quelle di Prodi (quattro milioni e mezzo). Più che una erosione è uno sfaldamento che può anticipare l’estinzione. Dove sono finiti tutti quei milioni di voti perduti? E perché il Pd non riesce a raccogliere , se non in parte, i voti dei nuovi elettori?
IL PARTITO IPOTETICO
L’esaurimento dell’ottobre democratico ha cause contingenti e ragioni remote. In un libro di secoli fa (La Dc nell’Italia che cambia, Laterza, 1984) Arrigo Levi chiese ai capi della Democrazia cristiana di raccontare le cause della sconfitta elettorale più grave della storia (meno sei per cento, due milioni di voti persi). I leader della Dc si divisero in “strutturalisti”, le cause del rovescio arrivano da lontano, e in “congiunturalisti”, il consenso perduto è provocato da una campagna elettorale sbagliata.
Allo stesso modo, nella sconfitta del Pd 2022 si possono distinguere le cause di breve periodo da quelle di lungo periodo. Sulla campagna elettorale ci sono dall’interno le giuste osservazioni di Dino Amenduni, tra i comunicatori di Proforma che ha gestito i messaggi elettorali.
In sintesi: il Pd non ha scelto se correre da solo per massimizzare i risultati nella parte proporzionale della legge elettorale oppure mettere su una coalizione competitiva nei collegi uninominali. Ma non è stato l’unico punto di debolezza.
La mancata scelta ha avuto come effetto, per la prima volta dal 1994, l’assenza di competizione. Gli elettori sapevano già che votare per il Pd significava partecipare, ma non vincere. Una consapevolezza che ha tagliato alla radice la categoria del voto utile. Tutti i voti sono utili, se non c’è gara: è quello che è successo.
Dal 1994 a oggi, dall’inizio della Seconda Repubblica, i due schieramenti di centrosinistra e di centrodestra tendono a somigliarsi, agiscono come neuroni specchio, imitando le mosse dell’avversario.
Nel 1994, con la legge elettorale Mattarellum, Berlusconi mise su la doppia coalizione, con la Lega al Nord e con Alleanza nazionale al Sud, similmente nel 1996 l’Ulivo riuscì a comporre un’alleanza a cerchi concentrici: il patto di governo (l’Ulivo propriamente detto), l’alleato (la lista Dini), la desistenza (con Rifondazione comunista).
Nel 2008, con il Porcellum, il centrosinistra si candidò con l’assetto a due Pd-Italia dei valori (Antonio Di Pietro), il centrodestra replicò mettendo su in poche settimane il Pdl alleato con la Lega. Nel 2013 e nel 2018 le due coalizioni si sono sfrangiate, a vantaggio del Movimento 5 stelle.
Nel 2022, invece, il centrodestra è andato unito nei collegi, mentre il centrosinistra si è disperso tra Pd-Sinistra-più Europa e M5s e Azione-Italia Viva. Il centrodestra ha incassato i collegi, il centrosinistra neppure ha provato.
L’agenda Draghi, in mano al Pd, è stata considerata la conferma della sua distanza dalla parte debole della società. Si è tagliato il rapporto con Giuseppe Conte, mentre si è puntato su un’alleanza con la lista di Luigi Di Maio che ha preso meno di 170mila voti in tutta Italia, un misero 0,6 per cento: era un’operazione trasformista inesistente nell’elettorato. Infine, le liste: mai così autoreferenziali, asfissianti, dato anche il taglio dei parlamentari.
Il ritorno all’indietro sulla parità di genere e sul numero delle elette-nominate in Parlamento è solo l’ultimo tassello di una serie di principi calpestati.
Sugli sbagli di lungo periodo, gli strutturalisti potrebbero partire dall’incapacità del Pd di sciogliere la sua natura di «partito ipotetico», come lo chiamò Edmondo Berselli già nel 2008: «Occorrerà vedere se il Pd è in grado di ripartire. Se i suoi membri punteranno sulla costruzione paziente di un partito vero. Se affioreranno o no nostalgie per le vecchie identità e per le vecchie appartenenze. Se qualcuno si prenderà l’impegno di delineare una cultura unificante, che al momento non esiste…».
Mantenere il potere
I se non sono mai stati sciolti. Il Pd ha continuato a essere scisso tra una fazione che lo ritiene l’erede del Pci, il partito della Ditta, con la frustrazione di non poter gareggiare in prima persona e la necessità di scegliersi sempre qualche controfigura, e una che invece ha puntato a liquidare ogni aggancio con il passato per presentarsi leggeri all’appuntamento con il futuro, il partito della Leopolda. In mezzo, i signorini della guerra Franceschini-Orlando-Guerini pronti ad allearsi con gli uni e con gli altri per mantenere il potere di interdizione dentro il partito.
Così il Pd ha smesso di ragionare, di coltivare un pensiero o una cultura politica, si è rifugiato o in un passato inutilizzabile o in un futuro indistinto.
Il Pd ha smesso di conoscere la società che dovrebbe rappresentare, si è rinchiuso nel politicismo, a dispetto di migliaia di amministratori locali che nel confronto con la realtà trovano la strada del riformismo. Il Pd ha coltivato una sola ragione sociale: restare al governo, a ogni costo.
IL TOPO IN TRAPPOLA
Dall’analisi delle cause della sconfitta discendono le risposte da dare alla crisi. Se il Pd ha perso per quanto accaduto alla fine della legislatura e in campagna elettorale per vincere basterà stringere l’alleanza con il Movimento 5 stelle o con Calenda/Renzi. Se invece il Pd viene rigettato per cause lontane bisognerà interrogarsi più in profondità. Un partito del 19 per cento non si butta a mare da un momento all’altro senza un progetto alternativo.
Ma non si può neppure cedere alla illusione ottica che abbaglia i dirigenti di ogni struttura e di ogni apparato in ogni tempo, pensare che dentro, in fondo, nulla sia cambiato e che il perimetro del mondo coincida con le porte e finestre della propria sede. Quando, invece, è proprio fuori che c’è la possibilità di rivincita e di salvezza.
È la metafora del topo che resta nella trappola, più volte raccontata dall’ultimo segretario della Dc Mino Martinazzoli, quando il partito stava per entrare nella fase terminale: «Un topo era caduto in una trappola. Gli amici cercavano di aiutarlo, ma lui non li stava a sentire: “Non mi lamento per la trappola, ma per la cattiva qualità del formaggio”».
La trappola del cattivo formaggio ha condizionato il Pd negli ultimi dieci anni. Accontentarsi della gestione del potere senza vincere nella società, una tentazione che ha corroso perfino il capo meno incline al tirare al campare, ovvero Matteo Renzi, che andò al governo senza la legittimazione di un voto, si disse mentendo a se stesso che valesse il 40 per cento delle elezioni europee e quando tornò a chiedere un voto fu sconfitto al referendum.
Ora la sfida per il Pd è mortale perché alla sua sinistra (M5s) e destra (Calenda/Renzi), per così dire, c’è chi punta a fare la spesa con i voti e gli elettori lasciati incustoditi. E per la prima volta il Pd è messo in discussione sul suo ruolo di partito egemone del centrosinistra, non è un polo attrattivo per nessuno, semmai mette in moto una dinamica centrifuga, di potenziali alleati e di elettori. È un terreno di conquista per Conte, per Calenda, per Renzi.
La rappresentanza sociale non si improvvisa, così come l’identità, – direi la personalità – di un partito che non è solo la figura del suo leader. Lo dimostra il rosario del tornare contrito che contagia i dirigenti nelle interviste post-voto (torniamo sui territori, torniamo nelle periferie…) che svela la distanza e l’abbandono: torneremo dove non siamo mai stati.
Un’impresa ancora più difficile in questa stagione di eclisse della società civile organizzata. I vecchi corpi intermedi non esistono più, i nuovi movimenti per l’ambiente o per i diritti fanno fatica a confrontarsi con la sfera politica globale che non ammette battaglie di settore, ma una visione complessiva del mondo.
Non serve cambiare il segretario, il giovane invece del vecchio, la donna al posto dell’uomo, serve cambiare partito. Adesso lo dicono tutti. Troppo tardi. Se davvero per il Pd, per la prima volta dal 2011, si apre una lunga stagione di opposizione ci sarà (forse) il tempo di farlo. Con un cambio di nome e di struttura, con una Ri-generazione.
Oggi che la pandemia, la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, la questione energetica, un esigenza diversa di sicurezza, il lavoro che cambia, le migrazioni, i nuovi diritti, tutto smonta l’idea del tramonto della politica come sfera privilegiata dell’azione, torna lo Stato e che la democrazia è in difficoltà serve ancora di più un partito – non tradizionale, ma rocciosa, forte, adeguata al combattimento e alla resistenza. E un partito che faccia riferimento alla democrazia come sostanza e non come forma, la più importante questione del nostro tempo, altro che le alleanze.