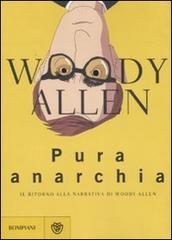
Metafisica applicata per vivere
3 Dicembre 2023
Pianto di solitudine del potente sconfitto
3 Dicembre 2023L’aggettivo che più frequentemente si associa al nome di Maria Callas è senz’altro quello di «divina». Giusto, anzi sacrosanto. Ma perché allora, assecondando la sua natura sublime, non considerala anche una e trina? Una persona, certo, nella sua inviolabile unicità, ma anche un prisma a tre facce nella sua dimensione di interprete. A guardarla da lontano, in effetti, dai cento anni esatti che ci separano dalla sua nascita, Maria, anche in ragione di una casuale vocazione onomastica, potrebbe essere davvero considerata una «trinità laica». In tutti o quasi tutti gli universi della sua esistenza terrena: la natura della voce, la tipologia del canto, le scelte (o le imposizioni) di repertorio, persino i domini della vita materiale e affettiva al di fuori del palcoscenico.
Abbiamo di fronte, innanzitutto, un dato oggettivo, facile da rilevare: l’estensione della sua voce. Possiamo scrivere su un pentagramma immaginario due note «polari» che troviamo – fissate per l’eternità – nelle registrazioni storiche: il fa diesis grave (sotto il rigo) intonato nell’aria «Arrigo! ah, parli ad un core» da I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi e il mi naturale sovracuto (sopra il rigo) toccato in «Dov’è l’indiana bruna» dalla Lakmé di Léo Delibes. Una estensione potenziale, dunque, di quasi tre ottave che abbraccia, almeno sulla carta, i tre registri di base della voce femminile: il contralto, il mezzosoprano, il soprano. Ma anche restringendo lo sguardo intorno al registro di soprano il prisma delle categorie coniate dagli studiosi di vocalità mostra almeno tre facce diverse: il soprano lirico (con la variante aggiuntiva della «coloratura»), il soprano drammatico, e infine il «soprano drammatico di agilità», la categoria proposta dal critico musicale Eugenio Gara per definire il mix tra canto di forza e canto di agilità che Callas imprime nel 1949 alla Elvira dei Puritani di Bellini.
Se poi scorriamo l’elenco dei quasi cinquanta ruoli affrontati da Maria in trentacinque anni di carriera la suddivisione ternaria si ripropone: in un alveo appartato, ma niente affatto «minore», si annidano i titoli legati al classicismo del primo e del tardo Settecento: Gluck, Haydn, Mozart, Cherubini, con la coda «inattuale» del Rossini serio (Armida) e di quello comico (Il Barbiere di Siviglia e Il Turco in Italia). Al centro del palcoscenico immaginario abitano ovviamente (quasi tutti governati, però, da una ars scenica modernissima) i ruoli capitali del melodramma italiano dell’Ottocento, quelli che ruotano intorno alla vera «santa trinità» formata da Donizetti, Bellini, Verdi. E infine (lasciando in disparte i «consapevoli abbagli» dei rari assalti wagneriani) si impongono le incursioni niente affatto casuali nel repertorio dell’opera post-romantica: Puccini, innanzitutto, ma anche Mascagni, Leoncavallo, Boito, Giordano, Ponchielli.
Di fronte al mistero della Trinità l’essere umano, solitamente, si chiude nel silenzio della contemplazione. Un rischio che Luca Aversano e Jacopo Pellegrini combattono energicamente nelle pagine, sonore e generose, di Mille e una Callas. Voci e Studi:un prezioso volume collettaneo pubblicato nel 2016 da Quodlibet e riproposto in questi mesi in occasione del centenario. Una visione non a caso «prismatica» del fenomeno Callas che raccoglie le riflessioni di quasi quaranta studiosi e li suddivide in diversi capitoli tematici intarsiati tra loro: Corpo e voce, Sulla scena, Medea, il modello Callas, Ricordi, Il mito. Un prisma al quale proprio oggi, domenica 3 dicembre, al Teatro Palladium di Roma, si aggiungono altre due facce: una tavola rotonda con Susanna Pasticci, Andrea Cortellessa e i due curatori del volume, nonché uno spettacolo, Kalòs-Callas: Collage, con i testi di Valerio Magrelli e le musiche di Bruno Moretti e Franco Piersanti. All’ingresso del teatro potrebbe posta, oggi, a mo’ di insegna, una sentenza inappellabile, quella pronunciata da Carmelo Bene all’indirizzo della «Divina»: «Sarebbe un oltraggio definirla miseramente una “grande cantante”. Era, ed è, l’arte».





