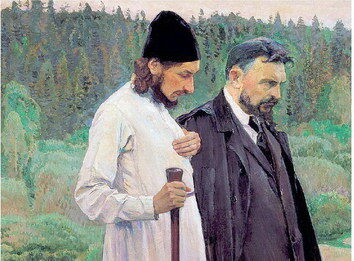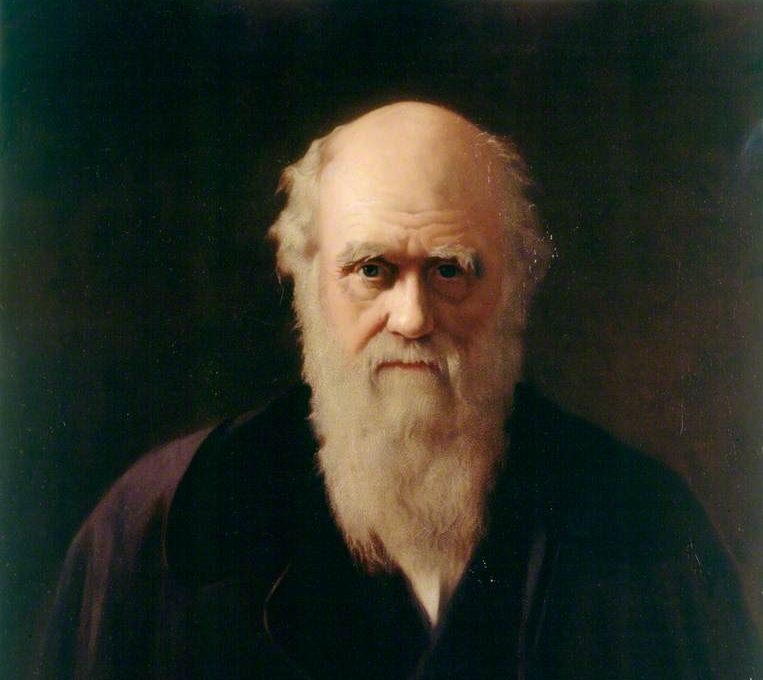Emilio Prini l’alieno anarchico
18 Febbraio 2024
Quanta Africa c’è tra i canali di Venezia
18 Febbraio 2024Lo ricordate? Alla fine degli anni Zero la letteratura italiana era nel pieno di quello che si definiva un «ritorno al reale»; anzi, tutta l’estetica occidentale sembrava esprimere ciò che David Shields definiva Reality Hunger, «fame di realtà». Lo si vedeva sul piano dei contenuti, grazie al ricorso massiccio a temi di consolidata tendenza realistica (l’interesse per i bassifondi della società, per un esotismo ‘povero’) o di attualità impegnata (il lavoro precario, la crisi economica), ma anche sul piano formale – con novità interne alla ‘cucina’ dei generi: grande fortuna del non fiction novel (specialmente nelle sue diramazioni giornalistiche), della testimonianza più o meno veridica in prima persona (autofiction, biofiction, memoir…), del nuovo romanzo storico…
Oggi le cose non sembrano molto cambiate: i nostri linguaggi artistici – non solo la letteratura – continuano a esibire fame di realtà, probabilmente perché il tasso di finzione e smaterializzazione che domina le nostre vite non è diminuito, anzi, è aumentato. Aumentato anche lo scarto fra un’arte più o meno sofisticata, a dominanza realistica, che continua a esprimersi attraverso vari esperimenti con la non fiction e si rivolge a un pubblico d’élite, e un’arte popolare, consegnata all’avventuroso e al fantastico, che si esprime attraverso variazioni sul romance sempre più irrealistiche: le saghe fantasy a grande tiratura, i romanzi rosa e neri più globalizzati, e ovviamente il cinema di cassetta, con i suoi supereroi e le sue azioni strepitose. Il divario allude a una complementarità che fa pensare: tra un’iperrealtà che urla di essere vera e un’irrealtà sempre più contorta e rumorosa, il nocciolo duro, aspro e non addomesticabile del reale pare giacere in un sotterraneo corazzato di oblio e di rimozione: infatti di novel borghesi se ne fanno sempre meno, e sempre meno buoni.
Più aperto al vecchio realismo ottocentesco, quello parametrato sulla quotidianità e sul verosimile, è semmai il linguaggio delle serie televisive, nelle quali in molti ritrovano l’eredità del romanzo: le serie intelligenti, di ultima generazione, che attirano sceneggiatori e attori di qualità, si rivolgono a un pubblico che è o si crede sofisticato, e in più godono di una circolazione mondiale, fanno grandi profitti.
Forte di questa intuizione, proprio alle serie tvWalter Siti dedica lo scritto che aggiorna e chiude la nuova edizione di Il realismo è l’impossibile (nottetempo,pp. 96, € 12,00),saggio breve che nel 2013 provava a fare il punto sulla nuova ‘questione del realismo’ in cui si dibatteva, e ancora si dibatte, la letteratura occidentale (sempre stata a dominante realistica, ma pure sempre disponibile a sperimentare modi molto diversi di farsi mimetica).
Riletto oggi, col senno di poi, Il realismo è l’impossibile appare ancor più come «una bieca ammissione di poetica»: e se ne vede bene il ruolo di incunabolo di quel che sarebbe stato, nel 2021, Contro l’impegno, con la sua polemica contro il ‘neo neorealismo’ piatto, contenutistico, stereotipato che nel frattempo si è imposto nella nostra narrativa.
Più che descrivere l’attuale fame di realtà – che gli appare povera di strati e di significati, allineata a un indebolimento complessivo della nostra idea dell’arte – a Siti interessa individuare una tradizione letteraria che operi nel senso del conflitto con la realtà: un realismo come sovvertimento dell’abitudine (e quindi degli stereotipi), come ricerca dello straniamento, come svelamento provvisorio di sensi rimossi o repressi nascosti alla società e all’individuo. Questo genere di realismo non funziona come un semplice specchio, riproduzione passiva del reale, ma casomai come uno specchio ustorio, ordigno che nutrendosi della realtà ne fa esplodere la superficie per lasciarne emergere i livelli invisibili e profondi; realismo come trampolino da cui sporgersi – a forza di dettagli esatti, introspezioni minuziose e parole veramente pronunciate, – verso un Assoluto che il quotidiano dissimula, ma è incapace di contenere.
È un realismo agonistico, che nasce da una sfida, anzi proprio da un rancore –«molti scrittori realisti odiano la realtà, se no non dedicherebbero la vita a fabbricarne un surrogato»; ma possiamo ipotizzare che l’avversione stessa derivi forse, più profondamente, da un amore, non corrisposto, per quella realtà che si è ritratta di fronte a un desiderio eccessivo e divorante («il realismo è una forma di innamoramento, odio e amore evidentemente non si escludono»). Quindi un realismo impossibile, perché incapace di catturare definitivamente l’oggetto del suo desiderio (e del suo risentimento); oltranzista, per la continua tensione imposta dall’imperativo a superarsi; trasgressivo, perché punta sempre a integrare se non a smentire le speranze utopistiche che la nostra società e noi stessi di volta in volta riponiamo nell’arte («il realismo è impossibile come la rivoluzione»).
Oggi lo vediamo più chiaramente di dieci anni fa: questo realismo è meraviglioso ma desueto, anacronistico nel suo ostinarsi a perforare una realtà che attraeva e faceva male (e faceva male perché attraeva). La realtà che Walter Siti intravede nei nuovi romanzi, film e serie tv è più spesso una materia che annoia o atterrisce, ma in ogni caso invoca supplementi: più spettacolo, più velocità, più correttezza politica – e non per approfondire, ma per evadere. Non per sporgersi, ma per scappare.
Se «l’irrompere del non-stereotipo, dell’inaspettato, è forse adesso percepito più come una minaccia che come una ricchezza», la diagnosi – al netto di una doverosa e un po’ meccanica apertura di credito finale – resta nel complesso pessimista: per molti, nonostante le apparenze, il realismo non è più una meta impossibile cui tendere, ma qualcosa di estraneo, da addomesticare. Un luogo da cui fuggire per consegnarsi alle ’storie’ dei romanzi, del cinema, delle serie tv e naturalmente dei social: confortevole e luminosa, questa irrealtà appare scorrevole, vivace e adeguatamente ammobiliata: un realismo turistico.