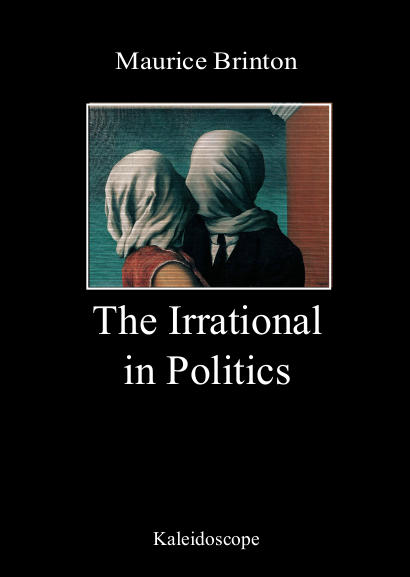L’ultimo Miglio
18 Gennaio 2024
Parte la missione europea “Aspis” anche navi italiane nel Mar Rosso
18 Gennaio 2024«Bisogna impedire a questo cervello di funzionare» disse nella sua requisitoria Michele Isgrò, il pubblico ministero che nel 1926 chiese venti anni di carcere per Antonio Gramsci. Oggi, il povero Gramsci, rischia ben altra condanna. E sta a tutti noi evitare che gli venga inflitta.
All’epoca, era accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato, incitamento all’odio di classe. Come è noto, il proposito del fascista non venne esaudito e il cervello sovversivo di Gramsci continuò a funzionare anche dal carcere.
Le idee che in quelle condizioni estreme fu in grado di elaborare e mettere in circolo rappresentano ancora oggi un elemento fondamentale per comprendere il rapporto tra potere e conoscenza, struttura e sovrastruttura, senso comune e cultura dominante.
Antonio Gramsci è di gran lunga l’intellettuale italiano globale, letto, tradotto e stracitato nelle università di tutto il mondo. È entrato a pieno titolo nel dibattito globale e postcoloniale, è un riferimento imprescindibile delle culture politiche delle sinistre di tutto il pianeta. Ecco per quale motivo non avrebbe potuto sfuggire meglio alla condanna che il regime avrebbe voluto infliggergli.
Purtroppo, tuttavia, esiste ancora un modo per impedire che quel cervello continui a far paura ai potenti. Esiste un’altra occasione di gettare sabbia, almeno nel contesto italiano, per provare a rallentare gli ingranaggi della formidabile macchina politico-culturale che il pensiero di Gramsci alimenta tutti i giorni al giorno d’oggi. Ciò può avvenire imbrigliando il suo pensiero nello spazio pacificato della «cultura nazionale», privandolo della sua natura conflittuale e facendo finta di dimenticare che tutto ciò che Gramsci ha scritto, sulle pagine dell’Ordine nuovo e sui foglietti faticosamente fatte trapelare dalla galera mussoliniana, diventa impensabile se la dimensione politica viene cancellata.
Descrivendo il nocciolo del pensiero reazionario, Furio Jesi scrisse che per la cultura di destra, che pure tanto fa uso della retorica della tradizione, «il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile». È soltanto in questo modo che, tornando sulle pagine del Corriere della sera sull’appello per apporre una targa alla clinica Quisisana in cui Gramsci morì nel 1937 (omettendo per l’ennesima volta che quell’appello è stato diffuso dal manifesto), il ministro della cultura meloniana Gennaro Sangiuliano ha potuto descriverlo come «fondamentale attore dell’ideologia italiana», in linea con l’idealismo, con Croce, con Prezzolini e col solito compendio della cultura conservatrice che il ministro sciorina in pubblico praticamente a ogni occasione.
Ed è soltanto in questo modo che, sempre ieri, a chi gli chiedeva se si considerasse antifascista (domanda tutt’altro che scontata, visto l’evidente rifiuto di farlo della presidente del consiglio e del presidente del senato) l’ex direttore del Tg2 ha sentito il bisogno di rispondere costruendo un improbabile parallelo tra comunismo e fascismo e impossessandosi del microfono per chiedere ai cronisti presenti di fare professione di «anticomunismo». Nel tribunale della storia reazionaria, si sa, come per miracolo tutte le vacche sono nere.
Giusto due giorni fa, peraltro, lo stesso Sangiuliano ha presentato al governo le trecento pagine del decreto governativo sui servizi media audiovisivi. All’interno del quale c’è spazio anche per un comma che persegue il fantasma della «cancel culture», questa volta definita come «tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione».
Vogliamo vederla, adesso, l’AgCom pronta a perseguire gli iconoclasti difensori del «politicamente corretto» e della «cultura woke». Questa è la grottesca battaglia della destra per l’egemonia. Per fortuna sono pessimi lettori di Antonio Gramsci.