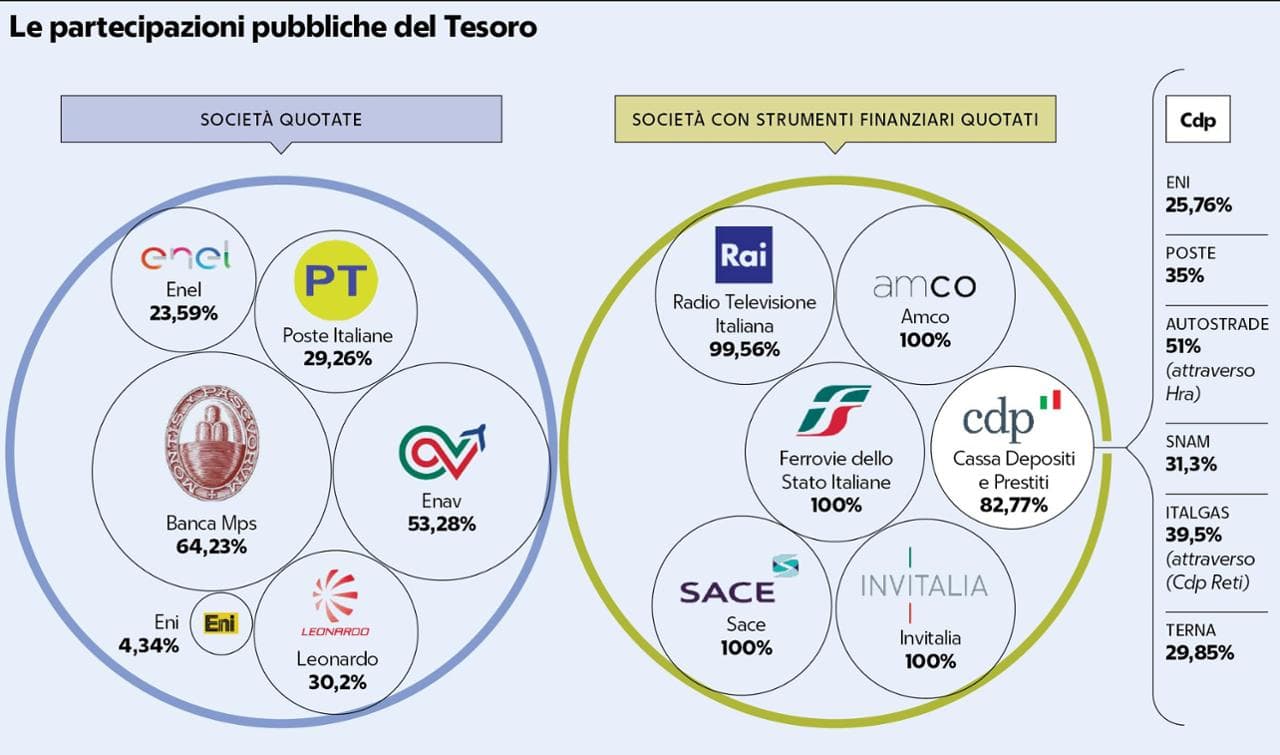Domenico Quirico
Una lunga fila disciplinata, che marcia svelta, scandita dagli stracci bianchi a cui affidano la loro vita: guardi il cielo e ti sembra di essere investito da una calda fragranza, ti avvolge un sole silenzioso e complice. Si sente un brusio, come una spuma di suoni, l’unico vero rumore sono alcuni colpi lontani di artiglieria. La fila, allora, ha un sussulto. Ma non si ferma. Tre ore, quanto ha concesso Israele, non sono molte tre ore per fuggire. Tre ore ha strappato il potente Biden all’implacabile Netanyahu, con le sue inutili portaerei di latta e i sottomarini nucleari.
Tre ore. Dunque non ci si può permettere di esitare , di avere paura. A guardare la fuga da Gaza a piedi verso la fragile sicurezza della sacca di disperati al confine con l’Egitto, dove una umanità brulica, fermenta, hai l’impressione di leggere un libro dal quale un severo censore abbia cancellato ogni frase superflua, lasciando solo crudeli informazioni che comunichino l’essenziale, il senso profondo.
I palestinesi, uomini donne vecchi bambini, camminano con la dignità dei popoli i cui antenati hanno trasportato pesanti fardelli sulla testa in mezzo a torridi campi. Come sfondo, all’avvio della marcia, ci sono imponenti scenografie di imperitura maceria. E’ solo l’inizio, la carovana è ancora paziente. Ogni tanto imboccando una strada più larga il fiume umano si allarga, compaiono asinelli che trascinano arrancando carretti gonfi di gente. Anche gli uomini trascinano a brandelli un passato ancora vivo. Un uomo spinge, curvo, una carriola su cui è disteso un malato di cui si indovina la forma sotto il pudore di una coperta. Con lo scorrere del tempo, avvicinandosi la fine della tregua concessa, la fila sarà percorsa da sussulti di paura, di diffidenza, di odio.
Quanti sono? Come contarli in questo faticoso andare nelle fogge più variopinte, ogni famiglia con i bambini e gli infermi, strappati dalla nicchia quotidiana, con il suo fardello di caldo, di sete, di fame, di terrore su queste strade da ramarri? E poi quando arriveranno (ma quanti resteranno per strada esausti rassegnati feriti) ci sarà da sfoderare denti e artigli e guadagnarsi una tana. Intanto sulla città abbandonata bombe e granate riprenderanno a cadere come se un gigante capriccioso si stesse divertendo con questo passatempo atroce, Israele e Hamas riprendono la loro guerra senza l’impiccio di questi inutili esseri umani.
La situazione si presenta come stranamente famigliare, abbiamo la certezza di aver vissuto nel passato quello che sta accadendo nel presente. Le case devastate, la gente in fuga, gli uomini armati che sbucano dalle macerie, silenziosi, cupi: tutto ci suona familiare. Congo, Siria, Nigeria, Tigrai, Somalia. Non vi esplodono in mano questi nomi? Cosa vuol dire bene per costoro? Non morire, un po’ di calma è già un bene.
Accade sempre così. A un certo punto ieri si è fatto silenzio. Aerei e cannoni hanno per tre ore sospeso i loro ingranaggi. Il tempo si è fermato, la terra non gira più. Qualcuno ha detto: bisogna andare.
Hanno cercato di raccogliere poche cose, non c’è rimasto molto a Gaza da portar via dopo un mese di bombardamenti. Infatti nella fila ci sono molti che non hanno con sé nulla. Nella disperazione resta una consolazione, quella di separarsi da tutto, di essere ridotti a se stessi. «Bisogna andare», ha detto qualcuno.
Bisogna imboccare la strada che porta verso l’Egitto, una strada che sembra la sintesi di tutte le strade dell’universo. Lunga, grigia, eterna prosegue fin dove l’occhio può arrivare e alla fine di essa non c’è null’altro che un campo per profughi. Forse lì tornerà l’ora della salvezza. Non moriremo più.
Credo che questa strada racconti queste esistenze palestinesi senza ombre di dubbi. Chilometri di strada dritta, camminare, senza fermarsi, scivolare via. Prima che sia troppo tardi. Senza riposo, senza mangiare né bere, umili, atterriti dal loro stesso spettrale cammino. Passano le ore. Non si può definirle lunghe, interminabili, queste ore esulano dal tempo normale. Sono ancora vivi, in fondo in un posto così è un miracolo.
Sono diventati gli esuli: le vittime delle pulizie etniche, gli scarti delle terre che bisogna svuotare per renderle sicure, da usare come trincee.
Rifletto. È la guerra che si rivela in questo lungo serpente di uomini. La guerra non quella dei libri e dei film ma quella vera nel suo aspetto brutale, senza diritti, regole, proibizioni. Questa gente ha passato settimane rannicchiata tra le case distrutte, sotto il tiro di aerei e cannoni. Non sono loro che fanno la grande Storia, ma la grande Storia si fa anche con loro, è intrisa del loro patire.
Se avessero tempo ci griderebbero, a noi che li guardiamo passare: non c’è nulla che possiate fare per noi, perché venite a spiarci, a guardarci camminare, a contarci come se fossimo armenti? Statevene nel vostro mondo perfetto, non vogliamo né la vostra comprensione né la nostra pietà.
Improvviso il risveglio di una memoria formicolante di ombre: immagini di un altro popolo, gli ebrei, esuli che camminano nel deserto in senso contrario anche loro braccati dalla vendetta del faraone. Con sorpresa mi sembrano fiaccole di una epopea lontana, tradita, epigrafi su un destino scomparso. Anche gli ebrei hanno vissuto l’esodo, l’esilio: trascendendo la loro solitudine come una prova, una promessa di comunione. Possono guardare senza rimorso questa fuga da Gaza?