
Proust era un No Vax? Cento anni dopo, un medico svela i misteri della sua morte
18 Novembre 2022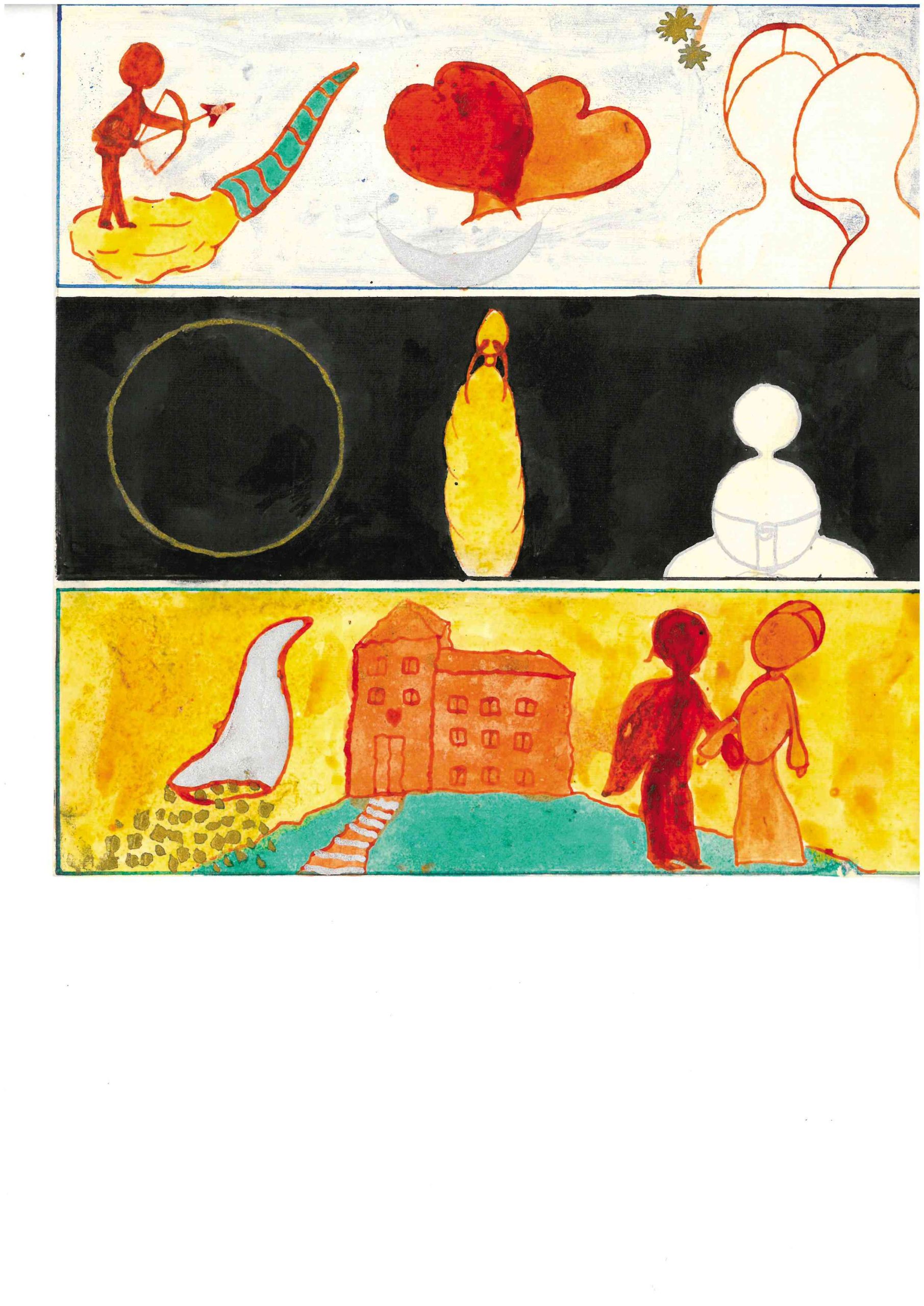
Inafferrabile Bobi Bazlen
18 Novembre 2022Il 21 novembre del 1922, nella chiesa di Saint-Pierre-de-Chaillot a Parigi, tre giorni dopo la sua morte si tennero i funerali di Marcel Proust. Suonavano le note della Pavane pour une infante défunte di Ravel. La bara era accompagnata da una scorta militare, poiché Proust era da due anni cavaliere della Légion D’Honneur. Il corteo funebre aveva attraversato la città intera, passando per gli Champs-Élysées fino al cimitero di Père-Lachaise, dove ora riposa non lontano da Chopin, Balzac, Bizet, Camus e Jim Morrison.
La notizia della morte rimbalzò sui giornali d’Europa. In Inghilterra, il necrologio del Guardian, redatto dal corrispondente da Parigi, inizia col ringiovanirlo togliendogli un anno: «aveva cinquant’anni». Il pezzo parla della sua salute cagionevole fin dall’infanzia, dei modi strambi, della carnagione pallida, «con occhi scuri pieni di fuoco», ma nel complesso, un tipo basso e fragile. Conduceva una vita da eremita, si dice, aperta solo a pochi contatti privilegiati, e gli incontri avvenivano «tra il costoso mobilio» della sua abitazione.
SI PARLA del rivestimento in sughero delle pareti ideato per tenere lontano il rumorio cittadino, e della reputazione di scrittore destinato a una «minoranza selezionata» di lettori: il suo stile «difficile e oscuro, le sue intricate e squisitamente raffinate meditazioni e analisi mai sarebbero potute piacere ai lettori comuni». Nonostante questo, l’articolista si dice certo del fatto che «tra tutti gli idoli e i maestri della attuale letteratura francese, è lui quello in grado probabilmente di guadagnarsi un posto che il tempo non potrà portargli via».
Al funerale, oltre ad ambasciatori e a membri del Jockey-Club de Paris, parteciparono gran parte di quelli che erano stati gli ospiti di un evento occorso qualche mese prima, all’Hotel Majestic. In occasione della prima a teatro del Renard di Stravinskij allestita dai Balletti russi di Djagilev, i coniugi Schiff avevano organizzato quella che nei loro auspici doveva essere la cena del secolo. Tra i tanti ospiti d’onore Proust, Stravinskij, Picasso, e Joyce; assieme al critico Clive Bell, all’intero corpo da ballo, e al giovane direttore d’orchestra Ernest Ansermet.
Su quella serata che i coniugi Schiff organizzarono allo scopo principale di far incontrare i due grandi letterati del periodo, Proust e Joyce, si è scritto tanto. Circolano svariati aneddoti a riguardo che riportano versioni differenti, ma che hanno in comune una verità di fondo. Se i presenti si aspettavano fuochi d’artificio verbali, grandi discussioni filosofiche sui massimi sistemi della letteratura, sfide e duelli stilistici, o anche solo un riconoscimento di reciproca stima, si sbagliavano di grosso. Poco o nulla di rilevante sarebbe successo tra i due. Eppure, quel poco ha ancor più importanza di eventuali e improbabili scambi approfonditi tra personaggi diversissimi, per indole, estrazione, abitudini e obiettivi.
In una cosa, però, Proust e Joyce convergevano: l’essere ritardatari. Prima arrivò l’irlandese, a cena finita. In evidente stato di alterazione alcolica, puntò direttamente lo champagne. Si sedette vicino a Schiff e restò in silenzio per un periodo che dovette sembrare eterno. Questo prima di addormentarsi e di iniziare a russare.
ASSAI PIÙ TARDI, tra le due e le tre del mattino, si presentò, elegantemente impellicciato, ma con l’aspetto pallido e malaticcio, Marcel Proust.
Ai resoconti esistenti, stilati da testimoni oculari, da conoscenti di testimoni oculari, e da romanzieri di vario tipo, si aggiunge ora un’opera italiana di grande interesse, Il giardino d’acqua, di Andrea Pagani (Ronzani editore, pp. 184, euro 15,00). L’autore ricostruisce in maniera assai godibile la serata e l’incontro attingendo a tante fonti, anzi, unendole tutte, come a dare l’impressione di uno scambio quasi corposo tra Proust e Joyce. Joyce l’avrebbe invece definito «una conversazione consistita principalmente della parola “no”».
Non solo Pagani si affida ai resoconti esistenti ma interpola in maniera assai sapiente riflessioni e meditazioni, talvolta direttamente tratte dalle opere, e in altri casi comunque coerenti con il sentire dei due scrittori: «My God!» pensa Joyce, «ancora questo Monsieur Proust. Ma chi se ne frega del suo libro. Pesante. Elefantiaco». Gli fanno eco i pensieri di Proust, quando Schiff sta per presentargli l’irlandese: «Oh mon Dieu! Non starà parlando, per caso, di quel tipo stralunato, ubriaco fradicio, seduto da solo, là in disparte, che beve champagne?»
Tra le fonti illustri riguardo all’andamento della serata, c’è un altro scrittore italiano d’eccezione, avvicinato dai critici per motivi vari sia a Joyce che a Proust: Italo Svevo. Prima di passare alla sua versione, però, lo scrittore triestino ci tiene a stabilire che tra i due non c’è nessuna analogia, e lui intende «separarli definitivamente». Racconta, avendone certo sentito da Joyce in persona in uno dei loro incontri parigini di metà anni venti, che «nella vita s’incontrarono una sola volta». Ecco quel che accadde secondo lui: «Una notte il Proust, già tanto sofferente, si risolse ad uscire da quella sua casa, dalle finestre ingessate dei Champs-Élysées, probabilmente costrettovi dal bisogno di un’inchiesta per poter finire qualche sua frase o qualche suo inciso su qualche avvenimento reale».
L’IMPULSO che fece uscire Proust di casa fu con tutta probabilità la volontà di confrontarsi con Stravinskij sugli ultimi quartetti di Beethoven, anche se il compositore non gli diede troppa soddisfazione, tagliando corto e dicendogli di detestare il musicista tedesco.
Svevo racconta allora che Proust: «fece la conoscenza del Joyce e, distratto dal proprio bisogno subito gli domandò “Conosce Lei la principessa X?” “No” rispose il Joyce. E il Proust: “Conosce Lei la principessa Y?” “No” rispose il Joyce “né me ne importa affatto”». Comprensibilmente «si separarono e non si rividero più».
È assai probabile che questa versione soffra delle esagerazioni divertite di Joyce stesso, perché sappiamo da più fonti che l’irlandese non si lasciava mai andare a comportamenti tanto scortesi. Ci dice però molto della differenza sociale e di obiettivi anche politici tra i due. Certo, entrambi erano interessati anche ai dettagli più minuti della realtà, ma è un dato di fatto che Joyce, a differenza di Proust, aveva un naturale fastidio per le élites e ne restava sempre distante. Tutto sommato era rimasto, come aveva scritto una infastidita Virginia Woolf tanti anni prima, un «proletario autodidatta».
Se pure la conversazione non si fermò a principi e principesse, sicuramente non toccò mai questioni troppo profonde. Secondo alcuni parlarono della reciproca passione per i tartufi, secondo altri si scambiarono informazioni circa i rispettivi malanni.
Il suo ricordo del francese – e forse è questo il migliore epitaffio – è quanto scrisse nel Finnegans Wake, riconoscendo al collega l’eternità che giustamente gli spetta: «Il prouts che colà inventerà una scrittura è in fine il poeta», ove Prouts (anziché Proust) è un prete irlandese (Father Prout), autore di belle canzoni popolari.





