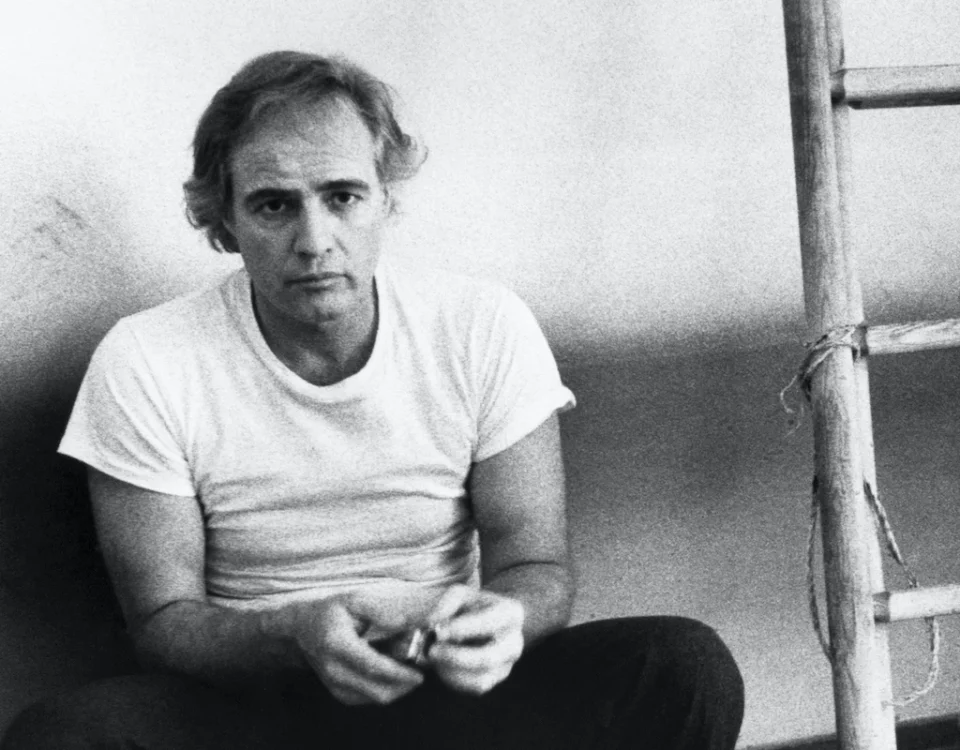Quando Alfred Hitchcock gira Psycho (di nuovo in sala 10-11-12 ottobre) , nel 1960, il cineasta inglese prestato ad Hollywood è all’apogeo della sua celebrità e della sua arte. Proprio per questo, lo studio Paramount cerca di dissuaderlo dall’adattare al grande schermo la cruda storia contenuta nel romanzo di cui Robert Bloch vende i diritti per 9500 dollari, senza sapere che a comprarli è il maestro del brivido.
Per girarlo, Hitchcock rinuncia al proprio salario e accetta una produzione in bianco e nero con un budget da serie b. Ma la Paramount continua a mettergli i bastoni tra le ruote, tanto che alla fine decide di proporlo alla Universal, lo studio che produce la sua celebre serie televisiva Hitchcock presenta.
È difficile retrospettivamente capire quanto quel soggetto fosse scabroso. Dimentichiamo per un momento che Psycho è uno dei film più noti della storia del cinema, che le sue immagini sono diventate parte integrante dell’iconografia novecentesca, che le sue sequenze sono sistematicamente studiate in tutte le scuole di cinema del mondo. Sulla carta, si tratta di una storia sordida. Una segretaria che deruba il proprio padrone per raggiungere l’amante con il quale si apparta occasionalmente in un hotel di terz’ordine. Il padrone di un motel che spia le proprie clienti da un buco. E che le uccide per reprimere i propri istinti sessuali, guidato da un rapporto morboso con la madre morta. François Truffaut lo fa notare ad Hitchcock : «Psycho è un film in cui non c’è nessun personaggio simpatico col quale il pubblico possa veramente identificarsi» – che gli risponde: «Non era necessario. Credo comunque che il pubblico abbia pietà di Janet Leigh al momento della morte».
La morte della protagonista è un’altra eccentricità del film. La celebre scena della doccia arriva dopo mezz’ora e diciotto minuti di una storia che ne dura ancora sessanta e che, amputata inaspettatamente della sua protagonista, deve ricominciare daccapo. È anche l’apice dell’orrore e della violenza. È vero che venti minuti dopo, in una scena quasi altrettanto celebre, un altro protagonista verrà eliminato a colpi di coltello. Ma la morte del detective Arbogast (Martin Balsam) appare sobria se paragonata all’esplosione di sangue che imbratta il bagno dove Janet Leigh viene massacrata.
LA SCENA è seguita da un’altra, meno appariscente ma altrettanto eccezionale, in cui Norman Bates (Anthony Perkins), tornato in sé, cancella ogni traccia del delitto. La meticolosità dell’opera di pulizia, di cui nessun dettaglio ci viene risparmiato, è l’identico speculare della violenza che precede, e al tempo stesso una splendida illustrazione di quel tipo piacere, gentile ma non meno perverso, che si prova quando si mette ordine in un caos.
D’altra parte, sarebbe errato dire che il film ricominci da zero. Tutti gli elementi della prima parte, compresa la protagonista, trovano una sorta di doppia vita nella seconda. Perché, se Psycho è film puntualmente fotografico, costruito inquadratura su inquadratura a partire dagli story board di Saul Bass, nel suo insieme è pensato come un concerto. Hitckcock sa che l’onda di quel primo orrore è talmente forte che la sua eco resta nell’orecchio dello spettatore per tutto il film. Qualche nota basta a rievocarne tutta la potenza.
La scena della doccia è, per il cinema del 1960, un rompicapo. Dodici anni più tardi, nel finale di Frenzy, Hitchcock irriderà l’ormai già antica censura, scoprendo i seni nudi dell’ultima vittima di Rusk. Ma quando Janet Leigh si denuda per la prima volta ed entra nella doccia allestita sul set di Psycho, la sua controfigura Marli Reno ha già posato nei test destinati a determinare con precisione quello che verrà mostrato allo schermo. Più che il coltello, è il montaggio che fende il corpo dell’attrice, spezzettandolo in un mosaico di una cinquantina di inquadrature e poi ricostituendolo grazie ad un gioco di raccordi, e ad un uso insuperato della profondità di campo.
I PRIMI sono dei semplici raccordi di movimento. Ma già quando Janet Leigh apre l’acqua, sollevando il viso verso il pomo che la sovrasta, lo stacco successivo è un taglio sul punto di vista, a suggerire una presenza inquietante che la osserva dall’alto. Il pericolo arriva però da dietro. Una serie di stacchi circolari accompagnano il movimento di lei che, come recita la sceneggiatura, girando su se stessa si trova con le spalle rivolte alla tenda, dalla quale appare la silhouette di una donna. A questo punto, una selva di inquadrature ritma i colpi del coltello fino al momento in cui Marion capitola aggrappandosi alla tenda. Il sangue, che le cola sulle gambe, riempie la vasca, si riversa nel buco dello scarico formando un mulinello che lo stacco successivo riprende invertendone la rotazione sull’asse dell’iride di lei, da cui un carrello all’indietro si allontana lentamente.
L’occhio è il soggetto di Psycho. E Psycho è la sommità d’una ricerca che, film dopo film, ha osato fare dello sguardo umano il proprio oggetto, attraversando quella piccola porta nera dove si riversa la materia di cui ogni spettatore è ghiotto.